di Andrea Galgano 4 luglio 2017
leggi in pdf Le stelle tardive di Arsenij Tarkovskij
« … perché la debolezza è la forza e la forza è niente.
Quando l’uomo nasce è debole e duttile.
Quando muore è forte e rigido
così come l’albero mentre cresce è tenero e flessibile
e quando muore è duro e secco.
Rigidità e forza sono compagne della morte,
debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell’esistenza… »
L’iter poematico di Arsenij Tarkovskij (1907-1989) è una lunga e cadenzata testimonianza di luce smerigliata che ha fioccato i suoi raggi in un secolo di guerra e splendore:«La tempesta qua e là per la Russia / scagliava loro dei bengala. / Ed era soltanto l’inizio. / Irretita in una lite funesta, / quell’estate la sorte cinse / d’una corona di dolore il nostro popolo». .
Si deve alla casa editrice maceratese Giometti & Antonello, la pubblicazione di Stelle tardive. Versi e prosa[1], un’antologia, curata e tradotta da Gario Zappi, dove quella affermata vitalità chiaroscurale è stata segno inscindibile di sgomento e purità, in Achmatova, Gumilëv, Mandel’štam e l’emigrante Chodasevic, e laddove la fiamma abitata dall’intimità scavata della Rus’ dava il suo gemito di sogno, sorgente e disgelo, Tarkovskij si pone come silenzio costretto, non solo dalla censura durata fino agli anni sessanta e l’accusa di misticismo, ma come dimora di misura e dismisura che ha inseguito il diaframma e lo sfarzo luminoso di questo “Pantheon nero” che ha vissuto la sua cifra di inseguimento, accoglienza umbratile e voce unica: «Sono colui che è vissuto nel proprio tempo / senza essere sé. Sono il minore della famiglia / degli uomini e degli uccelli, ho cantato assieme a tutti gli altri, / e non lascerò il banchetto dei viventi: / blasone autentico del loro onore di famiglia, / vocabolario diretto dei loro legami alla radice».
Già nella sua attività di traduttore, Tarkovskij consegna la linea dedicata all’ordine e misurazione, dove «la solitudine, il raccoglimento, la capacità di non farsi annullare dalla pressione degli eventi o delle circostanze anche più negative, risultano una costante della vicenda esistenziale e artistica di Tarkovskij, che infatti scelse di vivere molto ritirato anche negli anni di maggiore riconoscimento pubblico[2]».
Scrive ancora Galaverni:
Poeta non della storia ma della vita, non della politica ma dell’energia, meglio ancora dello spirito delle cose, della natura soprattutto, sembra che Tarkovskij abbia investito ogni sua risorsa psichica e intellettuale per trovare la concentrazione, la sensibilità, l’inclinazione dello sguardo più giuste. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe forse pensare, custodire la propria identità personale ha significato per lui renderla disponibile e accogliente, porsi come un punto di resistenza, trovare la propria voce, è stato tutt’uno con l’accordarsi a un canto, a un movimento, a una danza molto più vasti.[3]
Le stelle ospiti sono abito di fiato, mani e memoria come nodi che stringono la gola. Vi è una sorta di esiliato accesso e sottrazione, in questa ascensione di spirito oltre la materia, in cui il poeta ascolta il respiro delle cose (quanto di questo vivrà nelle opere del figlio Andrej, dalle impronte dialogiche di Stalker e i tocchi di Nostalghia e Sacrificio), il dettaglio del cielo che rabbrividisce e tiene l’acero come una rosa nel bosco di Ignat’evo, dove esso vive una vita partoriente e dove il verso insegue, tallonando, la materia di ciò che vive («Non fare capricci, non minacciare, non toccare, / non turbare la quiete del bosco sul Volga. / Puoi udire il respiro della vecchia vita: / funghi viscidi crescono nell’era bagnata, / i lumaconi li hanno rosi fino al cuore / ma una smania umidiccia ne vellica la pelle»), per restituire «la densità, il radicamento dello spirito nella materia e nel suo continuo divenire, come fossero esse stesse dotate di una loro intrinseca forza d’espansione naturale[4]»:
Per te, che mi sei stata tolta, che di notte / piangevi a causa mia, in un semplice / abito nero, con spalle infantili, / dono migliore, mai più resomi indietro da Dio, / supplico il passato, il presnete, / dormi più profondamente, non singhiozzare nel sonno, / non mi seguire con la coda dell’occhio, / angelo, cerbiatto, falchetto. / Dalle pietre di Sumer, dal deserto / d’Arabia, da quale girone / della memoria, nello sfavillare dell’arroganza / mi stringi forte con un nodo la gola? / Non so dove ora tu regni sovrana, / e non so come rivolgere la supplica, / per perdere ancora il diritto a possedere / il tuo respiro, e le mani, e l’abito.
L’immagine, allora, condotta all’assoluto, restituisce la riarsa oscillazione delle cose, dove l’espressione, la sintassi, i richiami e le intonazioni veterotestamentarie devono evocare il mistero vivente di ciò che è terreno (Alla terra ciò che è terreno), anima che riporta la presenza della realtà a farsi carne, volto caro ed amato, dove l’umano, la natura, la propria stanza interiore sono il segno celato di una grande visione universale.
La viva presenza della realtà è una accesa concrezione di evento e storia, la parola subitanea e profonda richiama i particolari attraverso punti di sguardo che uniscono, come grani, l’oscurità alla luce in un unico battito. È il vento e la sua promessa di vita e morte insieme, irrompe facendo stridere le serrature e sfiora i capelli con le sue mani, così come il cuore non muore quando sembra che dovrebbe (il risuonare dei passi, la casa con l’abbaìno sul giardino, la candela, le campane, l’inzuppata uva selvatica):
La mia anima è triste stanotte. / Amavo l’oscurità sferzata dal vento / e fatta a brandelli, / e le stelle luccicanti a volo / sugli umidi parchi settembrini, / come farfalle dagli occhi ciechi, / e sul voluttuoso fiume zingaresco / il ponte traballante, e la donna con lo scialle / che dalle spalle le calava sull’acqua lenta, / e queste mani, come innanzi una disgrazia. / Mi sembrava che fosse viva, / viva, come un tempo, ma le sue parole / di umide «L» non significavano più / com’è d’uso sulla terra tra i vivi. / Le parole ardevano, quasi fiammelle al vento, e si spegnevano, quasi sulle spalle le fosse calato / il dolore di sempre. / Camminavamo affianco, / ma ormai non toccava più coi piedi / questa terra, amara come l’assenzio, / e non mi pareva più che fosse tra i vivi. / Un tempo aveva avuto un nome. / Il vento settembrino irrompe anche / nella mia stanza: / fa stridere le serrature, / mi sfiora i capelli con le mani (Vento).
È l’epifania dell’incontro a rivelare la socchiusa grazia aperta, la sua smagliante idea di bene che trova nella gemma amorosa l’intima benedizione ultima, la vertigine, la festa, le palpebre sfiorate dall’azzurro. Le città si aprono come incantesimi e la menta si stende sotto i piedi. Questa stagione è rincorsa e seguita dal destino come un pazzo col rasoio in mano:
Quando giunse la notte mi fu fatta / la grazia, le porte dell’iconostasi / furono aperte, e nell’oscurità in cui luceva / e lenta si chinava la nudità / nel destarmi: «Tu sia benedetta», / dissi, conscio di quanto irriverente fosse / la mia benedizione: tu dormivi, / e il lillà si tendeva dal tavolo / a sfiorarti con l’azzurro della galassia le palpebre, / stavano quiete, e la mano era calda. / Nel cristallo pulsavano i fiumi, / fumigavano i monti, rilucevano i mari, / mentre assopita sul trono / tenevi in mano la sfera di cristallo, / e – Dio mio! – tu eri mia. (I primi incontri).
In Tarkovskij, dunque, vivono ferme e decise le alte invocazioni ed evocazioni che prolungano l’intensità di tutte le superfici e profondità:
Sei folle, Isora, folle e malvagia, / a chi hai donato il tuo anello col veleno, / chi hai atteso appiattata dietro la porta della taverna? / Mozart, bevi, non t’affliggere, morte e gloria vanno insieme. / Ah, Isora, i tuoi occhi sono splendidi, / più neri della tua anima, così nera e così trista. / La morte è come la passione, vergognosa. Aspetta, ancora un po’, / fa nulla, ora soffocherà, Isora. / E allora vola, senza sfiorare coi piedi il manto nevoso: / c’è ancora qualcuno da poter rendere sordo / e cieco, ci sono ancora i morsi della fame, / il lampione dell’ospedale e la vecchia infermiera.
È la sua voce messaggera, che spazia nelle due dimensioni, che fa vibrare l’arsi della propria terrena partecipazione al mondo, spingendola fino al linguaggio dell’eterno, alla sua destinazione di orizzonti e macerie umane: «Studio su un libro di pietra il linguaggio dell’eterno, / scivolo tra due macine come un chicco di grano nel rotare delle pietre, / sono per intero già immerso nello spazio a due dimensioni, / il mulino della vita e della morte m’ha spezzato la spina dorsale».
Il gesto dell’eterno imbratta di bellezza ciò che è umano, confondendosi e mischiandosi dove «debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell’esistenza», poiché «Non mi occorrono le date: io ero, e sono, e sarò»:
E lo sognavo, e lo sogno, / e lo sognerò ancora, una volta o l’altra, / e tutto si ripeterà, e tutto si realizzerà, / e sognerete tutto ciò che mi apparve in sogno. / Là, in disparte da noi, in disparte dal mondo / un’onda dietro l’altra si frange sulla riva, / e sull’onda la stella, e l’uomo, e l’uccello, e il reale, e i sogni, e la morte: un’onda dietro l’altra. / Non mi occorrono le date: io ero, e sono, e sarò. / La vita è la meraviglia delle meraviglie, e sulle ginocchia della meraviglia solo, come orfano, pongo me stesso, / solo, fra gli specchi, nella rete dei riflessi / di mari e città risplendenti tra il fumo. / E la madre in lacrime si pone il bimbo sulle ginocchia.
Lo sfarzo della miseria e delle ombre cercano la bellezza e la gloria ultima. Il poeta conosce la il suo varco, il lascito delle tombe squarciate, il respiro (che torna come una infinita spia lessicale) sulle braci ardenti della beatitudine.
L’infinito innalzamento è la riconosciuta sproporzione dell’essere, a fior di labbra[5] egli offre il suo petto ancora debole all’arsura. È la sua anima a essere tela di lino che racchiude la giovinezza allontanata, l’orlo della terra, il sale sul pane, il sogno profetico sul mare d’Azov:
Uscii alla stazioncina. La ghisa riposava / tra dense volute di vapore oleoso. Era / un re assiro dagli svolazzanti riccioli a grappoli. / La steppa s’aprì, e come nell’antro del vento / vi fu risucchiata la mia anima. Alle spalle / non avevo più capanne d’argilla: le torri lunari all’intorno / fluttuavano consolidandosi fin sull’orlo della terra, / la notte svolgeva da un vano all’altro la sua tela spessa, ravvolta strettamente. / La mia giovinezza s’allontanò da me, e un sacco / mi curvò le spalle. Sciolsi le corde, e versai / il sale sul pane, e sfamai la steppa, e con la settima parte di quanto restava saziai il mio corpo paziente. / Dormii, mentre al mio capezzale si raffreddavano / le ceneri dei sovrani e degli schiavi, e ai miei piedi stava / la coppa con le plumbee lacrime d’Azov. / Sognai tutto ciò che mi sarebbe accaduto. / La mattina mi destai, chiamai terra la terra, / e offersi il mio petto ancora debole all’arsura (Presso il mare d’Azov).
L’orientamento della poesia che solca steppe e il calendario dei tempi passati apre il suo petto al vento riarso. È la sorte raminga della sua lucentezza stupefatta e rarefatta, allo stesso tempo, che calpesta la timelea delle sue origini, mentre l’amore rammaglia il mistero terreno benedetto alla luce di stelle tardive.
Non tutto si ricorda o forse tutto si trascina sradicato. E allora sia gloria agli occhi che hanno mostrato le altezze delle stelle nel cielo, alla laringe e alle labbra ora che la voce è roca e tutto ignoto torna a risuonare, reciso nella maschera di cera degli anni remoti: «Forse che di là, giunta la mia ora, / alla luce di stelle tardive, / benedetto il mistero terreno, / potrò tornare al camposanto natio?».
Le fessure di Tarkovskij conoscono il dolore unico e raro dell’essere, l’anima riportata alla creazione, è assetata di armonia, e la sorte umana cerca di scaldarsi come il suolo in mano alla siccità.
Si rinviene in questa stoffa di poesia un dramma compiuto ma non sfaldato, che richiama la sua genesi, il ricordo antico come pianto, il ritorno al grembo materno e la sua verde corona, la dannazione avvinta di ogni limite, come candela consumata che raccoglie la cera al mattino e si riaccende postuma:
L’anima, accesasi in volo, / non fu vista nella stanza bianca / in cui tra dita di streghe misericordiose / si scaldava dolcemente il corpo del bambino. / Alla vigilia sul giardino era caduta la pioggia, / e la terra non s’era ancora asciugata: / a giugno vi furono così tanti lillà / che la lucentezza del mondo si fece turchina, / e a luglio, ad agosto, vi fu / alle tre finestre una luce tale, un colore / tale sgorgò a fontana nel cielo / fino al termine di quell’estate primordiale, / che anche nell’oltretomba la mia sorte / si scalda, come il suolo, al giorno della creazione.
Respirare la terra è percepire la lentezza consumata del vento, il tremolio della morte che si avvicina e il tremore degli aceri che ne simbolizzano la venuta, la neve di marzo riprende la sua antica mendicanza irrequieta a cui basterebbero le cure quotidiane: «Mi bastano le cure quotidiane, / non mi occorre un’altra felicità, – / lo so: anche là, oltre lo steccato, / si conclude l’anno di qualcuno, / lo so: s’erge un nuovo boschetto / là, dove svaniscono i nostri pini. / Sono grevi i calici bianco-neri: / sentono con le brezze il tempo e il turno».
O ancora viversi ombra in un cammino pietroso di attesa e redenzione scura. La casa è senza inquilini, spezzata e smagliante di risvegli e cura vivente, e la neve cade a terra vista da tutti:
Sono un’ombra tra quelle ombre che una volta / bevuta l’acqua terrena non hanno spento la sete / e tornano sul proprio cammino pietroso, / turbando i sogni dei vivi, per bere un po’ d’acqua viva. / Come la prima nave dal grembo dell’oceano, / come la barca sacrificale che esce dal kurgan, / così io salirò sulla scala fino al gradino / ove m’attenderà la tua ombra viva. / – Ma se è una menzogna, / se è una fola, / se non è un volto ma una maschera di gesso / a fissare ognuno di noi da sottoterra
colle dure pietre dei propri occhi illacrimati…
Tarkovskij respira in controluce il fiato-battito di tutte le profezie, il manichino inclinato, (di nuovo) l’anima sorvegliata dai precipizi, la bocca che cerca radici secche, la terra uccisa ma che resiste, colma di luce e d’incanto, come una traccia sottile calpestata che rammemora:
Se ora riuscissi a non svelarmi fino in fondo, / a non dissipare tutto ciò che mi cantò l’uccello, / che cianciò il pieno giorno, che ammiccò la stella, / che fece scintillare l’acqua, che inacidì l’acetosella, / e lasciare per sempre in usufrutto entro me stesso / una dura sferetta nel sangue, colma di luce e d’incanto, / e se non vi fosse più via per il ritorno / riassorbirmi in essa, e non uscirne più, / e: a caso, nell’aorta di uno qualunque.
O ancora attraverso questa lunga e ispessita linea, egli soggiace al pondus vitae, ma ne esce anche lustrandone le sinfonie e gli aliti continui:
La mia voce suona veridica, poiché il tempo non solo faceva scivolare giù i suoi pesi di ghisa, ma ascoltava se stesso: e la sua voce era simile alla voce unica di un’orchestra sinfonica. Era assolutamente plurimo, e tutto ciò che era, era: io, in fondo, non potevo nascere senza che esso lo sapesse, talvolta con un anno di anticipo, tal’altra con un giorno presentendo il futuro, e ciò nondimeno crescevo involontariamente sulle sue palme (p. 191).
La parola umile vissuta, in tutta la sua fierezza vagabonda smoccola candele. È meraviglia, stupore inusitato e abitato dalla coltre divina che viene pedinata. La memoria non raccorda le date (i suoi racconti Costantinopoli sono un alfabeto del ricordo), ma, allo stesso tempo, è precisa come un chiodo di mobile: «[…] Sullo spazio e sul tempo dall’alto / porremo le palme delle mani, / ma capiremo che nella corona del potere / è più preziosa la stella della miseria, / della miseria, dell’inanità, delle preoccupazioni / per il proprio amaro tozzo di pane, / e con le costellazioni aliene faremo / i conti sulla madre terra».
Il suo bene comincia con la prima traccia di alito del mondo fino alle note più alte che celebrano fasti e splendori di un tempo dato, donato dall’alto e trasfigurato da vigilie e attese, per tenere caro il volto non comune e l’ansia conoscitiva che rintraccia ciò che vive, la sua autocoscienza, il suo infinito asterisco.
[1] Tarkovskij A. A., Stelle tardive. Versi e prosa, a cura di Gario Zappi, Giometti & Antonello, Macerata 2017.
[2] Galaverni R., «Di talento, quindi pericoloso», Vita e luce di Arsenij Tarkovskij, in “Corriere della sera – La Lettura”, 7 maggio 2017.
[3] Id., cit.
[4] Id., cit.
[5] Brullo D., Arsenij Tarkovskij, i versi “nocivi” di un poeta troppo scomodo, in “Il Giornale”, 5 maggio 2017.
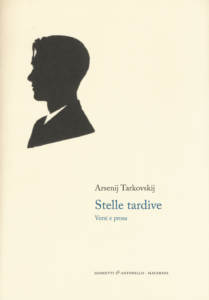 Tarkovskij A. A., Stelle tardive. Versi e prosa, a cura di Gario Zappi, Giometti & Antonello, Macerata 2017, pp. 232, Euro 22.
Tarkovskij A. A., Stelle tardive. Versi e prosa, a cura di Gario Zappi, Giometti & Antonello, Macerata 2017, pp. 232, Euro 22.
Tarkovskij A. A., Stelle tardive. Versi e prosa, a cura di Gario Zappi, Giometti & Antonello, Macerata 2017.
Brullo D., Arsenij Tarkovskij, i versi “nocivi” di un poeta troppo scomodo, in “Il Giornale”, 5 maggio 2017.
Galaverni R., «Di talento, quindi pericoloso», Vita e luce di Arsenij Tarkovskij, in “Corriere della sera – La Lettura”, 7 maggio 2017.
***
19 gennaio 2021
LE STELLE TARDIVE DI ARSENIJ TARKOVSKIJ (2)
Il secondo volume Stelle tardive. Poesie disperse[1], pubblicate da Giometti & Antonello nella forma di libro-album, consegna la memoria e la vocalità della dispersione[2], il tempo della vita prima della vita, la concimata traccia del futuro, la polvere tracimata dell’oblio, e, infine, l’autografia dispari del suo luminoso deposito vivente:
«I grevi granai di mattoni / avevano impregnato il cielo di denso respiro, / sotto la corazza di rame i portoni / non riuscivano a trattenere il grano furioso. / In pesante cascata esso ribolliva / fin sotto il soffitto, sotto le travi, sotto i vani / degli sfiatatoi spalancati, e si gonfiavano / i sacchi gravidi di gloria. / Così respirava la calura. Così viveva il granaio. Così i topi, / come sacchi polverosi, respiravano la calura, / e di grasso genuino si empiva / nel soffocante meriggio l’anno ubertoso. / così si enfiavano le stive delle navi, / e gli scaricatori altercavano a turno / con la folla che era affluita. Così riluceva / il sole cieco nell’acqua oleosa».
O lo iato dello stupore, che alita nell’autunno, è un cielo di ghiaccio scivolato nell’etere dischiuso: «Il tuo stupore, o il tuo / iato di vocali: che ricompensa / per un’esistenza che s’offusca! / E che alitare del giorno leggero / e che alta incomprensione / si cela in te per me. / Non è l’autunno, ma della voce il lieve sgomento, / lo scintillio delle vocali nell’etere dischiuso: come ghiaccio scivolato di mano…».
Vi è in Tarkovskij, uno sbrancamento di ordine, un’amarezza che è precarietà umana ma che è rifulge in un tremore di finestre e mancanze, uno spartito incendiato di ricordi e bellezza, di febbri temporali e cenere adamantina, contrade inabitate, affogate di rugiada, come sogni e respiri di prime stelle, amore nell’aria remota: «E più amaro delle prime stelle è il tuo amore, / ho stradimenticato tutto, amore mio, / prendi, prendi i garofani! / Sì, il mio primo brindisi è per te / tu sei più amara di tutti, amore, tu sei più amara delle stelle, / come l’aria remota…».
O come la giovinezza dello specchio, anima non placata e sospesa in un amore sdoppiato e vissuto, una lontananza di navi, un cuore travagliato, un frammento di oscurità di sogni e nel disgelo delle cose: «E mi pare che la vita mia si sdoppi, / che nel mio specchio io stia insieme a te, / fino a che la mia mano ha pudore di te / e nell’ora cupa va palpando la casa, / la casa, come un volto dagli occhi senz’anima, / il familiare granito, ed entro affranto / là dove non sei, ove nello specchio, come in una fossa / vi è l’insonne sembiante dell’inutile fatica».
Alessandro Zaccuri scrive:
«Se nel primo volume di Stelle tardive trovavano posto alcune delle composizioni maggiori di Tarkovskij […] la selezione attuale dà l’occasione di rileggere in controluce un percorso di estrema consapevolezza interiore. Si pensi a una poesia come Pietro del 1928, nella quale il dialogo con l’ombra dello zar si riverbera nella visione di una Leningrado spettrale («la tua città è deserta, la tua città sta / sul ghiaccio, in stelle di mica che non scintillano») oppure a Frammento del 1947, che rielabora il tema del paesaggio urbano nella prospettiva della memoria domestica («Verrà ricostruita la città, ma non occorrono al cuore / né una nuova casa, né un nuovo giardino, / né nuovi cavalieri sugli sportelli della stufa. / Che racconteranno di loro i nuovi bambini?»). Riaffiorano a più riprese immagini evangeliche, tra cui quella dei colombi «impastati nella creta, come i morti nella fossa», che rimanda al racconto degli Apocrifi».[3]
Nonostante l’oscurità vaga e indomita, la mano di Tarkovskij è una coltre di oltre disteso: «E la città sul ghiaccio sta come su delle stelle, / e l’aria scintilla per una stella greve, / e sull’acqua nera si gela il granito, / e la mezzanotte distende sulla piazza il palmo della sua mano».
Il giorno riarso, il fiele rovente della memoria, la meraviglia della notte e il fuoco intenso, la memoria franta come un sibilo rappresentano l’apice della sua visione, il silenzio e il valore spezzato della dispersione smarrita: «L’estate è caduta come un ago freddo / dalla mano indolenzita del silenzio / e s’è smarrita chissà dove nel buio fitto oltre lo scaffale, / oltre l’intonaco della parete sorcina. / […] Là, nella trepida quiete dell’oltre finestra, / fuori della mia vita e della mia dimora, / vestita di giallo, e d’azzurro, e di rosso, a che le serve / la mia memoria? A che le serve la mia memoria?».
Poi ritorna il suo vocabolario e la sua vocazione, la muta carne degli oggetti, la destinazione del sangue e le radici di Russia, il cuore vocato alla vita, il mistero della nascita e della morte .
«Io sono il ramo più giovane del tronco della Russia, / io sono carne della sua carne, e fino alle mie fronde / giungono le vene, umide, d’acciaio, / di lino, sanguigne, di osso, / dirette prosecuzioni delle radici. / Vi è la sovrana attrazione della vetta, / e perciò sono immortale fin quando / scorre nelle vene – mia sofferenza e mio bene – / delle sorgenti sotterranee l’umidore glaciale, / tutti gli eR e gli eL’ della lingua di Dio. / Io sono vocato alla vita per il sangue di tutte le nascite / e di tutte le morti, io ho vissuto nei tempi / in cui il genio anonimo del popolo / infondeva la vita donando nomi / nella muta carne degli oggetti e degli eventi. / Il suo vocabolario è aperto a pagina intera, / dalle nuvole alle profondità della terra: / insegnare alla cinciallegra la lingua della ragione, / e lasciar cadere un foglio unico nel pozzo, / verde, rosseggiante, arrugginito, d’oro…»
Tarkovskij A., Stelle tardive. Versi e prosa. Vol. 2: Album di immagini inedite e poesie disperse, Giometti & Antonello, Macerata 2020, pp.224, Euro 36.
 [1] Tarkosvkij A., Stelle tardive. Versi e prosa. Vol. 2: Album di immagini inedite e poesie disperse, Giometti & Antonello, Macerata 2020.
[1] Tarkosvkij A., Stelle tardive. Versi e prosa. Vol. 2: Album di immagini inedite e poesie disperse, Giometti & Antonello, Macerata 2020.
[2] “Io sono vocato alla vita”. Arsenij Tarkovskij, il disperso (www.pangea.news/arsenij-tarkovskij-poesie-2/), 6 dicembre 2020.
[3] Zaccuri A., Arsenij Tarkovskij, il padre della poesia, in “Avvenire”, 7 gennaio 2021.

