di Andrea Galgano Prato, 25 aprile 2013
Poesia Contemporanea
short link
pdf 25.04.2013 ROBERT FROST E LA PERDITA

La poesia di Robert Frost (1874-1963) raccoglie a piene mani nella perdita e in essa trova, come scrive Massimo Bacigalupo «il risanamento», il «fare punto momentaneo contro lo smarrimento».
È il cuore, la vetrata centrale della sua poesia. Il rapporto diretto tra poesia e memoria solleva il piano della smaccata atemporalità, del dettato bucolico che non conosce perfezione edenica, ma si riscopre vellutato nella rottura profonda, nella lacerazione e nella follia.
Quando T.S. Eliot lo definì «il più eminente e il più distinto poeta anglo-americano vivente» univa la sedimentazione della cultura anglosassone alla materia rurale e ancestrale della poesia, che unisce il monologo al dialogo, l’inflessione alla creazione fertile dei personaggi.
Nato in California, dove rimase per 11 anni, si trasferì, dopo la morte del padre, con la madre e la sorella nel Massachusetts, dopo essersi iscritto al Dartmouth College e poi successivamente ad Harvard. Non raggiunse mai la regolarità negli studi, lavorando come insegnante, calzolaio e perfino editore dell’opera di D.H. Lawrence.
Il matrimonio con Elinor Miriam White rappresentò la vertigine del suo discorso amoroso, con lei si trasferì definitivamente in Inghilterra nel 1912, dopo gravi dissesti finanziari e psicologici.
All’estero Frost incontrò Pound, che apprezzò e lo aiutò nel pubblicare i suoi testi. La vicinanza e l’influenza di poeti come Edward Thomas, Rupert Brooke o Robert Graves, fu decisiva. Di ritorno negli Stati Uniti, la sua fama divenne conclamata, arrivando a vincere ben quattro premi Pulitzer.
Il New England rappresentò per lui il mistero e la calibrata ancestralità di un movimento espressivo che per guardare il reale, incanala nel discorso, nelle inflessioni colloquiali e nel linguaggio, la tensione metrica che, se per temi si avvicina a Hardy, Browning e Yeats, di contro, sviluppa una peculiare e profonda espressività, unita alla lirica breve, musicale, lontana da ogni unisono vocale, come annunciava egli stesso nel 1913: «Io solo fra gli scrittori inglesi mi sono consciamente proposto di ricavare musica da quello che potrei chiamare il suono del senso».
Quel suono del senso è l’esito di un rinnovamento che inventa una ruralità bucolica e invita chi legge a decifrarne i segreti, le sineddoche, l’ambiguità di un “tranello”: «Bello è il bosco, buio e profondo, / Ma io ho promesse da non tradire, / Miglia da fare prima di dormire, / Miglia da fare prima di dormire».
Il respiro del bosco, ossia di una condizione vivente e vitale, si accompagna al peso della vita e alla tappa ultima del riposo eterno. Esiste sempre un doppio piano nella radice di uno sguardo: da una parte l’elemento naturale che si pone come spartiacque per una condizione successiva, per aprire il tempo poetico alla riflessione del dialogo. La bellezza e la pace hanno sempre una sinistra condizione, in cui l’oscurità dei boschi raccoglie il suo tremore, la sua paura o tragedia, in un originale contrasto. Il suono del senso accompagna il senso del suono, come tensione vitalistica a una suggestione mai dolciastra, a una struttura che pone l’accento sulla condizione umana nelle sue varianti, solo apparentemente, leggere.
Per Frost il senso è un accordo musicale che precede l’esistenza delle stesse parole, in questa vicinanza avviene la vitalità del linguaggio.
In una lezione del 1915, tenuta alla Browne and Nichols Schools afferma: «Quando ascoltate qualcuno che parla, sentite delle parole, certo, ma sentite anche dei toni. Il problema è quello di riportarli, di ri-immaginarli, e di metterli per iscritto […] E il grande problema è questo: come metti su carta questi toni? Come esponi il tono?». E poi successivamente nel 1918 si rapporta a Yeats, intravedendo un possibile accenno di risposta:
«William Butler Yeats dice che tutte le nostre parole, frasi ed espressioni per avere efficacia devono conservare il carattere della lingua parlata. Dobbiamo scendere al linguaggio di ogni giorno, prima di tutto – alla dura parola quotidiana della strada, degli affari, dei commerci, del lavoro estivo – prima di tutto; ma abbiamo anche un obbligo, quello di elevare le parole di ogni giorno, di dare loro un’impronta di metaforicità».
Se Brewer affermava che Frost «appartiene a una tradizione che deriva dall’insoddisfazione con la melodia “tennysoniana”, e si pone con Yeats, Pound ed Eliot tra i grandi rinnovatori della voce parlante nella poesia moderna», è pur vero che l’interesse metafisico di Frost gioca il suo ruolo decisivo in una doppiezza ironica e tragica, in cui la sottigliezza si accompagna all’eloquenza radicata e ordinata.
La più americana delle questioni poetiche, ossia il rapporto tra la poesia e il parlato, che da noi solo nel Novecento ha visto in alcuni autori un campo profondo di indagine, da Montale, a Giudici fino a Sereni, gioca la sua partita su questo rapporto. Persino William Carlos Williams ricostituirà la tessitura musicale della poesia-prosa, in cui suono e significato corrispondono perfettamente, come equilibrio ragionato tra lingua e parlante.
La stessa rusticità di campagna si allontana dal dettato straniante della vita sociale e l’intonazione omogeneizzante del verso frostiano recupera una tendenza e un avvicinamento all’uso metrico virgiliano, come ha esaminato Brodskij «Frost e Virgilio hanno in comune la tendenza a nascondere il vero tema dei loro dialoghi sotto lo splendore opaco e monotono rispettivamente dei pentametri e degli esametri». L’altezza sonora afferma il flusso della rarità del ritmo.
In un saggio del 1931, Educazione attraverso la poesia, Frost afferma:
«L’educazione attraverso la poesia è educazione attraverso la metafora […] La poesia comincia con metafore superficiali, graziose, decorative, e giunge al pensiero più profondo che conosciamo. La poesia offre il solo modo ammissibile di dire una cosa e intenderne un’altra. Chiedono: “Perché non dici quel che pensi?” Non lo facciamo mai, d’accordo, perché siamo tutti troppo poeti. Ci piace parlare in parabole e accenni indiretti, vuoi per diffidenza vuoi per qualche altro istinto […] Scrivere è tutta questione di avere idee. Imparare a scrivere è imparare a avere idee».
Le labbra socchiuse della verità obliqua di Emily Dickinson, trovano in Frost un alleato complice, come comunicazione tra sé e sé in un linguaggio mai soggiogato e netto, mai povero ma profondamente segnico.
L’originaria trasposizione comunicativa destina la indecidibilità verso la doppiezza dell’espressione, verso il gioco continuativo e arduo dell’esperienza poetica. È la sua forza, il suo non celebrato specchio: «The land was ours before we were the land’s».
Scrive acutamente Massimo Bacigalupo che:
«Frost vive ben diversamente il mondo o il mondo morale (per lui sono tutt’uno), un mondo che non ha facili soluzioni, in cui le persone offrono le loro versioni parziali senza che ne venga indicata una definitiva. L’universo è caratterizzato dalla problematicità, dall’indecidibilità, non in maniera amletica e capziosa, ma a livello immediato di percezione. La moralità in Frost è sensazione, per parafrasare la lode che di John donne fece Eliot: è poesia. L’idillio coi boschi non produce certezze o consolazione, ma rimanda sempre al principio della verità assente».
Il bagliore del concetto e della figura, che egli racimola dall’esperienza elisabettiana di Shakespeare e dal concettismo del Seicento, trova uno stridore tra chi abita i campi e la joi de vivre, tra il contrasto silente tra bianco e chiaro, intento e forma e disegno e assenza.
L’isolamento, l’estinzione e i limiti umani insuperabili, messi in evidenza da Randall Jarrell non chiudono la semplificazione ironica e vertiginosa della sua scrittura, ma aprono a una questione insoluta.
La natura del New England porge il suo barbaglio di comunione con la condizione umana. Un muro con il filo spinato occlude la vista di due persone, dall’altra parte ci sono una cerva e un cervo, da questa, due individui guidati da amore e dimenticanza: «Quasi la terra per un imprevisto favore / Li avesse assicurati che ad essi ricambiava / il loro amore».
L’evento che tocca le due persone annota e glossa la loro affezione, porgendo la specularità di un amore ricambiato tra il loro essere e la terra che guardano.
In Frost non esiste il bozzetto melodrammatico o l’edenica percezione di uno spazio, nonostante la vicinanza con Wordsworth e con la tradizione classica, ma il limite umano rivela la sua intensa precarietà, come ad esempio il vaneggiamento di alcuni personaggi, la scoperta di un adulterio, la lunga incertezza mentale.
La sua pantomima lirica acquista la dimensione del dramma, in cui la fattoria afferma il suo centro propulsivo e fragrante del mondo.
Il mondo di Frost concede inenarrabili effetti di quinta, in cui l’umano abita frequentemente e assiduamente l’angolo convesso di un trapasso, come da una landa felice al nido delle api nelel pareti, come dal dramma domestico alla teatralità dell’idillio (come accade in All revelation), per «destarsi all’esperienza, raccogliere i semi gettati prendendo in mano ogni tondo frutto, assopirsi stanchi e soddisfatti prima ancora di aver spogliato tutto il frutteto».
La conoscenza della notte è un viaggio inesauribile nella perdita, nel sonno, nella distanza cinica e virulenta, con una capacità ironica e spregiudicata che non si nutre di ansia o di inquietudine soffusa e solo nell’agone sconvolge la «satisfaction of superior speech», per convogliare in un terrore ironico di molte voci: dalla metafisico-ironica alla drammatico-teatrale, fino alla satirico-discorsiva, che meditano sulla realtà fattuale, soggettiva e poi universale, ordinata e coordinata in solchi, come testimonia Mietitura:
«Non si sentiva oltre al bosco altro suono che uno, / la mia lunga falce che frusciava al suolo. / Che cosa sussurrava? Non lo sapevo io stesso; / era forse qualcosa sul calore del sole, / qualcosa, forse, sull’assenza di suono – / Per questo sussurrava e non parlava. Non era sogno del dono d’ore vuote, / o facile oro profuso da fata o da elfo: / qualunque cosa in più della verità sarebbe apparsa / debole al fermo amore che ordinò il prato in solchi, / non senza delicate lanceole di fiori / (orchidee pallide), e un fulgido verde serpente fugò. / Il fatto è il sogno più dolce che la fatica conosca. / La mia lunga falce frusciava, lasciava il fieno ammucchiarsi».
Il «New York Times» nel dedicare a Frost un editoriale in occasione del suo ottantesimo compleanno mise in rilievo la sua intensità peculiarmente americana:
«Poeta intensamente americano, Frost ha toccato quegli aspetti della vita degli Stati Uniti che, pur dopo un secolo di sviluppo urbanistico, ancora costituiscono il nostro comune substrato. Il nostro concetto delle relazioni tra gli uomini, il nostro modo di intendere il lato tragico dell’esistenza e la nostra nozione della speranza restano intimamente legati alle case coloniche ed ai campi appena arati. Frost scrive su un mondo vero di gente vera, riuscendo ad introdurre in esso il lettore che ne ricava il senso di una viva esperienza e momenti di autentica rivelazione».
Il lavoro del poeta abbraccia l’infrangersi del tempo, il suo smarrimento e nascondimento, il ritrovamento di luce, come l’abbandono di un tratturo e il ritrovamento di un calice nascosto e originario in Directive, in essi trova luce e sospetto di ombra.
Frost R., Conoscenza della notte e altre poesie, a cura di Massimo Bacigalupo, traduzione di Giovanni Giudici, Mondadori, Milano 1999.
Brodsky J., On Grief and Reason, Farrar Straus & Giroux, New York 1995.
Brower R.A., The poetry of Robert Frost: constellations of intention, Oxford University Press, Oxford 1963.
Gardini N., Com’è fatta una poesia, Sironi, Milano 2007.
Jarrell R., Poetry and the Age, Knopf, New York 1953.
Penn Warren R., The themes of Robert Frost, University of Michigan 1947.
© articolo stampato da Polo Psicodinamiche S.r.l. P. IVA 05226740487 Tutti i diritti sono riservati. Editing MusaMuta®
www.polopsicodinamiche.com http://polimniaprofessioni.com
Andrea Galgano.25-04-2013 Robert Frost e la perdita
di Andrea Galgano Prato, 18 aprile 2013
Poesia Contemporenea
short link
pdf: IL LINGUAGGIO POETICO DI PAUL KLEE
 Il gesto poetico di Paul Klee (1879-1940) persegue il segreto e l’attrazione della genesi, la coltivazione di una ricerca, mai marginale, che non tocca il movimento di una glossa all’opera figurativa, ma sostanzia la percezione linguistica in una accezione significativa e densa, in un tratto omologo all’espressione artistica.
Il gesto poetico di Paul Klee (1879-1940) persegue il segreto e l’attrazione della genesi, la coltivazione di una ricerca, mai marginale, che non tocca il movimento di una glossa all’opera figurativa, ma sostanzia la percezione linguistica in una accezione significativa e densa, in un tratto omologo all’espressione artistica.
Se nei suoi Diari lo scenario, il divenire e il formarsi della creazione raggiungono l’acme di una continua tensione, i suoi testi poetici non affermano una subordinazione all’atto artistico, ma raccolgono il fecondo rapporto tra l’artista e la creazione, tra la tensione cosmica e la sigla strutturale dell’umano:
«Sguardo retrospettivo. Mi sono posto dinanzi a me stesso, a scrutarmi. Ho detto addio alla musica, alla letteratura. Ho desistito dall’aspirare ad una raffinata esperienza sessuale, rinunciando a quella tale avventura. Anche alle arti figurative penso appena, devo dedicarmi prima a sviluppare la mia personalità. In questo devo essere conseguente e non cedere alle sollecitazioni. Sono certo che solo così riuscirò a trovare poi la giusta espressione nell’arte»
o ancora
«L’arte è una similitudine della creazione. Essa è sempre un esempio, come il terrestre è un esempio cosmico. La liberazione degli elementi, il loro raggruppamento in sottoclassi composte, lo smembramento e la ricomposizione in un tutto da più parti contemporaneamente, la polifonia figurativa, il raggiungimento della quiete mediante la compensazione dei movimenti: sono tutti alti problemi formali, fondamentali per la conoscenza della forma, ma non ancora arte della cerchia superna. Nella cerchia superna, dietro la pluralità delle interpretazioni possibili, resta pur sempre un ultimo segreto – e la luce dell’intelletto miseramente impallidisce».
Dunque, se in questo libro la sua attenzione si rivolge ai meccanismi precipui di indagine, nella sua poesia sembrano assentarsi le cromature, discostandosi da altri poeti espressionisti, come Georg Trakl, ad esempio, in cui la forte pregnanza cromatica ha densità metaforica ed esaurisce il momento della scrittura.
Scrive Giorgio Manacorda, a cui si deve l’edizione dell’opera poetica di Klee: «Nei versi di Klee non si incontrano colori, non affiora una visione cromatica della realtà. I versi di Klee non descrivono il fantasma colorato del mondo, così come non lo descrivono i suoi quadri. […] Il colore è intuito dal lettore come qualità non nominata di una funzione. In questi lessemi («essere incandescente», «incandescenza», «bruciare», «sangue», ecc.) la valenza semantica prevale sul momento dell’implicito e presente valore cromatico».
Tale valenza si contrappone all’impressione, abbracciando la vertigine di un lessico mitico e simbolico. Il rapporto tra i segni linguistici e la densità espressiva carpisce la forte corposità di metafora e connette la sofferenza dell’esistere alla sensazione panica, al turbamento, all’abrasione, specie quando egli scrive: «Io somiglio al dirupo / dove la resina cuoce nel sole, / dove i fiori scottano», oppure, «Mi rifugiai nei campi assolati abbandonato / al rovente declivio».
Il vocabolario delle immagini, che egli sviluppa, si avvale del pittogramma che si trasforma in icona, ridestando una stretta vicinanza tra la decorazione del passaggio interiore con la simbolizzazione dell’atto figurativo.
Il testo visivo di Klee sottende a una orizzontalità pronunciata e invoca una lettura intrinsecamente temporale, in cui l’enfasi, il volume e il ritmo conferiscono un netto e inequivocabile parallelo visivo.
La metafora incendiaria raccoglie la solitudine nei confronti degli elementi della natura, cambia prospettiva di paesaggio, come un’esclusione sproporzionata e tripudio d’assedio, finestra verbale e visuale: «Come davanti alla tempesta / fuggono gli uomini … / Io sono il timoniere e la mia nave / forte mi porta alla meta» oppure «Io sono cresciuto solo su una landa / (…) / tempeste andavano e venivano, / avevano spazzato via ogni debole cosa. / (…) Il mio riparo sia intanto solamente il pensiero».
Il momento prometeico di Klee però afferma, rispetto allo Sturm und Drang, a cui potrebbe rimandare, un’apertura alla realtà, come centro di amore e orrore, scultura di frammenti, grido di sole: «Tu sei grande, è grande / la tua opera. Ma / solo grande all’inizio / incompiuta. / Un frammento. // Compila! / Allora griderò l’evviva!».
La sua vertigine tra uomo-artista e divinità raccoglie un confronto solitario, insegue un discorso sul reale che non ha l’enfasi estatica ma «il problema del rapporto con dio è il problema del rapporto (gnoseologico) con il meccanismo che muove l’universo. Dalla dialettica o forse, meglio, dalla contrapposizione tra particolare e universale non nasce nessun misticismo». (Giorgio Manacorda)
La relazione dinamica tra la natura e la metafora è biunivoca e diverge nella sottigliezza di una struttura semantica che nega quest’ultima, per raggiungere la conoscenza dei meccanismi cosmici.
La misura con il dio-cosmo non annulla distanze, ma provoca la sbavatura della sofferenza oltre il margine umano. L’uomo-artista riesce, attraverso la profusione creativa, ad abbracciare e raggiungere l’ordine cosmico. Il risultato è un vortice e una vertigine metafisici: «Pensa di essere morto / lontano e dopo molti anni / ti viene concesso un solo sguardo / verso la Terra. // Vedrai un lampione e un cane / vecchio con la zampa alzata. / Singhiozzerai dalla commozione».
La distanza è una visione che non solo partecipa, ma “vede” il suo processo creativo, attraverso lo svolgimento di una istanza umana sofferta, dura e lenta: «La mia testa brucia da saltare / / Uno dei mondi / che nasconde / deve nascere // Ma prima di creare / devo soffrire».
Il parto creativo avvicina l’anima alla genesi femminile. La donna di Klee ha il nome annunciante di un infinito silente e artefice, plasmatrice e innovatrice della fecondità ideale, come il verde della vita e dell’amore verso Evelina, gioia e aggettivo di una fertile serenità:
«Eveline è un sogno verde tra gli alberi, il / sogno di un bambino nudo nella campagna. / Me ne andai fra gli uomini per non lasciarli più / e fu impossibile essere così felice. / Liberato dal potere di troppo noti dolori / mi rifugiai nei campi assolati abbandonato / al rovente declivio. E ritrovai Eveline, donna / ma non invecchiata. Solo spossata dall’estate. / adesso lo so cosa volevo quando cantavo. / siate teneri con i miei doni» o ancora «Appoggiati a me / e seguimi se / si apre la terra / chiudi gli occhi. // Fidati del mio passo e del mio / freddo alto spirito. / Così come Dio / saremo in due».
Il chiaroscuro della penombra, del contrasto, di un rinvio di buio alla luce condensano il paesaggio interiore. Laddove egli dichiara di lavorare «sempre in rapporto alle più inconsce dimensioni del quadro», la sua tendenza pittorica e poetica abbraccia l’immaterialità, la astratta precisione e l’astrazione mitica, archetipica e autonoma, come scrive Clement Greenberg: «In Klee il disegno è, per così dire, temporale, o musicale».
Il poeta che disegna le sue partiture di profili o segni astratti, figure e confessioni precarie afferma la sua linea temporale-musicale, come conferma ancora Greenberg: «La linea di Klee indica, conduce, allaccia, congiunge. L’unità si attua per mezzo di relazioni e di armonie che giocano attraverso aree neutre la cui presenza è più una presunzione che un fatto».
Il verso si ricollega proprio ai segni che determinano l’arte, al mistero dei suoni, vicini più a sostantivi che ad aggettivi, indicati dal tocco verbale per «dare ordine al movimento», per offrire consistenza al valore ritmico della lingua.
Ed ecco che il colore, nelle poesie in controluce o in chiaroscuro, diventa gesto che si azzera, vive di assenza, annullato e ridotto a luce, ombra, bivio di buio: «E tuttavia questo genere di colore, nelle mani di Klee, raggiunge una particolare specie di profondità. Non una profondità nella quale gli oggetti rappresentati sono probabili, ma qualcosa di soffuso, respiri di colore che danno un baluginare distante, ambiguo». (C.Greenberg)
Il segno grafico o verbale, differenziato dal processo metaforico, ha una istanza primitiva, originaria come l’arte del Paleolitico, l’equilibrio e il disequilibrio e la coltre di una percezione.
La parola acquista un potere descrittivo che «ha il compito di completare e precisare le impressioni» e la continua oscillazione tra poesia e arte figurativa e musicala determina il motivo potente e fragile di una vicinanza che possa formalizzare il vissuto e il mistero indicibile: «In fondo essere poeta non dovrebbe ostacolare l’arte figurativa. E se dovessi decidermi per la poesia, Dio sa cosa altro vorrei fare».
La profonda parentela tra la pagina dipinta e quella scritta non contiene solo la fissazione di uno spazio, ma la stessa sospensione dell’oggetto determina la perdita dello spessore esistenziale.
Quando Klee si muove dal modello all’archetipo rintraccia una linea articolata ed elementare, rende appieno l’univocità del segno come affermazione piena, come sonda di un rapporto complementare di ordine e caos: «L’arte è una similitudine della creazione. Essa è sempre un esempio, come il terrestre è un esempio cosmico». L’estrema iconizzazione del testo poetico realizza mimesi e replicabilità, promuove un codice speculare di rovesciamento e ripetizione per leggere il caos e ristabilire l’ordine che non muta.
Il cardine sistematico del testo rispecchia la scacchiera cromatica della figurazione e della costellazione e visualizzazione di altri significanti. Esiste, pertanto una variante codica tale per cui sia i testi e sia gli ordini vengono presi come varianti di un ordine invariante, come annota Giorgio Manacorda: «L’operazione di Klee tocca un tale grado di astrazione e di formalizzazione da presupporre un allontanamento definitivo dall’ordine dei referenti extra-testuali, in direzione (viceversa) della fondazione di strutture archetipiche che poi vengano costantemente «replicate» dai testi e «iconizzate» in essi».
Roman Jakobson in un interessante testo che indaga la produzione poetica di Holderlin, Brecht e Klee: «Una sorprendente unione di trasparenza radiosa e di magistrale semplicità con multiformi indicazioni permette, al Klee pittore e poeta, di dispiegare un’armonica combinazione di molteplici procedimenti sia sulla superficie di una tela sia nelle brevi note di un diario».
L’acuta sensibilità, che unisce la profondità chiaroscurale ella miniatura verbale e il concetto grammaticale alla geometria della visione, permette l’organizzazione del movimento creativo in relazioni logiche che costituiscono il senso profondo e complesso di visibile e in-visibile, di domanda ed enigma: «Nel mondo terreno non mi si può afferrare perché io abito altrettanto bene tra i morti come i non nati. Più vicino del consueto al cuore della creazione ancora troppo poco vicino».
La fine ha trovato l’inizio.
KLEE P., Poesie, a cura di Giorgio Manacorda, Guanda, Parma 1995.
ID., Confessione creatrice e altri scritti, Abscondita, Milano 2004.
ID., Diari 1898-1918. La vita, la pittura, l’amore: un maestro del Novecento si racconta, Net, Milano 2004.
AICHELE PORTER H., Paul Klee Poet/Painter, Boydell & Brewer Ltd., Woodbridge 2006
GREENBERG C., Saggio su Klee, Il Saggiatore, Milano 1960.
JAKOBSON R., Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano 2002.
WyMAN S., The Poem in the Painting: Roman Jakobson and the Pictorial Language of Paul Klee, Word & Image: A journal of Verbal / Visual Enquiry, Routledge 2004.
di Irene Battaglini
L’immaginale Prato, 16 aprile 2013
ALFRED KUBIN pdf
short link
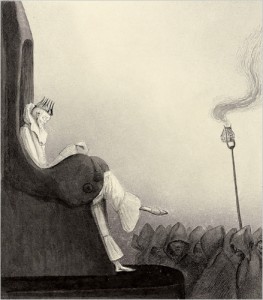 La vera funzione dell’Arte è rivelare la bellezza nascosta, l’impronta divina che è in tutte le cose.
La vera funzione dell’Arte è rivelare la bellezza nascosta, l’impronta divina che è in tutte le cose.
Roberto Assagioli
Alfred Kubin,The last king, 1902
Alfred Kubin è assai vicino al segreto della materia oscura.
Conosce il linguaggio arcaico dei sogni in bianco e nero, sfolgorante tripudio di colori indicibili all’occhio umano, colori animali, viaggi – fuoco alla scoperta di forme di vita aliene perché non ancora note, con cui stringersi negli appartati silenzi di una giungla aperta solo all’inconscio e al sogno.
Popolazioni di piccoli esseri con zampe e piccoli occhi sanguinari, di creature o-scene, prive di pudore e di ritegno, inghiottite dallo stomaco eterno del tempo arcaico.
Un tempo senza meridiane, demarcato dalle sfumature rese con la violenza strabiliante dello stilo che incide la pietra-carta. Non privo di effetti destruenti su colui che guarda, salvato di quando in quando da figure più amabili e mai dolci, mai tenere. Ma dotate di una qualche ispirazione simpatetica. Figure quasi vergini che deflorano la pupilla, ignare della propria immane forza ctonia. Una bella dormiente è di fatto cadaverica, un caro animale domestico è in realtà l’investigatore pubblico di un devastante tradimento affettivo.
In Alfred Kubin (1877-1959, austriaco di origine ceca) la privatezza del sogno e la vergogna dell’istinto manifesto costituiscono la coppia protagonista di un duplice matrimonio di opposti. Si tratta di vecchi amanti clandestini, di violacciocche, rose e fragole passate, che un tempo furono turgide e splendenti. Il tempo ha distrutto quelle irrorate terre di passione e ha prosciugato tutto, desertificato. Nuove forme di vita hanno popolato quel campo desolato, cittadini nuovi di un cimitero di veli di spose e di giovani martiri in abito da cerimonia. Il funerale è stato officiato e nelle camere scurite dal freddo le pareti divengono luogo di immaginazione perversa.
L’impianto accusatorio della linguistica di Kubin è una sorta di emisfero monco di un mondo che necessita di comprensione e di attesa di una risurrezione. È un universo onirico psicoide, a base di strampalate occasioni di tessitura di storie e di incrocio di segni.
I tratti del disegno e delle incisioni sono sempre trasversali, sottili, chiusi. La definizione, tuttavia, non è mai fumettistica e il tratto grafico tradisce un amore pittorico, sfocia in una grafologia iridata su un fondale opacizzato, è equidistanza dal caos eppure è sempre commistione nel magma da cui sembra emergere l’immagine principale.
Una criminologia immaginale, quella di Alfred Kubin. Che rievoca Lovecraft, e Edgar Allan Poe, di cui fu illustratore in oltre settanta opere.
Gli uomini di molti disegni sono spesso ipocondriaci, malaticci, preda di donne-licantropo, attentati da strategie di autoannientamento, vittime consapevoli e un po’ masochiste di uno schema sovrabbondante e conosciuto.
La copiosa produzione di Alfred Kubin è stata da sempre teatro di riflessioni di ordine psicoanalitico, e ci coinvolge anche come studiosi di psicologia dell’arte per via dell’effetto scenico dell’orrore, che ha una sua ragione di essere anche nell’estetica stessa, se si tiene conto della suggestione che riceviamo in relazione alla forma e alla tessitura di ogni singolo disegno. Simona Argentieri, in «Alfred Kubin: un sognatore a vita» (nel saggio La lente di Freud. Una galleria dell’inconscio, a cura di Giorgio Bedoni), articola la riflessione a proposito del rapporto tra psicologia e arte in Kubin:
«[…] sarebbe assurdo precludersi l’esplorazione dei possibili nessi tra parole e immagini, tra opera e vita quando Kubin stesso ne fa un elemento costante della sua poetica, intrecciando continuamente il percorso creativo con l’autobiografia. Direi anzi che un elemento particolarmente interessante è proprio la meticolosità con la quale egli costruisce la sua teoria su se stesso: l’autodiagnosi di patogenesi traumatica dei suoi tormenti, corredata dalla certificazione degli scritti e dalla preziosa esibizione sintomatica dei disegni. Anche la cura, d’altronde, ha tale qualità autarchica e autoreferente: l’isolamento di dieci giorni in corrispondenza di una crisi, la parentesi buddhista, la scrittura del romanzo L’altra parte che – a suo dire – avrebbe composto di getto in sole dodici settimane come rimedio al dolore della morte del padre.
Come è suo diritto, egli talvolta mente sulla stesura dei resoconti […], tuttavia è vero – come dice Erwin Mitsch (1988) – che su questa base emotiva si fondano il fascino e la forza soffocante che emanano dalla sua opera, che si eleva molto al di sopra della pittura concettuale e allegorizzante dei suoi contemporanei.
Insomma, c’è del metodo, sia pure ingenuo, nella sua follia; e c’è della teoria, sia pure convenzionale, nella sua sommessa infelicità e nella sua fedeltà ad un processo creativo fatto di andirivieni tra disegno e scrittura,che intreccia l’invenzione, il “gioco crepuscolare della fantasia”, le reminiscenze infantili con angosce esistenziali nutrite dalle letture di filosofi quali Nietzsche e Schopenhauer, di scrittori come Poe e Hoffmann, di lezioni di artisti come Klinger, Munch, Redon, Ensor, Goya, Rops… Sappiamo anche che teneva sulla scrivania il famoso libro di Hans Prinzhorn, che era andato a visitare la sua famosa collezione di artisti folli della Clinica Psichiatrica di Heidelberg, con i quali dichiarava una dolente fratellanza umana ed estetica. (*) Così procedeva con immagini e parole alla costruzione dell’immagine di sé, adattando eventualmente la biografia all’arte, che – a suo avviso – è la “conseguenza della vita”. (*) In un articolo pubblicato nel 1922 su “Kunstblatt” ne esalta “i miracoli dello spirito dell’artista che emergono dagli abissi reconditi e imponderabili”».
Nei suoi lavori, quindi, l’urgenza abreattiva del trauma e lo spasmo creativo dello «spirito dell’artista» si accordano in una ricerca violenta di armonia, con l’esito di rovesciare i codici della psicopatologia, che è fondamentalista circa l’identità tra psicosi e assenza di consapevolezza.
I temi della fine del mondo, dell’incubo, della coazione a ripetere, dell’accesso al simbolico della morte in ogni sua declinazione, sono stati ampiamente trattati dai critici e dagli storici dell’arte, che non hanno mancato di esaurire in giudizi talora molto duri la sua talentuosità, innegabilmente mescolata con la mostruosità. Ebbe in vita numerosi riconoscimenti, un’esistenza piena in un clima di grandi eventi culturali, ma anche storici e politici. Fu tutt’altro che estraneo a questa realtà, conobbe e strinse amicizia con le maggiori personalità artistiche e letterarie del suo tempo. In un certo senso, l’impressione è che sia stato confinato a sofisticato e misterioso illustratore del terrifico e del luttuoso. Una sorta di sovversivo dell’estetica, il «polo contrario di Klimt […], il lato notturno della Secessione» (K. Schuster, 1981), nell’andirivieni mortifero di Ade e Persefone, sotto l’invariabile dominio di Crono. Espressionista della notte, che si abitua quasi a “rubare” lo spazio creativo, iniziando a disegnare dietro le mappe catastali ereditate dal padre.
In un certo senso, la psicoanalisi è stata ed è una chiave di lettura che, in mano ai profani, gioca a favore della patogenesi dell’arte. E Kubin, anche solo per l’autoritratto in cui si disegna decapitato con la testa in un vassoio (illustrazione a Hugo Schmidt, Demoni e storia notturna, Monaco 1922), è preda ambita per la psicodiagnostica la più liberamente proiettiva. Com’è giusto che sia, se si considera che chi espone le proprie opere non può esimersi dall’essere sottoposto ad ogni forma di valutazione. In qualità di ipotesi inconfutabile, possiamo considerarla un punto di intersezione con altre ipotesi anziché una mappa di orientamento. Uno dei problemi filologici che emerge nello studio di Kubin, è la sua versatilità rispetto al mezzo creativo. Scrittore, pittore, incisore, disegnatore, illustratore, grafico (pensiamo agli inquietanti capilettera), usò la penna, l’acquerello e le chine con generosità di segno. Studiarne le incisioni, significa approcciarsi al suo linguaggio, che è però ampiamente rappresentato nel romanzo L’altra parte e nelle altre produzioni letterarie. Egli illustra il suo stesso libro con l’impeto ribelle dello scrittore ferito dal suo stesso desiderio, ornandolo con lavori scurissimi, intessuti di graffi allucinati, a rappresentare case immerse nella notte deserta, scorci di paesi maledetti, finestre chiuse su muri di silenzio: spazi privi di una dimensione umana, in apparenza. Oppure, in realtà, completamente immersi nella melma che si fa fatica a drenare, che si relega alla notte, all’onirico, al mysterium tremendum.
Difatti fu proprio C. G. Jung (1928) a portare l’attenzione sulla qualificazione archetipica di Kubin, in cui l’abbandono passivo al fantastico e al simbolico assolve una funzione «trascendente, artisticamente valida».
Per la stessa ragione, possiamo articolare la sua collocazione tra i più grandi artisti del suo tempo. Fu cassa di risonanza del decadimento delle cose e del mondo, tanto da meritarsi di essere annoverato tra i “profeti del tramonto” da Vassily Kandinsky: oscuri narratori delle rovine dell’Europa avvolta dalla caligine che segue al crollo degli dei.
In lavori come Bancarotta (1938) o La morte del povero dello stesso anno, sembra assumere su di sé la fortissima responsabilità di un’Austria crocevia di conflitti bellici in un’Europa vessata dalle forze disgreganti. Non si tagliò fuori dal dibattito della sua epoca, anzi ne fu protagonista insieme a tanti nomi illustri, come Mann, Kafka, Jünger, Redon, con cui strinse ampi rapporti epistolari.
Subì l’influenza di maestri come Goya e Bosch, oltre a Max Klinger, che anticiparono quel che i Surrealisti usavano addurre alle fonti inesauribili dell’inconscio.
Alfred Kubin non può essere quindi collocato tra le sponde rovinose di una psicopatologia della scrittura, del segno e del simbolo. I lavori vanno presi tutti insieme e visti come un “arazzo rovesciato”, parafrasando il titolo dell’ultimo lavoro di Andrea Monda e Giovanni Cucci. Il male non può essere spiegato ma al massimo raccontato. E in questo caso disponiamo di un immenso racconto, il romanzo della vita e dell’arte di un uomo che si mette a nudo e ci offre una delle più vaste geografie dell’inconscio, individuale, sociale, collettivo.
Poesia Contemporanea Prato, 12 aprile 2013
short link
pdf OCTAVIO PAZ E IL REGNO PERDUTO
di Andrea Galgano
 Octavio Paz (1914-1998), premio Nobel per la letteratura nel 1990, esprime meglio di ogni altro autore ispanoamericano la capacità di sintesi dello scavo poetico, della esistenza vissuta del testo, di un ermetismo propulsivo e dinamico che unisce linearità e fasto immaginario.
Octavio Paz (1914-1998), premio Nobel per la letteratura nel 1990, esprime meglio di ogni altro autore ispanoamericano la capacità di sintesi dello scavo poetico, della esistenza vissuta del testo, di un ermetismo propulsivo e dinamico che unisce linearità e fasto immaginario.
Nato in una famiglia indiano-ispanica dopo la rivoluzione messicana del 1910 (suo padre fu il rappresentante di Zapata negli Stati Uniti, mentre suo nonno fu uno dei primi intellettuali a favore della causa degli indios), ha respirato da subito, come testimonia la sua prima silloge a 19 anni Luna silvestre, la tensione dilatata di un processo espressivo che raccoglie erotismo, comunione, solitudine, morte, come un quadrilatero che innerva la sua arte e il suo gesto poetico.
A 23 anni aderì alla causa dei repubblicani andando a combattere e rompendo poi con gli stalinisti, definendo in modo indelebile e irreversibile una frattura con i totalitarismi di ogni tipo.
Le sue raccolte successive portano i riflessi della guerra spagnola, ma lasciano intatta la nitida scoperta di una fraternità e di una identità che caratterizzerà la sua produzione successiva, aprendo il suo corso mitico alle esplorazioni del reale e all’appartenenza.
Tutta la sua esistenza è stata un germoglio di feconde amicizie e crinali duraturi: Rafael Alberti, Cesar Vallejo, Pablo Neruda.
Rientrato in Messico nel 1938 fonda la rivista “Taller”, incontra Benjamin Peret, si lega ai surrealisti parigini e poi si sposa con Elena Garro. Su consiglio di Neruda entra in diplomazia (lascerà l’incarico nel 1968 dopo il massacro di Tlatelolco) e nei suoi innumerevoli viaggi (Francia, Svizzera, Giappone, India), scoprì la bellezza del misticismo orientale.
Le raccolte di poesie Versante Est e Libertad bayo palabra si alternano a saggi di politica e critica letteraria, fino a raggiungere con la Pietra del sole del 1957, lungo poema sul Messico, considerato da Julio Coràlez il più bel poema d’amore mai scritto in America Latina, la vertigine dell’inno.
Dopo le prese di posizione contro il castrismo, tentando di perseguire una via più democratica, nel 1976 fonda il mensile di riflessione politica “Vuelta”, iniziando, pertanto, una messa a fuoco di emarginati e esiliati, come più tardi testimonierà il bellissimo Il labirinto della solitudine: «La solitudine è il fondo ultimo della condizione umana. L’uomo è l’unico essere che si sente solo e l’unico che è ricerca d’un altro. (…) L’uomo è nostalgia e ricerca di comunione. Perciò ogni volta che sente se stesso si sente come mancanza d’un altro, come solitudine».
Quando ritirò il Premio Cervantes nel 1982 scrisse:
«la libertà, che comincia per essere l’affermazione della mia singolarità, si risolve nel riconoscimento dell’altro e degli altri: la loro libertà è condizione della mia. Nella sua isola Robinson non è realmente libero; benché egli non subisca una volontà estranea e nessuno lo costringa, la sua libertà si dispiega nel vuoto. La libertà del solitario è simile alla solitudine del despota, colma di spettri. Per realizzarsi, la libertà deve incarnare e mettersi di fronte ad un’altra coscienza e ad un’altra volontà: l’altro è, contemporaneamente, il limite e la fonte della mia libertà».
La poesia di Octavio Paz tende alla sponda infinita degli archetipi, solleva il binario dell’attività poetica verso una orditura di sacralità di immagine:
«L’uomo, persino quello avvilito dal neocapitalismo e dallo pseudo socialismo dei nostri giorni, è un essere meraviglioso perché, a volte, parla. Il linguaggio è il marchio, il segno della sua sostanziale non-responsabilità anziché della sua caduta. Attraverso la parola possiamo accedere al regno perduto e così recuperare gli antichi poteri. Quei poteri non ci appartengono. L’uomo ispirato, colui che davvero parla, non dice nulla di suo; per la sua bocca parla il linguaggio»
o ancora «Non è poeta chi non abbia sentito la tentazione di distruggere il linguaggio o di crearne un altro, chi non abbia provato il fascino della non-significazione e quello non meno terrificante, della significazione indicibile».
La scomparsa del poeta nella sua voce, in quanto voce del linguaggio, acquista una tensione altra, una rivelazione magmatica e fervida.
Il quadro polisemico che emerge dalla sua lettura è il sedimento in cui la nevrosi, presente in Neruda o Vallejo, si affranca in uno spazio mai soddisfatto, in un’indagine di materia e d’istante senza condizionamenti.
Le mitologie messicane si aprono nell’opera circolare di un tempo originario e primordiale, nella Storia, senza la quale il poema resterebbe disincarnato, flesso:
«prima della storia, ma non all’infuori di essa. Prima, in quanto realtà archetipica che è impossibile datare, inizio assoluto, tempo totale e autosufficiente. Dentro la storia – meglio: storia anch’egli – perché vive soltanto incarnato, ri-generandosi, ripetendosi nell’attimo della comunione poetica. Senza la storia – senza gli uomini che sono origine, sostanza e fine della storia – il poema non potrebbe nascere né incarnarsi; e senza il poema non ci sarebbe nemmeno storia, perché non ci sarebbero né origine né inizio».
Lo splendido istante, che germina nella vertigine, ha, nel particolare, l’estasi di un tempo irripetibile, calato in un solco di dimensione storica, laddove un pioppo, una montagna o un fiume partecipano a una immaginifica trasposizione della realtà e della visione d’insieme.
Scrive Franco Mogni: «poesia e poetica di Paz rispondono proprio a una peregrinazione verso le origini, alla ricerca di una cosmogonia (o cosmologia?) personale: lungo il percorso affiorano ciclicamente delle strutture pressoché compiute, dei testi singolari per cadenza e tenuta compositiva che in qualche modo chiudono una fase e ne introducono un’altra».
Se nella sua poesia tutto riconduce alla porta di un avvenimento, il desiderio di ricomporre il contesto lacerato dell’uomo segna definitivamente la traccia di una rigenerazione affascinata, di una puntualità dell’istante e del suo fluire e, infine, della sua pienezza.
La pietra del sole assurge una viva compenetrazione amorosa che unisce tempo rigenerato e illuminazione. La poesia e quindi l’amore, qualora fossero anche balbettii silenziosi, riescono a estinguere e estirpare l’umana materia grezza in una fascinazione preziosa, in una non totalizzante conciliazione di contrari, in quanto «poema della riconciliazione degli opposti, in cui la polarizzazione tra tu ed io, presente e passato, si risolve in una corrispondenza universale che mette in comunicazione piani considerati incompatibili».
L’apertura polisemica del tempo al mondo può aprire costellazioni indicibili oltre «il muro verdigno», in una congiunzione che permette l’irretimento di una statica contemplazione:«Tutti si trasfigurano, volando, / ogni fregio è nuvola, ogni porta / immette al mare, al campo, all’aria, ogni / tavola è in festa; conchiglie serrate / cui il tempo inutilmente stringe assedio/ svaniti il tempo, i muri / spazio, spazio / apri la mano, cogli la ricchezza, / raccogli i frutti, mangia dalla vita».
Il flusso dell’esistenza, la luce delle lampade, l’inabissarsi della luce nei cerchi di basalto, sono i frammenti musaici di una flessione rigenerativa, in cui l’Amore definisce il passaggio verso una temporalità accesa, una voce nascosta, una suggestione esuberante di immagini.
Sembra quasi che nell’esilio dell’abbraccio degli amanti il tempo si fermi, ceda il passo all’immensità di istante, dilati le sue coltri a un incondizionato bagliore sacro:
«Tutto si trasfigura, tutto è sacro, / il centro della terra è in ogni stanza, / sempre è la prima notte, il primo giorno, / il mondo nasce quando due si baciano. / Amare è lotta, quando due si baciano. / Il mondo cambia, i desideri incarnano, / anche il pensiero incarna, / il mondo cambia / se due si guardano e si riconoscono» perché «Perdiamo i nostri nomi e galleggiamo / Alla deriva tra l’azzurro e il verde, / tempo totale dove nulla accade/ se non il suo trascorrere felice».
Una fusione che chiarifica il ritmo creatore dell’universo, che fonde la percezione di odori, suoni, presenze e gaie prefigurazioni.
La donna di Paz è indistinguibile dal paesaggio che abita, riflette la natura che si sparge sui vestiti, come un trionfo ricolmo di risorse, come una docile festa disinibita e sparsa. È la persona a determinare il passaggio dal sesso all’erotismo: «Senza la fede in un’anima immortale inseparabile da un corpo mortale, non avrebbe potuto nascere l’amore unico né la sua conseguenza: la trasformazione dell’oggetto desiderato in soggetto desiderante. L’amore esige come condizione a priori la nozione di persona, e questa, a sua volta, la nozione di un’anima incarnata in un corpo».
Nella totalità concreta dell’essere si realizza il compimento di una unicità senza fine, protesa alla sua duplice fiamma, alla zona magnetica tra coscienza e realtà.
L’edonismo di Octavio Paz riflette un misticismo naturale che, come scrive Guillermo Sucre, «non cerca di raggiungere nessuna trascendenza ma di riscattare il corpo originario del mondo», poiché, come scrive lo stesso Paz, «La vita non comincia senza il sangue / senza la brace del sacrificio».
Quando la stilla dell’esistenza percorre le innervature, gli addensamenti, per toccare persino l’evaporazione, il debito della parola al silenzio esalta
«il senso dell’assenza, dell’incarnazione del vuoto, innervatura di un ritmo che dalla nascita alla caduta e viceversa dice e disdice la manque di un incontro, e non fusione, atto a provocare anziché l’armonia dei contrari, la loro trasformazione in un corpo altro: quello del testo, de foglio bianco (in, nel, verso il blanco-bersaglio) sul quale il testo inesorabilmente cresce».
Cogliendo i segni del tempo, è possibile rintracciare l’esperienza sovrannaturale, come dimensione originale e originaria dell’esistenza, come trasmutazione di sé: «Le pietre sono tempo / Il vento / secoli di vento / Gli alberi sono tempo / gli uomini sono pietre / Il vento / si avvera con gli orecchi».
Si assiste a una ricerca urgente di identità, per una natura perduta. In uno scandaglio pietrificato e vibrante, egli scopre un ponte nuovo, la «fiamma nera» dell’infinito, la vertigine e lo spasmo cosmici.
La sola parola afferma la rivelazione di un regno perduto, quasi adamitico. Il poeta si innerva in questa origine, in questa co-nascenza, come copula che annulla il potere menzognero del sopruso e della sua traiettoria sanguinosa di ogni esilio.
La percezione si trasforma in concepimento, la creazione che subissa la descrizione, come lo specchio segreto di un mondo invisibile aperto sul visibile. Ecco, quindi, che l’immagine assurge a un ruolo fondamentale e decisivo: essere promemoria della realtà materiale, in un termine momentaneo e passeggero della magia dell’istante al vuoto succedaneo: «L’ora mi innalza / fame d’incarnazione patisce il tempo / Oltre me stesso in qualche luogo attendo il mio arrivo»..
Il culmine della liberazione poetica, come l’uccello astro e serpente precolombiano Quetzalcòatl, erompe in una realizzazione altra da sé, in una nudità originaria, in una paternità sofferta e vera, in una lingua madre desiderata, per riappropriarsi e salvaguardare la temperie liberatoria: «Mani e coscienza per cogliere il tempo / sono una storia / una memoria che s’inventa / mai sono solo / parlo sempre con te / parli sempre con me / Cammino nel buio e pianto dei segni».
I segni riallacciabili a Fourier, i romantici tedeschi, come Blake, Novalis e Hölderlin, i barocchi e mistici ispanoamericani, vivono nel fuoco dell’atto creativo, come prominenza salvifica di una dicotomia sofferta e viva: la sonorità del silenzio.
Tra patriottismo e ribellione, attività politica e solitudine artistica, Paz compone il suo ritmo errante, la sua dizione priva di confine, il fulcro dialettico di una «disseminazione germinante» (Franco Mogni) che fonda la fede di un tempo puro, per iniziare un nuovo ciclo, per fondere gli opposti di un flusso misterico, in una corrente alternata. Il ritmo e le immagini rivelano il mondo:«Scorpione che si conficca nel mio petto / sigillo di sangue sui miei anni d’uomo».
Scrive Grace Schulman:
«La poesia di Octavio Paz è una questione urgente perché insiste sulla totalità della vita, l’amore, e le nazioni, una unità che solo l’arte può rivelare. E se io ho sempre saputo che la poesia vive su livelli più profondi dell’essere al mondo, mi comanda la voce di Octavio Paz ad ammettere la giustezza di questa conoscenza. Paz vede il mondo che brucia, e sa con chiarezza visionaria che gli opposti si sono risolti in un luogo al di là di contrari, in un momento di pura visione: in quel luogo, non ci sono frontiere tra uomini e donne, vita e morte. Se la sua poesia incarna il viaggio della mente verso la comprensione, il suo viaggio è il mio viaggio, la sua passione, la mia passione… ».
L’erranza di immagini concepisce lo spirito fuori del dramma della vita, tra lo stupore della quiete e le cicatrici del movimento.
Octavio Paz sa bene che quell’uragano che «s’è piantato in mezzo all’anima» esprime tutta la sua realtà corporea, la sua cadenza rituale e l’ascensione di fuoco acqua, terra e fuoco, uniche espressioni di accesso polimorfo alla parola vivente che riemerge dalla cenere, per scaldare la linfa luminosa dell’essere, in un suono primigenio e in un ragionamento irragionevole: «Vita e morte / Saldano in te, signora della notte, / torre di luce, regina dell’alba, / vergine luna, madre d’acqua madre, / corpo del mondo / cado in me stesso e non tocco il mio fondo, / coglimi dai tuoi occhi, unisci polvere / dispersa e riconcilia le mie ceneri».
Paz O., Vento cardinale e altre poesie, a cura di Franco Mogni, Mondadori, Milano 1998.
Id., La duplice fiamma. Amore ed erotismo, ES, Milano 2006.
Id., Il labirinto della solitudine, Il Saggiatore, Roma 1982.
Addolorato A., La parola danzante. Octavio Paz tra poesia e filosofia, Mimesis, Milano 2000.
Christ R., The Master of Contraries, in «The Nation», 2 agosto 1975.
Gallagher D.P., Octavio Paz, in Modern Latin American Literature, Oxford University Press, Oxford 1973.
Schulman G., Man of two words, in The Hudson review, vol. xxvii, n. 3, Autunno, 1974.
Sucre G., Paz: la vivacidad, la trasparencia, in La máscara, la trasparencia, Monte Avila, Caracas 1975.
Prato, 31 marzo 2013, Santa Pasqua di Irene Battaglini
L’IMMAGINALE
Short link 3. 31 03 2013 LA COLOMBA E L’ALEPH
 «Gli istinti hanno un aspetto dinamico e un aspetto formale. Quest’ultimo si esprime attraverso fantasie che, com’era ben lecito attendersi, è possibile rintracciare, con una sorprendente somiglianza, per così dire in ogni luogo e in ogni tempo. Come gli istinti, anche queste rappresentazioni possiedono un carattere relativamente autonomo; esse sono numinose e perciò si possono ritrovare soprattutto nella sfera delle rappresentazioni numinose, cioè religiose».
«Gli istinti hanno un aspetto dinamico e un aspetto formale. Quest’ultimo si esprime attraverso fantasie che, com’era ben lecito attendersi, è possibile rintracciare, con una sorprendente somiglianza, per così dire in ogni luogo e in ogni tempo. Come gli istinti, anche queste rappresentazioni possiedono un carattere relativamente autonomo; esse sono numinose e perciò si possono ritrovare soprattutto nella sfera delle rappresentazioni numinose, cioè religiose».
«L’ “interpretazione” non si attiene a nessuna teoria, ma segue gli indizi offerti dal sogno, intesi in chiave simbolica. Anche se vengono utilizzati concetti psicologici, come per esempio quello di “Anima”, non si tratta di un presupposto teorico, perché qui “Anima” non è un’idea, bensì un concetto empirico o un nome che designa un determinato gruppo di eventi tipici e osservabili. In una discussione così ampia le interpretazioni sono solo fasi provvisorie e formulazioni sperimentali, che devono però dimostrarsi valide nel loro insieme. Che lo siano, lo rivelerà soltanto il risultato finale, che mostrerà se si è sulla strada giusta oppure no. Un confronto di questo genere è sempre un’avventura creativa, in cui in ogni momento si deve impegnare il meglio di sé. Allora – concedente Deo – può riuscire il magnum opus della trasformazione».
C.G. Jung, La vita simbolica, p. 238. e 252, in Opere, vol. XVIII, Bollati Boringhieri, Torino 1999
La colomba della pace, la colomba blu, la colomba con fiori: esempi di un disegno disarmante e semplice che descrive in pochi gesti l’idea dell’infinito gioco tra messaggio e rappresentazione – tra significato e significante – nella cifra e nella poetica figurativa di Pablo Picasso.
Il rimando al simbolo pasquale di pacificazione e resa, di abbandono all’amore di Dio, di elevazione vittoriosa e di fine del diluvio – di vittoria sulla morte, di ascesa celeste, di fiducia nel piccolo messaggero che è purissimo, angelico e bianco, ma anche trasparente e intelligente, è un rimando immediato alle più apprezzate strutture metaforiche delegate a contenere i simboli della festa di Risurrezione.
Picasso, scaltro mediatore dell’inconscio collettivo del mondo, non esita a farne il vessillo del manifesto per il congresso mondiale di Parigi dei “Fautori della Pace” nel 1949. Ne farà un sigillo edipico, chiamando la figlia Paloma, che nasce nello stesso anno; e ancora la colomba e il piccione costituiranno l’anagramma intimo del rapporto con il padre, con il quale il giovanissimo Pablo Ruiz imparò a disegnare, cominciando proprio da questi piccoli e comunissimi animali.
Il grande storico e psicologo dell’arte Ernest Gombrich (Vienna 1909-Londra 2001), tuttavia, oltrepassa la lettura personalistica e sociologica del disegno della colomba in Picasso. Ne esplora la dimensione rappresentativa in una raccolta di conferenze e conversazioni (A cavallo di un manico di scopa, 1963), in cui volle sottolinearne la bellezza intrisa di libertà di espressione, di leggerezza, di genialità e rapidità. Ne indagò gli elementi psicoanalitici, le rispondenze edipiche.
Una interpretazione che debba rispondere agli insegnamenti metodologici di Gombrich si deve alimentare di una domanda inesauribile, l’unica che resista alla scure giudicante della critica dell’arte, eleggendo a strumento principe del raccolto anamnestico la fenomenologia descrittiva del campo pittorico, per verificare se ci sono i termini per riflettere, per dibattere, in quel processo che passa per la riduzione a uno, che è la costruzione di senso.
La vita simbolica della colomba lascia tracce in Jung, che nello scritto del 1954 “La risurrezione” (op. cit., p. 380), allude all’ascensione in quanto fatto psicologico e metastorico, in forza del quale l’Uomo sperimenta il Sé la cui «esistenza non viene annientata dalla morte: egli continua a vivere in una forma leggermente modificata. A un livello culturale più elevato, egli si avvicina a Dio che muore e che risorge, come Osiride, che diventa la personalità superiore di ogni individuo (come il Cristo giovanneo), cioè il suo τέλειος άνϑρωπος [trad. fonetica: téleios ánthro̱pos, n.d.A.], l’uomo completo (o perfetto), il Sé». (op. cit., p. 382)
La colomba in quanto immagine collettiva, «trascende l’individuo nello spazio e nel tempo, e quindi non è soggetto alla caducità di un corpo […]». (ib.)
L’urgenza quindi di una autorità spirituale restituisce dignità umana solo a patto di legittimare a ciascun uomo una natura divina, poiché «Cristo aveva detto loro: “Dii estis, siete déi” [salmo 82.6, citato in Giovanni 10.34, nota dei curatori delle Opere di C. G. Jung]; e come tali essi erano suoi fratelli, partecipavano della sua stessa natura, e né il potere del Cesare, né la morte fisica poteva più annientarli. Erano “risorti con Cristo”». (op. cit., p. 383)
Ma il punto interrogativo posto da Gombrich, e già sollevato da Jung nell’intervista “Jung e la fede religiosa” (op.cit., p. 391 e segg.) è a priori: perché la colomba? E’ un simbolo efficace?, risponde alle prerogative di un buon simbolo? Non è un animale particolarmente mite come si può credere, né è sufficientemente adeguato ai voli in altissima quota. Eppure il pittore non esita, e con pochissimi gesti, esultanti e quasi infantili, verga la carta senza indugiare sui particolari. Sta in questo, forse, un principio di risposta. La colomba di Picasso è senza ombre, e in questo risponde al dogma della privatio boni: il male è assenza di bene, o meglio è privazione del bene, è “negazione” del bene. Dipingere una colomba realistica, con i suoi volumi e i suoi chiaroscuri, avrebbe voluto dire apprezzarne i parametri estetici e in questo senso obbligare un grande maestro del colore come Picasso ad assimilarne gli aspetti dualistici, i tratti negativi, trascurandone la valenza simbolica diretta. La trasparenza, l’assenza di dettagli, ne fa un elemento che allontana dal pericolo della dualità, per definirne unicamente il valore inconscio universale, gettando un ponte tra l’originale (l’introvabile originale immagine di Dio) e la rappresentazione, direttamente “fruibile”, inequivocabile. Picasso nel disegnare la colomba, mette da parte se stesso, il potere narcisistico della sua geniale cifra figurativa, per mettersi al servizio del simbolo, al servizio del mondo e di quella pacificazione tra i popoli di cui fu sempre sostenitore.
Si tratta quindi di un chiarissimo esperimento di arte concettuale. Al quale ancora qualche pensiero è dovuto. Qualche altra domanda. Perché la colomba? La domanda è incompleta. Perché la colomba che porta un ramo di ulivo nel becco è simbolo di pace? Perché dice qualcosa. Porge una risposta in forma di segno. Recita la liturgia di Santa Romana Chiesa: «scambiatevi un segno di pace». Non dice: siate in pace, vivete in pace, pregate in pace. Dice proprio “un segno”. Un segno non è la sostanza della pace, ma il rimando alla pace. Un segno è qualche cosa di specifico che ci porta dritti nella tana della semantica, nel gioco delle infinite rappresentazioni. UN segno, non IL segno. Un segno come gesto, un segno come un ramoscello: un messaggio. La colomba, dunque, diventa la mano, la nostra, priva di armi e di sorprese, che si porta all’Altro con tutta la sua bella capacità di far volare l’amore, di far circolare la carezza, il perdono. Le ali, la coda della colomba, non sono forse disegnate da Picasso come mani, mani tonde e semplici, mani universali, che possono parlare, che possono lasciare un segno? Scrivere, rendere leggibile, applicare il messaggio in una forma specifica che tenda ad essere parola. Una parola libera, come libero è il segno con cui si esprime. Alla domanda se siamo liberi, la colomba sembra rispondere: si, ma a patto di aver prima ascoltato il mio messaggio, vi sto dicendo che siamo in pace, che sono cessate le ostilità, che possiamo andare oltre gli antichi conflitti. Possiamo esercitare nella pace, il nostro arbitrio espressivo, sviluppare l’arte di rappresentare, di decorare, di dipingere, e dunque di raccontare: libertà di attingere all’antenato primigenio da cui deriva la prima di tutte le lettere, la pittura rupestre dell’animale dotato di corna, elementi cardine del processo di tracciabilità della coniazione.
 D’altra parte, se l’aleph è una testa di bue ribaltata, la colomba in volo altro non è che un aleph rovesciato, portatore di voce e di identità, “che parla”.
D’altra parte, se l’aleph è una testa di bue ribaltata, la colomba in volo altro non è che un aleph rovesciato, portatore di voce e di identità, “che parla”.
Si moltiplicano gli interrogativi, che si alimentano della ricognizione intorno alla struttura formale della colomba picassiana. Il corpicino lieve della colomba ruota intorno a due assi, verticale e orizzontale, che occupano tutto lo spazio rendendolo incredibilmente indefinito. Lo espandono, ben oltre le dimensioni del foglio o del quadro. La linea d’orizzonte, costituita dalla firma, “l’identità”, è l’unico punto di appoggio. Non vi è centro visibile nel disegno, non vi è alcuna intersezione. La differenza con l’aleph è fondamentalmente questa. Il ramoscello-parola-messaggio, non è trasversale e non è perpendicolare. E’ parallelo alla terra, come deve essere ogni cosa affinché possa essere decodificata dallo sguardo, letta. Ogni fogliolina, è un foglio di storie, un ramo di inchiostro, un calligramma. L’occhio si concentra in questo modo sul messaggio, e lascia libero il messaggero. Tuttavia, il messaggero necessita di un centro, di un punto, di un oriente. L’escamotage della croce invisibile, più o meno premeditato, risponde ad una duplice esigenza: da una parte imprimere una forza che sostenga la forma, dall’altra eliminare in funzione della negazione, e non solo, ogni forma di contrapposizione tra opposti. Vale a dire, la figura per essere perfetta, numinosa, deve essere rotonda, sferica, ma non caotica. Deve stare nella quaternità, nelle pienezza, nella luce naturale che diventa divina e che appartiene all’Uomo Universale di cui parla anche René Guenon nel Simbolismo della Croce. Non bisogna confondere le dimensioni del simbolo con le direzioni nello spazio. La dimensione è sferica, la direzione è multipla. La croce invisibile ha quattro direzioni, quattro “bracci”, e due dimensioni, definite dalle rette che si intersecano a formare la croce. Questo è un dato essenziale per determinare l’universalità del simbolo, attraverso il quale l’Uomo ha potuto rappresentare, riassumere e assimilare questioni fondamentali legate alla sua interpretazione del mondo. Le quattro direzioni sono fondamentali, per René Guenon, a indicare
«l’immanenza di Dio in seno al mondo, la manifestazione del Logos al centro di tutte le cose, nel punto primordiale in cui le estensioni indefinite non sono che le espansioni o lo sviluppo: “Egli formò dal Thohu (il vuoto) qualche cosa e fece di ciò che non era ciò che è. Egli intagliò delle grandi colonne dall’etere inafferrabile. Egli rifletté e la parola (Memra) produsse ogni oggetto e ogni cosa con il suo Nome Uno”. Il punto primordiale da cui viene proferita la Parola divina si sviluppa, come abbiamo detto, non solo nello spazio, ma anche è nel tempo; è il “Centro del Mondo”, sotto tutti gli aspetti, cioè è ugualmente al centro degli spazi e al centro dei tempi». (R. Guenon, Il simbolismo della croce, Adelphi, Milano 2012, p. 35
Come le colonne dell’albero sefirotico sono intagliate nell’etere, così la nostra colomba aleggia nel vuoto, sembra riposare in una dimensione statica di non-azione in cui tutto avviene, in cui gli opposti si risolvono, in un etere puro e inafferrabile, che è «la causa di tutte le cause e l’origine di tutte le origini. È in questo mistero, origine invisibile di tutte le cose, che nasce il “punto” nascosto da cui tutto deriva. Per questo è detto nel Sepher Ietsirah: “Prima dell’Uno, che cosa puoi contare?”».
Perché l’unità è il primo di tutti i numeri, e la numerazione è la prima coniazione, la prima incisione, il principio della conoscenza. Lo zero metafisico, il Non-essere simboleggiato dal “vuoto” caro alla filosofia orientale, è lo stato anteriore all’inizio del mondo, del volo della colomba, della pronuncia del primo suono. Non a caso, nella scrittura ebraica le lettere venivano anche impiegate come cifre, e ad aleph spettava il valore numerico di 1. L’Aleph, in quanto simbolo dell’unità, veniva connesso con Dio, l’Uno, Unico ed Eterno. Annota Borges nella raccolta di racconti del 1949 L’Aleph:
«Devastato il giardino, profanati i calici e gli altari, gli unni entrarono a cavallo nella biblioteca del monastero e lacerarono i libri incomprensibili, li oltraggiarono e li diedero alle fiamme, temendo forse che le pagine accogliessero bestemmie contro il loro dio, che era una scimitarra di ferro. Bruciarono palinsesti e codici, ma nel cuore del rogo, tra la cenere, rimase quasi intatto il libro della Civitas Dei, dove si narra che Platone insegnò in Atene che alla fine dei secoli tutte le cose riacquisteranno il loro stato anteriore, e che egli in Atene, davanti allo stesso uditorio, insegnerà tale dottrina». (“I teologi”, L’Aleph, Jorge Luis Borges, 1949)
Howard Phillips Lovecraft nacque il 20 agosto 1890 a Providence nel Rhode Island. Sua madre appartenne alla agiata borghesia che si era stabilita nella cittadina sin dall’età coloniale, mentre il padre, fu rappresentante di commercio per una ditta di argenteria, la Gorham Silver Company, per problemi psichici, finì in manicomio, morendo poi di sifilide.
Venne cresciuto dalla madre, da due zie e dal nonno, che lo inizierà alla letteratura, attraverso la passione per la letteratura gotica, le Fiabe dei fratelli Grimm, Le mille e una notte: «Il mio amato nonno, Whipple Van Buren Phillips, divenne il centro di tutto il mio universo. Era un uomo di cultura, che aveva viaggiato molto e aveva accumulato una messe di folklore cosmopolita con cui non cessò mai di deliziarmi» o ancora «Imparai il latino con una certa facilità e in altri studi fui molto aiutato da mia madre, dalle zie e dal nonno. È proprio a quest’ultimo che devo molto: aveva viaggiato a lungo in Europa, e mi deliziava con i suoi racconti di Londra, Parigi, Roma. La sua toccante descrizione delle rovine di Pompei m’impressionò moltissimo, perché avevo sempre amato fantasticare sulle grandezze del passato […] Perciò respinto, respinto dagli esseri umani, cercai rifugio e comprensione nei libri, e in ciò fui doppiamente fortunato: la biblioteca familiare accoglieva infatti i migliori volumi acquisiti tanto dai Phillips che dai Lovecraft, […] fu allora che i volumi più vetusti della biblioteca familiare divennero tutto il mio mondo – risultando allo stesso tempo i miei servitori e i miei padroni. Mi aggiravo fra di loro come una falena ammaliata, ricavando gioia suprema dagli antichi volumi inglesi dei Lovecraft, che mia madre mi aveva affidato quando mio padre era rimasto paralizzato, dal momento che ero diventato l’unico rappresentante maschile della famiglia. Leggevo tutto, capivo qualcosa e il resto me lo immaginavo. Le Fiabe dei Grimm rappresentavano il mio nutrimento di base e vivevo in gran parte in un mondo medievale evocato dalla fantasia».
L’apertura della biblioteca del nonno è un colloquio aperto con tutte le discipline: mitologia, scienze, astronomia. A sette anni è già autori di brevi racconti e inizia a maturare la sua personale passione per Edgar Allan Poe, Julies Verne, Herbert George Wells.
Nel 1896 perse la nonna materna. In seguito egli ricorderà l’incubo e l’ossessione di quel lutto, così come la perdita del padre due anni dopo e del nonno nel 1904.
Frequentatore a intermittenza delle scuole pubbliche e costretto a ritirarsi per esaurimento nervoso e salute malferma, dovuta probabilmente a una caduta da un’impalcatura e a proseguire privatamente gli studi, svolse la sua vita all’ombra della madre, vivendo al 598 di Angell Street: «Sentendosi incapace d’inserirsi nel consorzio sociale, di adattarsi alle minute necessità della vita quotidiana, Lovecraft s’isolò sempre più dal mondo, studiando il passato, favoleggiando di vivere nell’antichità classica o nell’America del diciassettesimo secolo, il suo periodo storico preferito. Corazzò il suo spirito di cinismo e si dispose ad osservare, con un sorriso dolceamaro, “l’irrazionale comportamento” della razza umana. Il suo isolamento era favorito dalla facilità con cui sapeva crearsi una realtà fittizia, infinitamente più colorita ed affascinante del mondo di tutti i giorni» (G. De Turris, S. Fusco, Howard Phillips Lovecraft, Firenze, La Nuova Italia, 1979, p. 14).
La sua indole si può ravvisare anche nella personalità dello scultore Henry Anthony Wilcox, tratteggiata ne Il Richiamo di Cthulhu: «A quanto pare il primo marzo 1925 un giovanotto magro, scuro di pelle e dall’aria nevrotica aveva fatto visita al professor Angell mostrandogli il fantastico bassorilievo d’argilla. In quel momento il materiale era ancora fresco, quasi umido. Il nome del giovanotto, come diceva il suo biglietto da visita, era Henry Anthony Wilcox, che mio zio riconobbe per il figlio minore di un illustre casato; a quell’epoca il signor Wilcox studiava scultura alla Rhode Island School of Design e viveva per conto proprio nell’edificio conosciuto come Fleur-de-Lys, vicino all’istituto. Il giovanotto era precoce e dotato di un grande talento, ma anche di una notevole eccentricità. Fin da bambino aveva attirato l’attenzione con il racconto dei suoi sogni straordinari e si definiva “ipersensibile”, anche se la gente quadrata dell’antica città commerciale si limitava a giudicarlo strano. Non si era mai troppo mescolato con i coetanei e poco a poco era scomparso dalla scena sociale: ora era noto solo a un piccolo gruppo di esteti sparsi in altre città. Persino l’Art Club di Providence, geloso del proprio conservatorismo, lo aveva abbandonato a se stesso».
Dal 1924 al 1926, nei due anni di matrimonio, abitò a New York, salvo poi ritornare di nuovo a Providence al 10 di Barnes Street con la zia Lillian e poi, definitivamente, al 66 di College Street.
Il flusso torrenziale della sua esistenza si svolse nell’ossessione di un universo fantastico.
Dopo aver distrutto molta della sua iniziale produzione narrativa, per quasi dieci anni si dedicò esclusivamente al giornalismo scientifico e alla poesia, che recupera la vastità e l’indifferenza dei cieli, Poe, il tema ossessivo della morte, il Settecento inglese e soprattutto le letture fantastiche. Una serie di lettere inviate al settimanale “Argosy” vengono notate dalla United Amateur Press Association.
Per Lovecraft l’affiliazione alla stampa amatoriale significò sviluppare la sua vasta corrispondenza e a creare una casa editrice: la Arkham House.
Il mancato arruolamento nell’esercito, a causa della sua salute cagionevole, segnò definitivamente il suo processo creativo che si indirizzò alla necrofilia, al macabro, al grottesco.
La conoscenza della produzione di Lord Dunsany rappresentò un gorgo e un’accensione. Quando morì la madre per una banale operazione e poi quando sposò Sonia Haft Greene, egli rimase a New York, svolgendo un oscuro e poco redditizio lavoro di correzione e di consiglio letterario, salvo l’incontro con il mago Houdini che gli propose di scrivere un racconto per lui: diventerà Imprisoned with the Pharahos.
Inizia il suo rifugio nei sogni e nelle veglie, come l’incubo di Nyarlathotep, scritto in uno stato di dormiveglia: «Ecco, questo è stato il mio incubo! Nel sogno sono poi svenuto, e quando ho ripreso i sensi ero ormai sveglio – e con un mal di testa eccezionale! Non capisco ancora bene di cosa si sia trattato […]. Un giorno, ho intenzione di attingere materiale da questo incubo per scrivere un racconto, come ho già fatto per The Doom that Came to Sarnath».
La sua dormiveglia brama un mondo di misteri fastosi e giganteschi, di tremore splendido e orrifico, la cui immaginazione conduce sfrenatezza immaginifica e entità di soglie incomprese e tetre.
Annota Sunand Tryabak Joshi: “Why study H. P. Lovecraft? In the minds of some critics and scholars this question still evidently requires an answer, and will perhaps always require an answer so long as standard criticism maintains its inexplicable prejudice against the tale of horror, fantasy, and the supernatural”
La fuga dalla realtà si accompagna alla lucidità onirica di un viaggio astrale: «Mi svegliò il suono di una strana melodia. Un arpeggio, una serie di vibrazioni armoniche echeggiava ovunque, mentre ai miei occhi si presentava uno spettacolo di bellezza suprema. Mura, colonne e architravi di fuoco vivo splendevano intorno al punto dove io sembravo fluttuare a mezz’aria e svettavano verso un altissimo soffitto a cupola di splendore indescrivibile. Insieme a questa esibizione di magnificenza architettonica, o piuttosto in alternanza con essa, come in un caleidoscopio, si scorgevano vedute di valli incantevoli, alte montagne e grotte invitanti. Erano dotate di ogni piacevole attributo scenografico che si potesse concepire, eppure sembravano fatte di una sostanza eterea, lucente, plastica la cui essenza faceva pensare allo spirito più che alla materia» o ancora «Fu sotto una falce di luna bianca che vidi per la prima volta la città. Sorgeva, immobile e sonnolenta, su un misterioso altopiano in mezzo a una depressione circondata da montagne fantastiche. Mura, torri, pilastri, cupole e strade erano di un marmo sepolcrale, e dalle strade si alzavano colonne che in cima avevano scolpite le immagini di uomini severi e barbuti. L’aria era calda e immobile nel cielo, a dieci gradi scarsi dallo zenit, brillava l’occhio della Stella Polare».
Scrive Giuseppe Lippi: «Che Lovecraft sia soprattutto un sognatore è cosa che pochi metteranno in dubbio, anche alla luce della sua produzione; ma è di quelli che posseggono l’invidiabile capacità di gettare un ponte tra il mondo dei sogni e quello della veglia, finché poco a poco l’uno trascolora nell’altro in un amalgama originalissimo. Fin dall’infanzia la notte gli porta alcune immagini ricorrenti: enormi altopiani deserti sui quali giganteggiano colossali rovine; abissi senza fondo che si spalancano su altre sfere di realtà; celle e corridoi sotterranei che si snodano sotto le fondamenta di edifici familiari, mettendo in comunicazione il mondo della superficie con un netherworld gravido di segreti; esseri mostruosi che riempiono, al tempo stesso, di meraviglia e terrore».
Egli stesso confessò: «Se io mi siedo alla scrivania con l’intenzione di scrivere un racconto, è molto probabile che non ci riesca. Ma se scrivo per mettere sulla carta le immagini di un sogno, tutto cambia completamente».
La trasfigurazione dei sogni mette in contatto il suo universo segreto e incantato, laddove la magia e la chiave d’accesso per la felicità quasi edenica, negata dall’infanzia infelice, possano unirsi, finalmente, in un’unica grande architettura visiva, come un lungo grande sogno: «Bramava le lande dei sogni perduti, e ardeva dal desiderio di rivivere i giorni della sua fanciullezza. Poi aveva trovato una chiave, e penso che, in un certo senso, sia stato capace d’impiegarla per qualche bizzarro scopo […]. Sono davvero impaziente di vedere la grande Chiave d’Argento, perché le sue criptiche iscrizioni potrebbero offrire la soluzione per decifrare i misteri e i disegni di questo cieco e indifferente universo».
La permanenza a Providence, dopo il distacco dalla moglie, destinò la sua figurazione eclettica e versatile, attraverso una cospicua produzione, come Il caso di Charles Dexter Ward, Alle montagne della follia, La maschera di Innsmouth, luogo maledetto e infestato da una voragine condannata.
Annota ancora Giuseppe Lippi: «L’intuizione geniale che gli era già balenata anni addietro, forse all’epoca di Dagon, prende forma: nel racconto dell’orrore gli esseri umani sono pedine di una più vasta scacchiera cosmica; le nostre mitologie, le nostre stesse paure, sono pietose menzogne che servono a coprire più mostruose, assurde realtà dell’essere. I nostri dei indigeni si inchinano a mostruose divinità dell’oltrespazio che non conosceremo mai, ma la cui semplice menzione può scate-nare la follia. Lovecraft, per dirla con le parole di Fritz Leiber, sposta l’oggetto del terrore dalla terra al cosmo, dai diavoli, dalle streghe e i vampiri della tradizione gotica alle creature calate da altri mondi e dimensioni che aspettano di riprendere possesso del nostro universo».
La mitologia anagrammata che sta alla base del mito di Cthulhu crea uno spazio fittizio di dei e demoni che popolano l’universo di sotterranee entità malefiche, in un tempo corrotto e decadente.
Calcando le tinte di un universo parallelo e originario, Lovecraft fonda un mondo di crolli e forze fantastiche che sagomano le linee di un assedio di luoghi: dal Massachussets, fino al Vermont e a Boston.
In un saggio del 1966, Giorgio Manganelli avvertiva in Lovecraft: «qualcosa di risolutamente ingenuo, una cultura da incolto, una artificiosità elementare. […] Con ingenua fiducia, continuamente ripete talune parole: empio, blasfemo, mostruoso […] tuttavia non pare assurdo dirlo “scrittore”. Forse perché il suo puro, concentrato orrore stinge rapidamente, e svela, sotto, qualcosa di duro, di ostinato […] «forse la goffaggine geniale di Lovecraft è solo l’indizio di una macchinosa cerimonia apotropaica, grazie alla quale egli tenta, vanamente, di tenere a bada l’ambiguo, “strano ed antico”, mostro della letteratura».
Approfondendo la tematica dell’orrore e dello spirito della fantascienza, egli espresse una malattia d’altrove che si affranca e vaga nello spazio del cosmo esterno e abissale: un altrove fisico e inattingibile, colto nell’incapacità di oltrepassarlo.
La costruzione immaginaria, l’atmosfera onirica e la visione accompagnano una rivolta assoluta e primordiale contro il mondo che lo attornia. Lo stesso Lovecraft, scrivendo a Rheinhart Kleiner, disse che «le misteriose produzioni della fantasia umana sono altrettanto reali – nel senso di “fenomeni” reali – dei più ordinari pensieri, passioni e istinti della vita d’ogni giorno. C’è un senso di euforia che dà quasi il capogiro nel guardare oltre il mondo conosciuto e dentro le profondità dell’ignoto; c’è un brivido a cui non si può sfuggire nei pensieri che hanno a che fare con il mistero e l’orrore».
Gli incubi e i sogni divengono il trapassato di una leggibilità convulsa di epoche e di una inquietudine che lo avvicina a Poe (Jacques Bergier lo definì “Edgar Poe cosmico”), ma ne distanzia le tensioni verso una distillazione di delirio e unione di fantastico e scienza.
Malato di cancro all’intestino, si fece ricoverare da solo al Jane Brown Memorial Hospital di Providence, nel marzo del 1937 e all’alba del 15 morì, in assoluto silenzio, per essere poi sepolto nel cimitero di Swan Point.
Lovecraft abita la insensatezza del delirio cosmico, è privato dell’armonia e dell’ordine dell’universo e «se da un lato esprime questa impressionante angoscia dell’essere di fronte alla propria alienazione, dall’altro cerca di reintrodurre, con qualche sotterfugio e un’abbondante dose di umorismo nero, il discorso sul perduto stato di grazia» (Giuseppe Lippi).
L’area del terrore e il timore religioso si accompagnano a una concezione tenebrosa e numinosa che forgia le figure in una aspettualità teriomorfa, in un Assoluto deterministico, in una sospensione che preannuncia il caos di un «disegno senza disegno».
È l’elemento esterno a mettere in scena la paura. L’incombenza determina un diorama freddo e gelido che provoca vertigine di vuoto e di senso, mysterium tremens e iconoclastia.
La manifestazione di oggetti antichi e proibiti, come il Necronomicon, aprono portali di abisso e dimore fossili, come un disegno occulto, impalpabile e colorito.
Il fascino simbolico e il sortilegio delle sue forme, se da un lato gemono di colore, dall’altro si muovono verso il timore di fronte alla solitudine naturale e alla dispersione infantile, come egli stesso scrive nel suo saggio Supernatural Horror in Literature: «Il sentimento più forte e più antico dell’animo umano è la paura e la paura più grande è quella dell’ignoto».
È un ignoto che affronta il lato allucinatorio, il labirinto concentrico, compenetrato e coalescente, e poi precognitivo e profetico di un’ombra che diventa mitologia di abisso, sottile divisione tra il mondo della vita e il regno della morte (Herbert West, rianimatore), fluidità della forma umana e ipnosi.
L’inanimata lontananza del plasma dell’immaginario oscuro di Lovecraft rievoca passaggi maligni e labirinti metafisici distruttivi, come testimonia questo passaggio de La visione del caos, nel quale la paura del protagonista proviene da un ambiente irriconoscibile e ostile e la sua mente cade nella brutale fantasia e nel panico, per una astratta e incontrollabile entità mostruosa: «Poco a poco, ma inesorabilmente, si insinuò nella mia coscienza e giunse a dominare ogni altra sensazione una sconcertante paura dell’ignoto: paura tanto più grande in quanto non riusciva ad analizzarla e che sembrava riguardare un pericolo che si faceva sempre più vicino. Non era la morte ma qualcosa di inaudito e orrendo, qualcosa che non si può esprimere.[…] Le onde erano scure e violette, quasi nere, e si aggrappavano al fango rosso e cedevole della terraferma come mani avide e rozze. Non potei fare a meno di pensare che un’orribile entità marina avesse dichiarato guerra alla terra, aiutata magari dal cielo iracondo».
La conoscenza proibita diviene, pertanto, un asse di disperazione e maledizione, in cui il non-umano prevale sull’umano in una nera abissalità multidimensionale.
La realtà descritta da Lovecraft è una strada distorta e decadente: spesso una casa barocca fatiscente in un agglomerato urbano disgregato, un albergo ai limiti del mondo gestito da una madida matrona, tutto, quindi, viene collocato in un sottofondo di rumori e di fatalistica dannazione (I ratti nei muri).
Il realismo visionario, attestato sul cosmic horror, si colloca su una vertigine tragica, ingannevole e meccanicistica, in cui le forze dispiegate all’interno degli scenari abitati dall’uomo permangono nella loro fisicità: «Io nutro sempre il più profondo riguardo per l’intelletto puro: sono un assoluto materialista e meccanicista, credo che il cosmo non abbia né scopo né significato, sia un groviglio di cicli alterni di condensazione e dispersione elettronica: una cosa senza principio né direzione permanente né fine, fatta soltanto di forze cieche che agiscono secondo schemi fissi ed eterni, inerenti alla loro essenza».
Nell’immaginario di Lovecraft, il matrimonio tra il mondo siderale popolato da entità terrificanti e la realtà umana ha lo spazio di una fenditura, in cui interviene e irrompe la presenza ultraterrestre e extraterrestre.
L’insufficienza, l’incapacità e l’intelligibilità umane nel cogliere la vastità e la totalità dell’essere apre l’infinito varco alla tenebra, alla anomalia cosmica, allo stadio fragile e intermedio dell’umanità sospesa e dormiente e a un pantheon rovesciato, che come scrive Michel Houellebecq è espressione di un «terrore rigorosamente materiale».
La spazialità del sublime si scontra con il frangersi della follia. Davanti alla terribile rivelazione della realtà, la mente trova rifugio nel sogno e nella fenditura folle.
Non esiste una conciliazione che possa definire un esito positivo. Anche nel più piccolo dei villaggi (L’orrore di Dunwitch) gli sconvolgimenti terribili e devastanti di un mostro invisibile lasciano indelebilità di segni, come lo svenimento e la follia, appunto.
È il non visto, la non-rivelazione che paradossalmente si rivela, a sgomentare, a trovare il bandolo di un confine limitante e razionale.
Pertanto, il sigillo della sua tecnica narrativa si distanzia dalla indagine psicologica di Poe per raggiungere il fulcro nevralgico dell’abisso siderale e l’orrore, come scrive in un interessantissimo articolo Andrea Scarabelli, «non abita l’inconscio dei personaggi ma le stelle sovrastanti, non appartiene alla loro interiorità ma si manifesta come irruzione di un’alterità pulsante e spaesante».
Lo stesso Lovecraft scrive che «per raggiungere l’essenza della vera alterità, sia nel tempo che nello spazio che nelle dimensioni, occorre dimenticare che concetti quali la vita organica, il bene e il male, l’amore e l’odio, e tutti gli analoghi attributi locali di una razza trascurabile e effimera chiamata umanità, abbiano un’importanza di qualsiasi genere» e che il sommovimento di forze senza tempo e luogo «Nonostante si spingano a descrivere abissi sconosciuti, i miei racconti prendono sempre avvio da un’ambientazione realistica. I reami spettrali di Poe erano anonimi, popolati da creature misteriose dall’ignoto passato – invece io mi sforzo di dare alle cose che scrivo l’ambientazione tipica dell’antico New England e ai miei personaggi […] il tipico lignaggio di queste terre. Le mie fantasie oniriche non nascono dal nulla […] ma hanno bisogno, per mettersi in moto, dello stimolo rappresentato da una scena, da un oggetto o un evento reali. […] Il mondo che mi circonda è il mio teatro d’azione, il libro da cui traggo la mia ispirazione».
Tuffandosi nel mare e nelle spire dei sogni egli scova la bellezza e la dimensione esistenziale, frequenta l’incubo più radicale, per appartenere alla terra e al suo limite che scruta e inghiotte: «Le entità che Lovecraft mette in scena sono e rimangono oscure. Egli evita di precisare la suddivisione dei loro poteri e delle loro capacità. In realtà, la loro esatta natura sfugge a qualsiasi concetto umano. (…) Esse rimangono fondamentalmente indicibili. Noi riusciamo a percepire solo dei fugaci sprazzi della loro orripilante potenza; e gli umani che cercano di saperne di più ci rimettono inevitabilmente il senno e la vita». (Marc Houellebecq)
È qui che avviene il terrore materiale di Lovecraft, che nel mito di Cthulhu, trova «una Weltanschauung che va oltre il fascino delle sue immagini e delle sue fantasie, e penetra nel nucleo della nostra sensibilità di uomini che da lui sono lontani ormai quasi un secolo, ma che come e più di lui devono confrontarsi con i «fantasmi/senza sostanza delle mode vane/ e degl’incerti credi» viepiù incalzanti all’inizio del Terzo millennio. Con ciò lo scrittore di Providence ci ha offerto – senza che egli ne fosse del tutto consapevole – gli strumenti ideali, culturali, etici per fronteggiarli e non lasciarsi travolgere o condizionare. L’importante è saper identificare i fantasmi, leggendo al di là della loro ombra, come fece profeticamente Lovecraft nella prima metà del Ventesimo secolo»(Gianfranco de Turris).
Nella terribile dimensione del caos egli descrive l’inganno della luce e sono le tenebre a rivelare il volto sconosciuto e smarrito dell’umanità.
La tripartizione ontologica trova il culmine nei grandi mostri corporei ultradimensionali, come i Grandi Antichi, sopravvissuti al residuo delle età remote. Scesero dalle stelle con i loro poteri sovrumani sulla Terra e lì si stabilirono, fondando R’lyeah. Costretti a sprofondare negli oceani, attendono di risvegliarsi e di imporre il loro potere.
Ma questi mostri «infilatisi da tempo immemorabile nelle pieghe della Terra, e che ora traboccano dai paesi del New England, non sono “i marziani”, ma “gli dèi dei marziani”; non gli abitanti delle stelle, ma gli dèi degli abitanti delle stelle. Liquidato insomma ogni residuo di geocentrismo e antropomorfismo, dimesso ogni antiquato particolarismo religioso, quelle che abbiamo ora sono divinità realmente alla misura del cosmo o, per così dire, al passo con le galassie più progredite. Il fatto poi che siano così orrende è certo una sgradita sorpresa; ma in sede di aggiornamento teologale, la verità è ciò che conta» (C. Fruttero, F. Lucentini, Storia delle storie di Lovecraft, in H. P. Lovecraft, L’orrendo richiamo. Tutti i Mostri del Ciclo di Chtulhu, Torino, Einaudi, 1994, p. VIII).
La tensione verso l’inconoscibile diviene l’inafferrabile spazio di un delirio che abita il buio, come il dio Azathoth, centro di un mondo apatico e insensato.
Nel romanzo Le montagne della follia, memore del Le Avventure di Gordon Pym di E.A.Poe, una spedizione scientifica in Antartide porta alla scoperta di una enorme catena montuosa, più alta di qualunque altra, mentre al di là delle cime infinite si nasconde un altopiano che ospita le rovine di una città aliena. Dinanzi a questa scoperta gli esploratori constatano l’insensatezza di un errore e di una comparsa.
L’epifania del tempo sospeso e annichilente sconvolge ogni razionalità tranquilla e pacata. Quando cade un meteorite presso la tranquilla fattoria di Arkham, la tranquilla razionalità è sommossa da una contaminazione di una pazzia naturale e sadica: «Gli uomini rimasero indecisi davanti alla finestra, mentre la luce del pozzo si faceva più forte e i cavalli impazziti scalciavano e nitrivano per la disperazione . Fu un momento veramente terribile: il terrore che regnava nella casa maledetta, i quattro mostruosi resti umani alloggiati in un capanno lì vicino (i due che erano già in casa più i due ripescati da pozzo) , e il fascio di ignota e sacrilega iridescenza che dal pozzo si levava sul cortile».
La distruttiva vitalità cosmica interrompe una stabilità che è annientata e annichilita, come un misterioso pozzo di bagliori. La luce colorata che torna dal buio è rievocazione di un eterno ritorno e di un labirinto alieno.
Scrive Sandro D. Fossemò: «In un certo senso, è come se Lovecraft ci volesse totalmente disilludere dalla pretesa di vivere in un cosmo benevolo, solo apparentemente sano e razionale, servendosi proprio dell’ “ignoto” come una porta verso il mondo reale in cui «tutto imputridisce e muore, dove nelle cantine buie e nelle soffitte sbarrate di quasi tutte le case strisciano, gemono, saltano e latrano mostri». Una porta che, però, viene custodita da Yog-Sothoth, il temibile guardiano dell’inintelligibile, inteso a rappresentare l’impossibilità psicologica di contemplare il volto della realtà, senza rischiare di morire o di cadere in preda alla pazzia».
Lovecraft H. P., L’orrore soprannaturale in letteratura, Theoria, Roma 1992.
ID., Tutti i racconti. 1923-1926, a cura di Giuseppe Lippi, Mondadori, Milano 2009.
ID., Tutti i racconti. 1927-1930, a cura di Giuseppe Lippi, Mondadori, Milano 2009.
ID., Il dominatore delle tenebre, a cura di Sergio Altieri, Feltrinelli, Milano 2012.
ID., Lettera a Rheinhart Kleiner del 16 novembre 1916, in LOVECRAFT H.P., L’orrore della realtà. La visione del mondo del rinnovatore della narrativa fantastica. Lettere 1915-1937, (a cura di) G. De Turris, S. Fusco, Mediterranee edizioni, Roma 2007.
ID., Lettere dall’altrove, a cura di Giuseppe Lippi, Mondadori, Milano 1993.
De Turris G., Fusco S., Howard Phillips Lovecraft, Firenze, La Nuova Italia, 1979.
FOSSEMò S.D., Il terrore cosmico da poe a Lovecraft, la paura dell’ignoto dall’abisso dell’anima al caos cosmico
(http://blogmetropolis.myblog.it/media/02/01/905349309.pdf)
Fruttero C., Lucentini F., Storia delle storie di Lovecraft, in LOVECRAFT H.P., L’orrendo richiamo. Tutti i Mostri del Ciclo di Chtulhu, Einaudi, Torino 1994.
Joshi S. T., Itroduction, in D. Schultz and S. T. Joshi (a cura di), An Epicure of the Terrible. A Centennial Anthology of Essays in the Honor of H. P. Lovecraft, Teaneck (NJ), Fairleigh Dickinson UP 1991.
MANGANELLI G., La letteratura come menzogna, Adelphi, Milano 2004.
HOUELLEBECQ M., H.P.Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita, Bompiani, Milano 2005.
SCARABELLI A., Razionalismo e antiumanesimo nell’epistolario lovecraftiano, in “Antarès”, 2011.









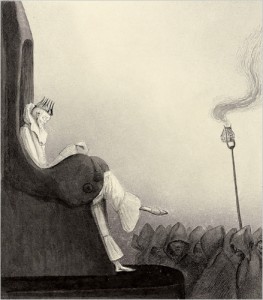 La vera funzione dell’Arte è rivelare la bellezza nascosta, l’impronta divina che è in tutte le cose.
La vera funzione dell’Arte è rivelare la bellezza nascosta, l’impronta divina che è in tutte le cose.


