di Andrea Galgano 16 settembre 2019
leggi in pdf ASHBERY-CHODASEVIC-PARRA
Si intitola capoVersi, la nuova collana della Bompiani, con i primi tre titoli: Autoritratto entro uno specchio convesso di John Ashbery, Non è tempo di essere di Vladislav Chodasevič e L’ultimo spegne la luce di Nicanor Parra.
JOHN ASHBERY: L’INELUDIBILE LIMINALE

Autoritratto entro uno specchio convesso[1] di John Ashbery, vincitore del Premio Pulitzer nel 1976, del National Book Award e del National Book Critics Circle Award, a cura di Damiano Abeni e con un saggio di Harold Bloom, rappresenta una frantumazione linguistica che tenta di esplorare, raggiungere e rappresentare il reale, in ogni sua forma compulsiva, negli anfratti che segnano il Tempo, attraverso l’ordito della figurazione quotidiana, la scompaginazione della prospettiva e il territorio dello spazio mentale.
Già nel 1983, Garzanti pubblicò, nella storica traduzione di Aldo Busi, impreziosito da una introduzione di Giovanni Giudici che ne sottolineò la genesi germinale del Tempo, obbligato e cadenzato dal reale: «In Ashbery la coscienza umana, nella ricerca di dare senso al fluire inarrestabile dell’esistenza, resta vuota, frastornata e attonita, tuttavia carica di un’energia che sfavilla, lasciando intendere sogni, scommesse, emozioni, desideri e chissà quali speranze di felicità[2]».
John Ashbery avverte tutto il potere dei passaggi liminali, non soltanto nella diffrazione tra presente e intonazione passata, ma nella convessità del tempo e nei suoi dispositivi:
«Quelle intricate versioni del vero vengono / sbrogliate, i ringhiosi grovigli estirpati / e sparpagliati. Dietro la maschera / permane una comprensione continentale / del bello, che s’appalesa di rado e quando lo fa già / muore sulle ali del vento che l’ha portato sulla soglia / della parola. Racconto consunto dal raccontare. / Tutti i diari s’assomigliano, limpidi e gelidi, con / la prospettiva di un gelo interminabile. Vengono collocati / in orizzontale, paralleli alla terra, / come i morti che non ci intralciano. Giusto il tempo di rileggere / e il passato ti scivola tra le dita, augurandosi che tu sia con lui».
Il sole si sfarina, il volo aspro delle parole come una pienezza in uno sguardo di specchi aumentano il desiderio di pienezza e separatezza, immedesimazione, ombra e riflesso di una leggibilità nascosta, laddove il mondo non viene rappresentato bensì è esso stesso proprietà, avviluppo e inconoscibilità:
«dalla notte affiora il ricordo / le sue foglie come uccelli che si posano all’unisono sotto un albero / raccolto e scosso di nuovo / messo giù in rabbia fiacca / sapendo come lo sa il cervello che ciò non si può mai inverare / non qui non ieri nel passato / solo nella lacuna dell’oggi che colma se stessa / mentre il vuoto è suddiviso / nell’idea di che ora sia / quando quell’ora è già passato».
In tale inconoscibilità che non ammette conclusione nette e risposte preconfezionate, il challenging di Ashbery squilibra le pupille del senso, in un universo di perfezione che non teme irresolutezza e luci dissipate, e che, nel dono essudato della parola, pone la sua linea, il tatto che si sottrae, la scatola intonsa di un monologo ritagliato:
«Uno sguardo di specchio ti arresta / e tu passi oltre scosso: ero io il percepito? / Mi hanno notato, stavolta, così come sono, / o tutto è ancora rimandato? I bimbi / ancora intenti ai giochi, nuvole che salgono con agile / impazienza nel cielo pomeridiano, per dissiparsi / quando scende il limpido, denso crepuscolo. / Solo in quel colpo di clacson / là in fondo, per un attimo, ho pensato / che l’insigne evento formale stesse iniziando, orchestrato, / i colori addensati in uno sguardo, ballata / che abbraccia il mondo intero, adesso, ma con dolcezza, /ancora con dolcezza, ma con ampia autorità e tatto. / La prevalenza di quei fiocchi grigi che cadono? / È pulviscolo di sole. Hai dormito al sole / più della sfinge, ma non ne sai più di prima. / Entra. Ho pensato che un’ombra tagliasse la soglia / ma era soltanto lei venuta a chiedere ancora una volta / se intendevo entrare, e in caso contrario di prendermela calma. / La lucentezza della notte s’insedia. Una luna dal pallore cistercense / ha scalato la vetta del firmamento, vi si è installata, / socia adesso nell’affare del buio. / E un sospiro sale da ogni minuscola cosa terrena, / da libri, carte, vecchie giarrettiere, dai bottoni di sottomaglie e mutandoni / riposti in una scatola di cartone bianco chissà dove, e tutte le versioni / inferiori di città rase al suolo dalla livella della notte. / L’estate troppo esige, troppo prende, / ma la notte, schiva, reticente, dona più di ciò che sottrae».
Anche il dettaglio partecipa alla scena. Un dettaglio frazionato e scomposto che aggredisce dolcemente la pagina. Se di postmoderno si tratta, il postmodernismo presunto di Ashbery è un oltre di senso disfatto e raggiunto, laddove l’orizzonte spazio-temporale conosce i salti e l’incorruttibilità e l’inerzia.
Il colore si accompagna alla stasi sconvolta, per schernire luci ventose e planare con l’acuto diaframma della distopia, della forma scomparsa ma emersa all’improvviso e dell’inconscio sottaciuto nei nomi che germinano e nell’attesa piena. Le parole sono anti-figura, effigiano spaesamenti, mimano immanenze. Sotto l’elusività esiste la necessità di una materia cangiante, come
«qualcosa di incandescente, di urgente, di vero, e che anzi questa verità si possa cogliere solo rinunciando a quella sorta di coazione alla coerenza che costituisce in fondo una della illusioni fondanti del cogito: se la poesia di Ashbery, come ha scritto qualcuno, rischia di «far sentire stupidi», questo andrà considerato come il primo necessario passo per una maturazione profonda che implica persino, come dichiara lo stesso poeta americano in una risposta alle mie domande, un accrescimento di sapienza o di saggezza[3]»:
«Vede i quadri alle pareti, / mero campione del vero. / Ma non se ne ha mai abbastanza. / Il vero non appaga. / In una vaga stanza d’albergo / le sfilze di chiazze lievitate / dal crepuscolo erano giorni e notti / e al largo sul mare / perdurava il desiderio di essere un sogno a casa / nuvola o uccello assopito nell’abbeveratoio / d’acque digressive».
Il territorio della poesia raggiunge gli argini della mitopoiesi e della metalinguistica, li alterna, sfrangia i codici, frequenta la parodia e la dissacrazione come riflessione fatale:
«Come un temporale, diceva, le trecce di colore / mi dilavano e non sono per niente d’aiuto. O come chi / a un banchetto non mangia, perché non sa scegliere / tra i piatti fumanti. Questa mano amputata / impersona la vita e per quanto vaghi, / est o ovest, nord o sud, è sempre / un estraneo che mi cammina accanto. O stagioni, / bancarelle, chaleur, ciarlatani dai capelli scuri / ai margini di qualche fête rurale, / il nome che buttate lì senza mai dirlo è il mio, mio! / Un giorno mi rivarrò su di voi per quanto logoro / sono a causa vostra ma nel frattempo il giro / continua. Si uniscono tutti al giro, / pare. E poi, che altro ci sarebbe?»
Spingere la parola, partendo dall’abisso della cifra ricolma ed orfica di Whitman, dalla densità separata di Emily Dickinson, dalla nudità suprema di Emerson e Wallace Stevens, al battito surreale e improvviso della Beat o l’impronta rinascimentale, fino all’amato Raymond Roussel e ai Surrealisti degli anni ‘20, cercando però un’espressione che sia distruzione convenzionale e celamento, è il suolo poetico di Ashbery, dove il sotterraneo rivelato si unisce al visibile:
«L’ombra della veneziana sulla parete dipinta, / ombre di sansevieria e cactus, animali di gesso, / inquadrano la tragica melancolia dello sguardo che acceso / fissa il nulla, un buco simile ai buchi neri nello spazio. / In reggiseno e mutandine raggiunge leggera la finestra: / zip! S’alza la tenda. Un fragile teatrino di strada si palesa / con ostie di pedoni che sanno dove andare. / La tenda scende lenta, lente si schiudono le lamelle. / Perché deve sempre andare a finire così? / Un podio con donna che legge, con il parapiglia dei capelli / e il non-detto di lei che ci riattira a lei, con lei / nel silenzio che la notte di per sé non può spiegare. / Silenzio della biblioteca, del telefono con il suo blocco- note, / ma nemmeno questi li abbiamo dovuti reinventare: / se ne sono andati nella trama di un racconto, / nella parte sull’“arte” – sapere quali dettagli di rilievo lasciar fuori / e il modo in cui si costruisce un personaggio. Cose troppo reali / per porvi troppo pensiero e quindi artificiali, eppure ormai sparse a coprire la pagina. / L’interno con l’esterno che diventa parte di te / nel vedere che non hai mai smesso di ridere in faccia alla morte, / lo sfondo di tralci scuri sul contorno della veranda».
Anche per Ashbery vale la tela verbale di un ipotetico dripping pollockiano, composto di epifanie spaiate, dove la poesia diventa possibilità, ritratto di luce e sua eventuale esplosione:
«Vivere con la ragazza / venne gettato a pedate nella zolla delle cose. / Ci fu una gran scenata a fine giugno, / gente che va e viene / prima che si lasci perdere la faccenda. / Ma rimane, come lei che accenna appena / ad accigliarsi, o le foglie che sgocciano / di rabarbaro e malvone, / anch’esse temporanee nella sconfitta. / Nessuno ride ultimo».
O ancora la cifra della torva fecondità:
«Quasi subito l’olio ha / preso il posto del / buio che ti circonda. Tutto è andato / come predetto, ma / comunque non è mai suonato bene: / una frazione qui, una lisca dove non aveva importanza. / Va offerto / attraverso un varco inappellabile: peri e fiori / un supremo muro resinoso / che si crogiola nel clima temperato / della tua identità. Torva fecondità / da tenere d’occhio».
Costruzione e non già distruzione, quanto filo invisibile:
«Così ciascuno si trovò preso in una rete / come una moda, e ogni sforzo per districarsene / lo avviluppava di più, inesorabilmente, visto che tutto / là esisteva per essere raccontato, sparato / da confine a confine. Qui c’erano pietre / che si leggevano come chiazze di sole, c’era il racconto / dei nonni, del giovane campione vigoroso / (le battute un tempo assegnate a un altro, adesso / restituite al nuovo oratore), cene e riunioni, / la luce nella vecchia casa, il modo segreto / delle stanze di sfociare l’una nell’altra, ma tutto / era circospezione del tempo che contemplava se stesso / poiché nulla nell’intricato racconto si espandeva di fuori: / la grandiosità nell’istante del narrare restava irrisolta / finché la sua sovrabbondanza di eventi, dolore commisto a piacere, / non sbiadì nell’attimo esatto dell’esplodere / in fioritura, la sua crescita statico lamento».
Il titolo della raccolta, che riprende l’opera del Parmigianino del 1524, raggruma il richiamo della deformità dello specchio convesso alla limpida costruzione dello spazio geometrico e lineare. La mano della tela sovrappone due dimensioni di realtà, due spazi prospettici. Essa entra nel quadro, come una vasta porzione:
«Come lo fece Parmigianino, la mano destra / più grande della testa, protesa verso lo spettatore / mentre con naturalezza sfugge, come a proteggere / ciò che sfoggia. Qualche vetro piombato, travi antiche, / pelliccia, mussola pieghettata, un anello di corallo confluiscono / in un movimento che sostiene il volto, che fluttua / avvicinandosi e allontanandosi come la mano / tranne che è a riposo. È quel che è / sequestrato».
Harold Bloom commenta:
«Il gesto difensivo della mano è una formazione reattiva o illusio teorica, dato che ciò che si vuol dire è che la mano agisce come per promuovere ciò che protegge. Qui lo sfuggire è un’altra modalità del riposo, così che la difesa non tanto protegge quanto sequestra, termine il cui antecedente tardo-latino aveva il significato di “rinunciare per mettere al sicuro”. Ashbery cita la descrizione di Vasari della sfera di legno tagliata a metà su cui Parmigianino ha dipinto quella che il poeta descrive come l’ “onda reiterata / d’arrivo” del volto[4]».
Il dualismo dell’anima e del corpo segna la sovrapposizione del ritratto. È un attimo di rêverie che soggiace a un indizio di melanconia alchemica, tra le mani dell’arte. La poesia-specchio del mondo che, pur rendendo temporale il gesto, lo eternizza. Essa richiama, rinvia, sfugge la propria genesi come uscio interminabile («Può darsi la mano / abbia volontà sua di ingigantirsi sul muro, / di farsi più grande e greve e forte / del muro; e che la mente / ricorra ad allegorie solo sue e proclami: / “Quest’immagine, quest’amore, di questi / mi compongo. In questi mi manifesto esteriormente, / in questi, mi vesto d’un lindore essenziale, / non come nell’aria, che tende all’azzurro acceso, / ma come nel possente specchio del mio desiderio e volontà”»):
«L’anima instaura se stessa. / Ma fin dove può fluttuare lontano attraverso gli occhi / e ancora tornare sana e salva al proprio nido? Essendo / la superficie dello specchio convessa, la distanza aumenterà / considerevolmente; vale a dire quanto basta per asserire / che l’anima è un prigioniero, trattato in modo umano, tenuto / sospeso, incapace di incedere molto oltre / il tuo sguardo che intercetta il dipinto».
Ancora Bloom:
«Ashbery va a caccia dell’anima, seguendo Parmigianino, e trova solo due entità disparate, una mano “grande abbastanza / da sfasciare la sfera”, e un vuoto ambiguo, una stanza senza recessi, solo alcove, uno studio che resiste a ogni cambiamento, “stabile / nell’instabilità”, un pianeta come la nostra terra, in cui “non ci sono parole per la superficie, cioè, / nessuna parola per dire ciò che è in realtà”[5]».
La caccia dell’anima è mutila d’interezza. Un incanto distopico e intenso che racchiude tagli, luci e simboli. Nella superficie avviene quel che c’è, senza cui nulla può esistere, nemmeno il corso del tempo. La superficie è orizzonte profondo e instabilità stabile di analessi. Il suo dislocamento rimane una protrusione di sogno, simile al vivere, o meglio al gesto vivente e la sua kenosis, per dirla alla Bloom:
«La kenosis è la ratio prevalente in Ashbery, e tutta la sua poetica sta nell’“[esalare] la propria forma con un gesto che esprime quella forma”. Cos’altro, se non la forza del passato, il vigore della sua tradizione poetica, avrebbe potuto portare Ashbery alla sua soglia successiva, allo stacco disgiuntivo o attraversamento del solipsismo che lui oltrepassa tra il terzo e il quarto paragrafo in versi? La transizione avviene “dal sogno alla sua codifica” fino alla sorpresa angelica o demoniaca del volto di Parmigianino/Ashbery. Il Portentoso o Sublime fa il suo ingresso sia attraverso la repressione del ricordo del volto sia attraverso un ritorno del represso grazie a ciò che Freud ha definito Negazione».[6]
Ecco Ashbery:
«Mentre comincio a scordarmene, / ripresenta il suo stereotipo / ma si tratta di uno stereotipo inconsueto, il volto / all’àncora, scaturito dai rischi, che di lì a poco / altri ne avrebbe abbordati: “piuttosto angelo che uomo” (Vasari). / Forse un angelo ha le sembianze di tutto / ciò che abbiamo scordato, intendo dire di cose / scordate che non paiono familiari quando / ci imbattiamo di nuovo in esse, perdute indicibilmente, / seppur nostre, una volta».
La frammentazione degli istanti è il sussurro, la rimembranza fuori dal tempo. La frattura e il tormento, la stanza radiosa, la luce di aprile e il limite raccontano la precocità precaria di un abisso che si consegna, immolando tutta la sua totalità:
«Ogni cosa accade / sul suo balcone e viene ricapitolata al suo interno, / ma l’azione è il freddo flusso sciropposo / di una sfilata in maschera. Ci si sente troppo limitati, / setacciando in cerca di prove la luce di aprile, / nella pura immobilità della serenità del suo / parametro. La mano non regge alcun gesso / e ogni parte dell’insieme si deteriora / e non può sapere di aver saputo, se non / qui e là, in gelidi recessi / di rimembranza, sussurri fuori dal tempo».
[1] Ashbery J., Autoritratto entro uno specchio convesso, a cura di Damiano Abeni, con uno scritto di Harold Bloom, Bompiani, Milano 2019.
[2] Affinati E., L’energia di Ashbery il più grande poeta di quest’epoca, in “Roma Sette”, 18 settembre 2017.
[3] Gezzi M., Benvenuti in un mondo che non può essere migliore. Intervista a John Ashbery, in «Poesia», XXII (2009), 234, gennaio 2009.
[4] Bloom H., Frantumare la forma, cit.
[5] Id., cit.
[6] Id., cit.
Vladislav Chodasevič: la frattura del buio
 In Non è tempo di essere[1], a cura di Caterina Graziadei, che contiene testi da Giovinezza (1908), La casetta felice (1914) e Raccolta dei versi (1927), Vladislav Chodasevič (1886-1939) osserva il mondo, contemplandone l’oscurità separata, la non-appartenenza, la scissione martire e la frattura abbuiata che respira finestre di tempo come distanze.
In Non è tempo di essere[1], a cura di Caterina Graziadei, che contiene testi da Giovinezza (1908), La casetta felice (1914) e Raccolta dei versi (1927), Vladislav Chodasevič (1886-1939) osserva il mondo, contemplandone l’oscurità separata, la non-appartenenza, la scissione martire e la frattura abbuiata che respira finestre di tempo come distanze.
La studiosa afferma:
«La finestra è centro di uno stralunato universo, lente e focus di un occhio testimone, di un poeta che è soprattutto sguardo. […] Discrimine fra interno ed esterno, la finestra diverrà nel tempo soglia creativa, trasparenza da cui si vede e si è visti, duplicità dello sguardo riflesso, che accoglie in sé i molti significati dell’occhio, della rifrazione. Infine, già nell’infanzia, essa prefigura la costante attrazione per la vertigine all’ingiù, per il suicidio. Di un’accidentale e fortunosa caduta dalla finestra scriverà nella prosa autobiografica Infanzia (1932), stilizzata sul modello baudelairiano delle Fusées o del Peintre de la vie moderne, dove il poeta ricorda il primo formarsi del gusto, il viluppo di inclinazioni e sensi che formeranno poi l’ordito di molta sua poesia e di altrettante scelte di vita».[2]
Morto in esilio nel 1939, a Parigi, nella vigilia del secondo conflitto mondiale, schiacciato dal lungo calvario che toccò anche Mandel’stam e Pasternak, nella ideale triade che ne fece Renato Poggioli, negli anni ’40 e ’50, egli è il poeta che, diacronicamente, avverte il peso dell’eclisse dello sradicamento, in quella meraviglia complicata, come disse Nabokov, che rimane lacerto di ferita insanguinata ma che resiste nella sua tramontata e scabra perfezione, annunciando, così, la vertigine dell’orrore degli specchi infranti, la rifrazione dello sguardo nella notte europea del secolo[3] e il tremore della morte.
E nella intonazione insonne della sua malattia, come «Baudelaire “dandy précoce”, egli partecipa della qualità androgina che da quel mondo deriva e sembra distinguere l’artista, il funambolo, o il ballerino[4]».
Chodasevič avverte la dissonanza come febbrile esecuzione dell’anima[5], l’infero che diviene dimora in un universo doppio, in una disgregante armonia di suono e disvelamento, ed è nella morte che tocca la sua ferita aperta e febbrile, che si afferma la sua luce attardata e intiepidita («Come tedio si riversa / nel fumaiolo gelato – l’urlo del vento! / Attorno a me si stringe il cerchio, / attorno alla fronte Angoscia intreccia / il mio fatidico serto»), come uno scarto di sogno inchiodato che scandisce la storia («Solo, fra le anse del fiume, / allo stridìo di attardate gru, / oggi di nuovo apprendo / la muta sapienza dei campi. / Si fanno più occulti, più gravi i pensieri, / più cauto il fruscìo della canna. / Alla foglia caduta nel letto sabbioso / offre il fiume tetra sepoltura»).
In un dittongo impronunciabile, essa decifra il percorso di una «una psicanodia, percorso dell’anima che aspira a abbandonare l’involucro del corpo per rientrare alla patria celeste e insieme narrare le sue sofferenze, le difficoltà di questo accidentato cammino. Un itinerario all’insù che volge in uno sciagurato precipizio: se il volo d’Icaro era fallito per arroganza, l’anima invece si perde per lo sconforto[6]».
Chodasevič compone il suo territorio di vastità immemori ed escluse, fondendo il volto del fato in danza incerta e verticale di metafisica e di respiro quotidiano, muovendosi «lungo una dinamica costante di attrazione-repulsione, alto-basso, cielo e terra; spesso con uno scarto irritato per la volgarità e l’usura dei giorni feriali rovescia la divagazione filosofica, la visione ultraterrena nello stretto orizzonte del cortile, comprime e riduce la tensione metafisica nei logori stampi di una trivialità cittadina, quotidiana[7]»:
«Come una silhouette sull’azzurro lunare, / nereggia un ramo in merletto bruciato. / Come un fantasma sei sorto sull’erba, – / come una silhouette sull’azzurro lunare, – / hai levato al fogliame incurante / immote braccia contorte in meandri… / Come una silhouette sull’azzurro lunare, / nereggia un ramo in merletto bruciato. // II Da dietro i tronchi la riviera immemore / dondola chiazze di puntillismo lunare. / Oh, quanto pura, quieta, spensierata / da dietro i tronchi – la riviera immemore! / Oscura arrivasti da lontano / in cerca di oblio, di una sosta alla culla lucente. / Da dietro i tronchi la riviera immemore / dondola chiazze di puntillismo lunare…».
Ecco, dunque che il destino del poeta diviene furtivo e rarefatto. Un’oscura e solitaria lacrima di incontro. Come scagliato dall’abisso respira l’inestinguibilità del suo vocabolo di fuoco, vibrando il suo stelo sottile che non vacilla nell’aria diafana.
Vi è, allora, un offuscamento nel suo gesto lirico che tocca gli occhi esausti degli ardori primaverili: una lunga passeggiata che cerchi pace e possa portare all’anelito dell’anima, come una quieta salmodia di tenebre che risale fino a Puškin.
L’imprevedibilità dei suoi contrasti dissipa gli orientamenti in una calibrata vertigine calante, dove i sogni dell’anima attraversano tende arabescate e segni cifrati che varcano il tempo e lo spazio, fino alla calamità dei cretti:
«È bello che al mondo / ci siano magiche notti, / il ritmico scricchiolio dei pini, / l’aroma di comino e camomilla / e la luna. / È bello che al mondo / ci siano ancora bizzarrie del cuore, / che la principessa, pur senza amare, / conceda un bacio impresso / sulle labbra. / È bello che in forma di ali / sullo stradello d’argento, / si sciolga in ombra lieve, / e oscillando si afflosci, / un nastro nero. / È bello sorridendo pensare / che la principessa (pur senza amare!) / non dimentichi la notte di luna, / né i baci, e me neppure, – / ora né mai!».
Il suo scavo insegue la densità della materia, entrando nella penombra del tempo incerto e maturo, sconfinato nella morte e nel varco della ultimità e del rinnovamento: «Brilla d’oro nel suo palmo il chicco di grano / nella terra nera destinato a cadere. / E là dove cieco il verme si apre il cammino, / in un tempo segreto morrà per germogliare. / Così va la mia anima per la via del grano: / scesa nel buio morrà – per rivivere ancora. / Tu pure, mia terra, e tu con lei, suo popolo, / traversando questo anno morrete a nuova vita, – / poiché una sola saggezza ci fu data: / tutto il vivente vada per la via del grano».
In Chodasevič, troviamo la cifra di un allarme imminente: « Anche in sonno l’anima non ha riposo: / sogna la veglia, inquietante, terrena, / e attraverso il sonno odo un delirio, / che a stento la vita del giorno mi ricorda».
È come se tutta la radiosa trama del paesaggio fosse minacciata da un sabotatore interno, un’anima inquieta, una nera coltre socchiusa e acrobata che disgrega gli inizi di ogni corso segreto, di ogni attesa leggera e di un fuoco che fa chiudere gli occhi:
«Come accade / quando col remo stacchiamo la barca / dalla riva sabbiosa; ancora il piede / tocca netta la terra sotto la chiglia, / e vicino appare il verde della riva, / la catasta di legna; poi una scossa – / e la riva si allontana; più piccolo / si fa il boschetto dove noi vagavamo; / sale dal bosco un fumo; ed ecco – oltre / gli alberi già la radura appare col rosso / capanno termale. / Così me stesso / vidi in quell’istante, come quella riva; / vedevo d’un tratto di lato, quasi / guardassi un poco dall’alto, a sinistra. / Sedevo, le gambe incrociate, sprofondato / nel divano, la sigaretta ormai spenta / tra le dita, pallido e smagrito. / Gli occhi erano aperti, ma la loro / espressione non potevo vedere. / L’altro me stesso, seduto di fronte, / non percepivo. Mentre chi mi guardava, / con occhi forse incorporei, a suo agio / sembrava, leggero e tranquillo. / E l’altro, seduto sul divano, / mi apparve soltanto un amico di sempre, / estenuato da un lungo viaggiare. / Quasi fosse venuto mio ospite, / e, di colpo, ammutolito nel quieto discorso, / scuotendosi, morisse in un solo sospiro. / L’amaro sorriso abbandonava il volto / rasserenato. / Così vidi me stesso per poco: certo / la lancetta dei secondi non aveva / compiuto un quarto del giro dovuto. / E come prima non per mio volere / avevo abbandonato quell’involucro – / così di nuovo vi tornai. Pure / duravo pena e fatica al ritorno, / sgradito persino allo stesso ricordo. / Non diversa angustia patisce e pena / il serpente costretto a inguainare / di nuovo la pelle appena scrollata… / Di nuovo / rividi innanzi a me i libri, / riudii le voci. Mi era fatica / ancora sentire quel corpo, le mani… / Così, lasciati i remi e balzando a riva, / ci sentiamo a un tratto più gravi. / Fluiva in me nuovamente il languore / come di un lungo remare, – nell’orecchio / suonava indistinto un rumore, un’eco / prigioniera di vento lacustre o di mare».
Il suo abito di sogno avverte la ruvidezza del corpo fiaccato e della finitudine. Il suo orizzonte proclama il riflesso di una imminenza di fine frustrata, ricolma di dissonanze e senso disperato: «È la mia anima come una luna piena: / limpida e fredda. / In alto splende e risplende – / né le mie lacrime asciuga; / non si dà pena della mia sventura, / né ascolta il gemito delle mie passioni; / l’anima che brilla non mette cura / a quanto mi fu dato patire».
La luce di Chodasevič diviene un fulcro di gemme flebili e aggrottate, il ricordo del meriggio è materia finita che percorre le linee della immota realtà, il mysterium tremendum il buio di luna verde e anima che vacilla e sgambetta sulla scena azzurro-lunare. È la conclusione della sua nigredo che tutto ammanta e fa perire:
«Ogni suono mi tormenta l’udito, / gli occhi ferisce ogni raggio. / Comincia a spuntare lo spirito / come un dente fora la gengiva gonfia. / Spunterà, spogliandosi della scorza consunta. / In mille occhi svanirà nella notte, / non in questa notte cinerina. / E rimarrò qui lungo disteso – / banchiere trafitto da un apache – / con la mano premendo la ferita, / a gridare e dibattermi nel mondo vostro».
O ancora: « Guardo dalla finestra, e disprezzo, / Guardo me stesso, pure disprezzato. / Invoco tuoni sulla terra, / senza credere al cielo. Avvolto dal fulgore diurno, / vedo solo un buio senza stelle… / Così sull’aiuola si torce il verme, / reciso dalla vanga pesante».
Caterina Graziadei commenta:
«La diffrazione dello sguardo scaturisce da una prospettiva metafisica che altera e separa, sdoppia la realtà. È un demone che propaga dissonanza nell’anima e nei versi del poeta. Ed essa risulta artificio strutturale della poetica di Chodasevič, presiede alla dicotomia dei due emisferi in cui è spezzato il mondo, aiuola dove il poeta si torce come «verme reciso da una vanga pesante» (Guardo dalla finestra, e disprezzo…). Dissonante è l’inframondo terreno, popolato di piccoli demòni stolti, opposto all’empireo inattingibile dell’anima, oppure il quotidiano che d’improvviso irrompe nella speculazione metafisica, secondo uno schema a contrasto in cui spesso la stanza o il distico finali contraddicono il senso dei versi precedenti, con effetto sentenzioso o sarcastico, fissato nella brevità dell’aforisma: «… ma stràppati: pietra da una fionda, / stella, spiccata nella notte… // […] Chissà cosa borbotti fra te e te / in cerca delle chiavi o del pince-nez» (Travalica, trasalta…)».[8]
L’inerzia malevola della realtà stringe gli strati della terra, il fruscìo del requiem, la mano estranea assiderata, dove volge la cifra del tormento flebile come risveglio trascinato e minacciato che affronta gli ossimori di anima e corpo, come un’anamorfica erma bifronte: «Allora le cose attraversano il corpo fisico del poeta e ne invadono, aggrediscono lo spazio interiore, psichico: la centralità dell’io è dislocata ai margini con violenza, il voyerismo è il segno della sua perversione[9]».
La poesia diventa così presagio di angoscia e di pena, un vicolo lontano dove l’acero ingiallisce e il nero cappello si rotola sulla sabbia, e dove «anche attraverso l’afa spiri / dell’Ade la frescura».
Il verso è disadorno e nudo, l’anima essenziale, dimessa e disadorna la linea che prosciuga il vivente in un frattale oppositivo, quasi sentenzioso, per far affiorare la dimensione interna o ciò che si affaccia all’esistere, come può essere una strada.
È il sintomo del suo esilio:
«Alla mia mano non è dato sollevare / il velo dell’occulta Maia, / ma prodigioso un mondo si specchia / nella tua pupilla dilatata. / Là con unione inconcepibile / si palesano l’amore e la strada: / l’ardere dell’etere fiammante / insieme al disgelo di primavera. / Un cosmo luminoso vi affiora / dalla mossa cortina delle ciglia, / vortica e fiorisce come la stella / dei raggi in una bicicletta».
Lì si innerva la sua misura, spesso luttuosa e recisa, dove il mondo ctonio emerge in tutta la sua innervata tenebra, in cui il dialogo con Dio ha il sapore di una consegna di anima che liberi il corpo, nonostante Egli diventi spesso un rivale, divenendo però il tramite per una trasfigurazione simbolica.
Solo lì l’anima acrobata afferma il momentaneo orizzonte della leggerezza, il suo precario spirito che crepita. Chodasevic afferma il suo esilio fioco e orfico: «Risplendi nel fulvo riverbero, / e strida la penna solerte. / Vive nel suo rapido crepitio / tutto l’anelito del mio essere».
L’anima è divisa. Le certezze sono labili come il tempio della vanitas di tutto ciò che c’è, salvate da un lieve affioramento di schegge antiche e pesante lira: «I piedi alla infera fiamma, / la fronte alle stelle vaganti».
È come la sua Pietroburgo disseminata di cielo ed ombre, tramortita dal buio tombale della Russia. Tutte le sue slogature interiori passano da un selciato dismesso, consegnano la lingua umana, contrassegnata da una libertà severa.
La Musa de La notte europea è inquietante, laddove il supplizio sensoriale si esplica nella minaccia della città, nelle sfere estranee dell’essere, nel cielo cieco e nella notte che estende il giorno.
In una tragica Berlino (il poeta l’aveva raggiunta nel 1922 con Nina Berberova), che assomiglia tanto a San Pietroburgo, Chodasevič sente tutto il peso della sua finitudine tragica. Non solo per la conformazione della città e il suo grigio-brunastro invernale, ma per il senso di troncamento, di tenebra e di ombre allungate. Un bagliore secco e fosco che genera doppi, trasfigurazioni mostruose e stridore cacofonico di un mondo altro:
«L’Ade, sempre così prossimo ai versi di Chodasevič, appare adesso come una realtà quasi tangibile, Berlino diviene anche per lui antiporta del Tartaro, prefigurazione dell’Apocalisse che travolgerà l’Europa fatiscente sotto la spinta della nuova barbarie, attesa e preconizzata da alcuni intellettuali europei prima del nazismo. Nella Berlino “meccanica”, come a Saarow, vicino luogo di
villeggiatura dove Chodasevič è ospite di Gor’kij, anche la natura non offre consolazione: è matrigna, infuoca e arroventa una «erba sbiancata, mezzo tramortita», oppure bagna, fradicia, imputridisce».[10]
Nel suo colore smarginato come una sorta di anti-paradiso, nella catabasi di illusione e vitale prospettiva, nella malìa come sospensione fotografica, nello straniamento distorto, Chodasevič colloca la sua creazione ammutolita e il piombo dell’inattingibile sul sogno deluso: «Non è tempo di essere, ma di sostare, / non tempo di vegliare, ma di dormire, / come dorme l’embrione dall’erta fronte, / e nella molle eternità di nuovo / ravvolgersi come dentro un utero».
[1] Chodasevic V.F.., Non è tempo di essere, a cura di Caterina Graziadei, Bompiani, Milano 2019.
[2] Graziadei C., Un’intonazione senile, in Chodasevic V.F.., Non è tempo di essere, cit., p.7.
[3] De Michelis C.G, L’undicesimo poeta russo, in “La Repubblica”, 23 luglio 1993.
[4] Graziadei C, cit., p.7.
[5] Id., La dissonanza nella poesia di Vladislav Chodasevic, in «Europa Orientalis», 4, 1985.
[6] Id., Un’intonazione senile, cit., p.9
[7] Graziadei C., La dissonanza…, cit., p.82.
[8] Id., cit, p.9.
[9] Id., cit., p.84.
[10] Id., cit., p. 11.
Nicanor Parra: il poeta sceso dall’Olimpo
 Nicanor Parra (1914-2018) esplora la prolifica sperimentazione laica della poesia, attraversando la vertigine terragna dell’essere e, come scrive Matteo Lefèvre, nella raccolta L’ultimo spegne la luce[1], appena edita da Bompiani,
Nicanor Parra (1914-2018) esplora la prolifica sperimentazione laica della poesia, attraversando la vertigine terragna dell’essere e, come scrive Matteo Lefèvre, nella raccolta L’ultimo spegne la luce[1], appena edita da Bompiani,
«ha saputo condurre agli estremi le possibilità della creatività in versi, inaugurando il “genere” dell’antipoesia e riuscendo a scardinare dall’interno il sistema delle lettere sudamericane grazie a una beffarda, ostinata azione corrosiva. Ed è andato anche oltre: da questa violazione, dal lavorìo ai fianchi di Calliope e dei suoi sacerdoti e adepti, ha dato vita a un nuovo modo di concepire la scrittura lirica, alimentando una musa prosaica in grado di accogliere nel suo regno quanto in precedenza da esso era proscritto poiché intollerabile a livello di linguaggio e di argomento, inaudito in termini di motivi e protagonisti».[2]
L’erosione della cultura poetica tradizionale, la frantumazionedisincantata della forma lirica, lo scompaginamento della retorica e dello stile, la sapida mordacità, il Cile come patria tracimata (nacque a San Fabián de Alico, vicino a Chillán, nella regione centrale del Paese, da una famiglia della piccola borghesia di provincia) segnano il gesto poetico di Parra, visto non già nell’opposizione poetica, ma come agone a una certa idea paludata di poesia, ristretta in uno stantio e processuale iter poematico, in cui il poeta smette di avere un crisma di profezia, divenendo margine precario e vitale e dando voce alla bellezza impenetrabile delle metropoli latinoamericane, guidato
«dal desiderio sessuale più che dal trasporto amoroso, da una fame picaresca più che dalla coscienza di classe, dal culto dell’opportunità materiale più che da qualsiasi anelito trascendente. Nell’opera di Parra sfila dunque un’umanità sbilenca, spesso senza storia e senza memoria, una moltitudine di figure antieroiche che fanno dei bisogni primari e di un’esistenza ordinaria, triviale, la propria bandiera; e tra costoro si inserisce anche lo stesso autore, il quale nei suoi vari autoritratti si definisce perlopiù come un individuo sgangherato, un uomo qualunque, materiale e prosaico, un soggetto dimesso, nient’altro che un “insegnante in un liceo oscuro”, un impiegato “abbrutito dalla cantilena / di cinquecento ore a settimana”».[3]
Lefèvre afferma ancora:
«I versi di Nicanor Parra mettevano in crisi un sistema che in Cile si era retto per decenni su un comodo, rassicurante equilibrio degli opposti, su un pantheon di figure accreditate che rappresentavano sia la linea conservatrice sia il suo rovesciamento più o meno polemico in nome di uno stanco epigonismo delle correnti primonovecentesche oppure di una poesia organica al dogma politico e sociale di turno. Per intenderci, da un lato resistevano vecchi moduli modernisti accanto ai temi senza tempo della lirica (amore, morte, Dio, natura ecc.), abbinati spesso al culto delle radici storiche del paese e dell’intero continente, dalla mitologia indigena ai luoghi selvaggi della Patagonia; dall’altro si trascinavano stancamente linee di scrittura e compromesso che riprendevano una sperimentazione ormai trita oppure gli assiomi propugnati dall’ideologia, specialmente quella socialista, che cominciava a dare alla letteratura patria anche una visibilità su scala globale».[4]
L’antipoeta è un funambolo provvisorio che abita il ciglio dell’essere, lo vive nel’abisso della dimora e dell’incontro con figure di ogni risma estrema, dove il feroce affresco si unisce al territorio fantasmatico della volubilità, della transitorietà dei passaggi e dell’ontologia distorta.
Il poeta stesso diventa, dunque, persino parodia non di se stesso, ma dell’aurorale sacralità del suo messaggio, inscenando il teatro dei segni, mostrando inquietudine e visceralità, ritratto e acume di sogno caustico.
Nella o-scena demitizzazione della poesia, egli compie un’anti-missione, una vertigine anti-tradizionalista, dove il contrario, l’ossimoro, l’opposizione si aggrappano al relitto divino, allo smascheramento borghese della società, e dei suoi relitti, denudati davanti allo specchio: «Non gettiamoci polvere negli occhi / L’automobile è una sedia a rotelle / Il leone è fatto di agnelli / I poeti non hanno biografia / La morte è un’usanza collettiva / I bimbi nascono per essere felici / La realtà tende a scomparire / Fornicare è un atto diabolico / Dio è un buon amico dei poveri».
L’individuo diviene l’incisione irrigata della realtà, il limen navigato, la meta viandante e spericolata di una umbratile tensione conoscitiva, dove il tessuto paradigmatico e paradossale si spinge oltre l’apparenza, la cifra stilistica e la creazione, per divenire radicata suspension of disbelief.
Parra rappresenta la traslazione della fuga attraverso l’azzardo, l’alternanza di codici, la taglio della poesis, l’embrione della parola corrosiva che si appropria della quotidianità per diventare linea lapidaria e spesso ironica, urgenza e gesto vivente di domanda fino all’oblio azzurro («Oggi di primavera è un giorno azzurro, / Credo che morirò io di poesia, / Di quella malinconica ragazza / Io non ricordo ormai neppure il nome. / So solo che passò per questo mondo / Come una colomba fuggitiva: / Io l’ho dimenticata, lentamente, Come tutte le cose della vita»):
«Questo indistinto signore assomiglia / A una figura da museo di cere; / Guarda attraverso le tendine logore: / Che vale di più, l’oro o la bellezza? / Vale di più il ruscello che si muove / O la pianta ben salda sulla sponda? / In lontananza si ode una campana / Che apre un’altra ferita, o che la chiude: / È più reale l’acqua della fonte / O la ragazza che si specchia in essa? / Non si sa, ormai la gente non fa altro / Che costruire castelli di sabbia: / Conta di più il bicchiere trasparente / O la mano dell’uomo che lo crea? / Si respira una fragile atmosfera / Di cenere, di fumo, di tristezza: / Ciò che è stato una volta non sarà / Più così, dicono le foglie secche. / Ora del tè, pane tostato, burro, / E tutto avvolto come in una nebbia».
Se la ricerca poetica abbraccia ogni contatto, lo svolge attraverso un indocile apprendistato (Huidobro, Pablo de Rokha, Gabriela Mistral e il giovane Neruda, fino ad Alberti e Lorca), avvertito in Cancionero sin nombre (1937), successivamente inizia a comporre la sua fertilità eversiva, come avverrà in Poemas y antipoemas (1954), prima cifra di una luce nuova, in cui emerge il signum contradictionis della sua parola, che unisce oscurità e suolo umano («Guarda la gamba umana che pende dalla luna / Come pianta che cresce verso il basso / Quella gamba temibile che galleggia nel vuoto / Illuminata appena dal bagliore / Della luna e dall’aria dell’oblio!»), come avviene in questo Epitaffio:
«Statura nella media, / La voce né sottile né profonda, / Primo figlio di un maestro elementare / E di una sarta di retrobottega; / Magro fin dalla nascita / Pur se devoto della buona tavola; / Dalle guance scavate / E dalle orecchie piuttosto ingombranti; / Con un volto squadrato / Nel quale gli occhi si aprono a stento / E un naso da pugilatore creolo / Scende a una bocca da idolo azteco / – Tutto questo condito Da una luce tra il perfido e l’ironico – / Né troppo furbo né scemo completo / Io fui così: un misto / Di buon olio da tavola e di aceto / Un insaccato d’angelo e di bestia!».
Parra alterna registri, dall’invettiva al ritorno alla primordialità, dalla meta-letteratura, avvertita nella sotterranea vocazione senza regole, alla instabilità creativa che deve divenire ultimità incresciosa e disposizione umana.
Esiste nella poesia di Parra un conflitto irrisolto tra la pars destruens e quella construens come infinita spaccatura e fuoco solitario. Non solo di stile o lirica che sembrano rinnovarsi e ampliarsi in un gioco linguistico, bensì strutturate o in una luce sinistra, ribelle e scientista (spesso idiosincratica e avversativa, si pensi all’imbonitore di Sermones y prédicas del Cristo de Elqui), o in una istantanea conversativa e distopica, o in una irredimibile confessione che entra nelle trame affettive proponendo la rievocazione, il tempo irriso e riletto.
Il valore del cardine poetico diventa ineliminabile, ma in un contesto comune, nei particolari di ogni giorno, nasce nel cuore del cuore, vive della nudità di spighe e di occhi. È poesia dell’alba, della terraferma. Essa scende dall’Olimpo per porgersi come ombra umana e creaturale di un «rumore moltiplicato dal silenzio: media aritmetica tra il tutto e il nulla».
Il linguaggio si lacera, rappresenta frammenti senza battesimo. In un universo disaggregato, Parra concepisce una salmodia come una lunga sequenza che aggrega polifonie, immagini, sentenze, parola rimestata, numerologie, collage di asprezze e nomi sparsi (Alonso de Ercilla e Gabriela Mistral, Octavio Paz e Juan Rulfo, Ernesto Cardenal, Tomás Lago, Che Guevara):
«Signore e signori / Questa è la nostra ultima parola / – La nostra prima e ultima parola –: / I poeti sono scesi dall’Olimpo. / Per i nostri padri / La poesia è stata un oggetto di lusso / Però per noi / È un bene di prima necessità: / Non possiamo vivere senza poesia. / A differenza dei nostri padri / – E dico questo con tutto il rispetto – / Noi sosteniamo / Che il poeta non è un alchimista / Il poeta è un uomo come tanti / Un muratore che costruisce un muro: / Un costruttore di porte e finestre. / Noi conversiamo / Nel linguaggio di tutti i giorni / Non crediamo in segni cabbalistici».
Matteo Lefèvre commenta:
«Il valore essenziale della poesia, qui accostato a un “bene di prima necessità”, è ricondotto nell’alveo della normalità, delle urgenze concrete dell’essere umano e coincide altresì con un provvidenziale abbassamento della missione dell’artista, a cui non si tributa un sovrappiù di responsabilità morale o anche solo estetica rispetto alla massa; nell’antipoesia non c’è spazio per alchimie linguistiche e concettuali né per alcun privilegio di casta, poiché il poeta “è un uomo come tanti”, è aperto alla vita, al lavoro e alla lingua di tutti i giorni».[5]
La morte rappresenta, come affermato anche da Roberto Bolaño, il segmento apotropaico di una rivelazione che, ironicamente, data anche la longevità dell’autore, diventa una consegna, una smorfia, una sottile concessione. O come accade nei 4 Sonetti dell’Apocalisse, una interminabile successione di croci si evidenzia sulla pagina. L’intima espressione di un sacrificio segnico. Il cuore di una scrittura finale.
[1] Parra N., L’ultimo spegne la luce, traduzione e cura di Matteo Lefèvre, Bompiani, Milano 2019.
[2] Lefèvre M., Un antipoeta alla corte della poesia, in Parra N., L’ultimo spegne la luce, cit.
[3] Id., cit.
[4] Id., cit.
[5] Id., cit.
Ashbery J., Autoritratto entro uno specchio convesso, a cura di Damiano Abeni, con uno scritto di Harold Bloom, Bompiani, Milano 2019, pp. 240, Euro 18.
Chodasevic V.F.., Non è tempo di essere, a cura di Caterina Graziadei, Bompiani, Milano 2019, pp. 400, Euro 20.
Parra N., L’ultimo spegne la luce, traduzione e cura di Matteo Lefèvre, Bompiani, Milano 2019, pp. 432, Euro 20.
Ashbery J., Autoritratto entro uno specchio convesso, a cura di Damiano Abeni, con uno scritto di Harold Bloom, Bompiani, Milano 2019.
Chodasevic V.F.., Non è tempo di essere, a cura di Caterina Graziadei, Bompiani, Milano 2019.
Parra N., L’ultimo spegne la luce, traduzione e cura di Matteo Lefèvre, Bompiani, Milano 2019.
De Michelis C.G, L’undicesimo poeta russo, in “La Repubblica”, 23 luglio 1993.
Graziadei C., La dissonanza nella poesia di Vladislav Chodasevic, in «Europa Orientalis», 4, 1985.
Moscardi I., Due poeti (e un antipoeta), in “Corriere della Sera – La Lettura”, 8 settembre 2019

























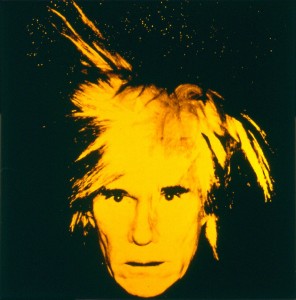







 La Clairvoyance è un autoritratto ad olio su tela del 1936 di Magritte. René Magritte (belga, 1898-1967) è il pittore contemporaneo più discusso, studiato e interpretato al mondo. La sua adesione al surrealismo è il movente per fare della sua arte un ampio scenario simbolico, linguistico, onirico e metaforico, prestandosi ad ogni forma di interpretazione psicoanalitica, di diagnosi per lo più ispirate alla dinamica, peraltro assai congrua, del trauma della morte della madre, avvenuta in circostanze mai del tutto chiarite.
La Clairvoyance è un autoritratto ad olio su tela del 1936 di Magritte. René Magritte (belga, 1898-1967) è il pittore contemporaneo più discusso, studiato e interpretato al mondo. La sua adesione al surrealismo è il movente per fare della sua arte un ampio scenario simbolico, linguistico, onirico e metaforico, prestandosi ad ogni forma di interpretazione psicoanalitica, di diagnosi per lo più ispirate alla dinamica, peraltro assai congrua, del trauma della morte della madre, avvenuta in circostanze mai del tutto chiarite.




