di Irene Battaglini
Prato, 30 settembre 2013

«Art is the triumph over chaos». John Cheever, The Stories of John Cheever (1978)
articolo in pdf IL GESTO IN PIENA DI CY TWOMBLY




The Four Seasons: Spring, Summer, Autumn, and Winter. 1993-94, Synthetic polymer paint, oil, house paint, pencil and crayon on four canvases
L’arte di Cy Twombly è un grido sull’America. Un richiamo di sangue e di cieli densi di fiori che si rompono in un boato crespo di farfalle contaminate. La sua pittura è un fiotto che rompe gli argini dell’armonia, è un soffio che imprime voli per mete non raggiunte, non possibili. La pittura di Twombly (Virginia, 1928-Italia 2011), esprime il fallimento delle utopie moderniste. Illeggibile, incoerente, improbabile. Eppure è vera e bellissima. Bisogna capire come sia stato possibile creare questa unione violenta e irreversibile, come un aereo in velocissima precipitazione che prende fuoco sulla coda, e nell’atto di avvolgersi su di sé diventa una stella cometa. Quadri di una straordinaria epifania cromatica, di luce che esplode. In cui segni, colori e forme sono gli strumenti dell’agrimensore in un pianeta desertico di cui scongiura l’imminente deflagrazione. Sono il canto e la preghiera di un ultimo uomo verso Dio i cui occhi, che per dirla con McCarthy, un altro americano dignitario della più alta contemporaneità, «tradivano non disperazione, ma soltanto quell’insondabile, profonda solitudine che è l’impronta più tipica di questo mondo». (da Oltre il confine)
Tutta l’arte di Cy Twombly (pittore, incisore, disegnatore, scultore) è notte inoltrata che deflagra nell’aurora, è il “linguaggio dimenticato” di Erich Fromm su una lavagna stridente, è ardesia che si sbriciola a creare forme improbabili, è gemmazione di scarabocchi di luce bruciante dalle forme svelte, come le braccia di un nuotatore esperto che farfugliano nell’abisso e che nell’inconscio tumulto non smarriscono – nello smarrirsi – l’eleganza di quanto hanno appreso.
Il “quadro” deciso da Cy Twombly è una forma concreta di non-pittura, è una decisione spasmodica di andare verso la crisi linguistica e di immergersi in questo spasmo come all’imbocco della neoplasia che ha corroso velocemente l’universo percettivo del cui declino siamo attori, costretti alla visione monoculare della realtà dell’emarginazione o alla confusione conglobante e regressiva dei social-network. È una pittura di voci che si affollano ad un crocevia, dove è obbligato a stare l’artista contemporaneo che deve organizzare e riorganizzare continuamente immagini, metafore e rappresentazioni nella stanza della propria coscienza, che si affligge del proprio paradosso esistenziale, per dover essere nello stesso tempo figlio e dio, creatura e creatore.
Cy Twombly sembra aderire, per far fronte allo stress della devastante mitologia unilaterale del mondo contemporaneo, ad una tradizione “anticreativa”, come se il suo atelier fosse una prestigiosa accademia in cui lo scranno più alto è perennemente disabitato. La sua originalità è così potente che deve per forza nascondersi a se stesso, per capire qualche cosa della sua stessa talentuosa e indisciplinata arte del segno. La tecnica che lo vuole maestro nello sfocare la linea del contorno dal disegno è l’espressione di una strategia di attacco ai fianchi dell’ortodossia, è un modo per dire che l’infante è più indipendente del dio e più arrogante, più violento, più demoniaco. Del resto, il desiderio di unione deve essere spostato in una fuga in avanti verso la dimora della perfezione, verso la quale il puer muove con incessanti cadute e inappagato desiderio.
La proiezione sul futuro, su quello che sarebbe stato un disegno di Cy Twombly se egli ci avesse donato le forme belle del suo immane talento pittorico a detrimento della sua scelta di uomo autentico che decide di farsi scenario del mito della luce del mondo post-industriale, comincia già a costellarsi nel controverso ambiente del ventre materno dell’espressionismo, in cui nascono le sue prime opere, non in ordine ad una casualità, ma ad un divenire in prospettiva mitica del dramma della propria vita lacerata in cui segno e disegno, contorno e ombra, sono scissi eppure appaiati in un affiancamento in cui sembrano alloggiare danzatori solitari. Dice Adolf Guggenbühl-Craig nel libro Il bene del male. Paradossi del senso comune (Moretti&Vitali, 1998, pp. 27 e 28):
«Abbiamo [quindi] a che fare con due tradizioni: da un lato la creatività viene fatta oggetto di ammirazione, dall’altra essa viene ritenuta un attributo esclusivo di Dio e, per quanto riguarda gli uomini, la si considera soltanto una forma di hybris, di tracotanza. Sia quel che sia, con la creatività noi giungiamo faccia a faccia con Dio. E che cosa succede con l’indipedenza? Sicuramente possiamo ritenere che l’unico essere davvero indipendente in questo mondo sia Dio. Per definizione Dio è indipendente da tutto e da tutti, e tutto è dipendente da lui. Egli è l’inizio e la fine, alfa e omega del creato; […]. Noi stessi cerchiamo di raggiungere questo tipo di divinità, cadiamo vittima del complesso di Dio».
La prospettiva mitica fu, per Twombly, forza e sembianza, significato e bellezza. Il pittore amava nutrirsene, e fare dei suoi disegni “veicoli per contenuti letterari”,[i] dai quali cercava di liberare le figure.
L’opera di Twombly, se fosse tutta ordinata su piani paralleli, mostrerebbe una morfologia simile ad una stratificazione geologica intra-psichica in cui sembrano essersi fissati i marcatori del processo alchemico. Gli esordi, agli inizi degli anni ’50, sono connotati dall’influenza di Kline e Paul Klee, e sono prevalentemente pennellate gestuali-espressioniste, in un originale e morbido intreccio di tratti, parole, numeri e porzioni (“frazioni”) di oggetti. È molto attratto dall’Italia, dove si stabilisce definitivamente nel 1960, anno in cui allestisce la prima mostra alla Galleria di Leo Castelli.
 Gli anni ’60 sono caratterizzati dai cosiddetti “Quadri della Lavagna”, opere di grande dimensioni in cui usava la tecnica calligrafica dei graffiti su sfondi solidi di colore grigio, marrone o bianco (una tecnica a metà tra la pittura e l’incisione), in cui la scrittura viene svestita del suo ruolo comunicativo e trasferita nel campo semantico del gesto, fino a costellare appieno l’action painting, ricco di citazioni come Leda e il cigno (1962, fig.1) o la famosa battaglia di Lepanto. In questo periodo, che è estremamente proficuo, comincia a creare le sue prime sculture astratte, le quali, sebbene varie nella forma e nel materiale, erano sempre ricoperte di pittura bianca. Twombly utilizzerà (e sarà scultore di quest’arte povera per tutta la vita) materiale preso a prestito dal fabbro, dal maniscalco, dal falegname, per dare altezza a forme semplici dalla struttura assemblata, a ricordare l’arte dei mastri antichi nel forgiare gli strumenti del lavoro: un omaggio alle cose, che si liberano della condizione di oggetti utili (come le lettere e la parola scritta) per diventare il simbolo del proprio servilismo: l’oggetto svilito dalla sua destinazione strumentale diventa un soggetto di bellezza silenziosa e perenne, come in un processo di mummificazione, in cui gesso, vernice, legno, cartone, metallo, carta, stoffa, spago, matite, diventano elementi del lavoro manuale che, ricoperti di vernice bianca e opaca, subiscono l’ultimo trattamento immortale.
Gli anni ’60 sono caratterizzati dai cosiddetti “Quadri della Lavagna”, opere di grande dimensioni in cui usava la tecnica calligrafica dei graffiti su sfondi solidi di colore grigio, marrone o bianco (una tecnica a metà tra la pittura e l’incisione), in cui la scrittura viene svestita del suo ruolo comunicativo e trasferita nel campo semantico del gesto, fino a costellare appieno l’action painting, ricco di citazioni come Leda e il cigno (1962, fig.1) o la famosa battaglia di Lepanto. In questo periodo, che è estremamente proficuo, comincia a creare le sue prime sculture astratte, le quali, sebbene varie nella forma e nel materiale, erano sempre ricoperte di pittura bianca. Twombly utilizzerà (e sarà scultore di quest’arte povera per tutta la vita) materiale preso a prestito dal fabbro, dal maniscalco, dal falegname, per dare altezza a forme semplici dalla struttura assemblata, a ricordare l’arte dei mastri antichi nel forgiare gli strumenti del lavoro: un omaggio alle cose, che si liberano della condizione di oggetti utili (come le lettere e la parola scritta) per diventare il simbolo del proprio servilismo: l’oggetto svilito dalla sua destinazione strumentale diventa un soggetto di bellezza silenziosa e perenne, come in un processo di mummificazione, in cui gesso, vernice, legno, cartone, metallo, carta, stoffa, spago, matite, diventano elementi del lavoro manuale che, ricoperti di vernice bianca e opaca, subiscono l’ultimo trattamento immortale.
Nella metà degli anni ’70 Twombly realizza opere “multistrato”, vere e proprie creature che rappresentano la piena realizzazione del suo repertorio anticonvenzionale, costruite assemblando il collage di fogli ad altri media pittorici.
Gli spazi “vuoti” sono il collante necessario al dipanarsi di una creatività splendente, che attinge spietatamente alla linguistica, piratandone i sistemi di base. Il segno diventa “lemma” e spesso è contratto in un calco filologico: come se un bambino geniale avesse la capacità improvvisa di comunicare attraverso un linguaggio in cui verbo e immagine convergono in una bocca vulcanica fatta di meraviglie e di delicatezze, che vengono alla luce con estrema cura, a volte con riferimenti geografici, come la serie dei quadri Bolsena (il lago vulcanico vicino a Viterbo).
 In questi lavori, gli elementi grafici si fondono con forza tecnica sempre più rilevante in una sorta di dissoluzione vorticosa, di totale imprendibilità, ma sono talvolta caratterizzati da un nitore fantasmatico, come una sorta di alfabeto decifrabile dalla perizia di pochi eletti, come ad esempio in Apollodoro, (fig. 2), fino a raggiungere negli anni ’90 l’acme estetico di eleganti esemplari floreali che in qualche modo lo ricongiungono, in una sorta di re-unione con il principio, ai Fauve che ne connotarono gli inizi del percorso mezzo secolo prima, nel periodo americano, in cui fu della scuola dei grandi Robert Rauschenberg e Jasper Johns.
In questi lavori, gli elementi grafici si fondono con forza tecnica sempre più rilevante in una sorta di dissoluzione vorticosa, di totale imprendibilità, ma sono talvolta caratterizzati da un nitore fantasmatico, come una sorta di alfabeto decifrabile dalla perizia di pochi eletti, come ad esempio in Apollodoro, (fig. 2), fino a raggiungere negli anni ’90 l’acme estetico di eleganti esemplari floreali che in qualche modo lo ricongiungono, in una sorta di re-unione con il principio, ai Fauve che ne connotarono gli inizi del percorso mezzo secolo prima, nel periodo americano, in cui fu della scuola dei grandi Robert Rauschenberg e Jasper Johns.
Un esempio folgorante è quello delle Quattro Stagioni, giganteschi pannelli che sembrano dimorare tra lo spazio scenico e quello architettonico, in una sorta di danza dei colori che si raccordano in chiazze in perenne tentativo di scendere verso il basso, trattenute contro la tela da invisibili fili, come mani che tentano di mitigare l’urlo di una dea di bellezza arcaica, maestra delle pitture rupestri.
L’ interno delle tavole è carico di una fortissima tensione, di una conflittualità invadente e di una cripticità linguistica che rimanda alla costante alternanza tra violenza e silenzio, tra sessualità e gioco, tra luce e fondale, in un rapporto emotivamente coinvolgente con lo spettatore: al quale non è difficile desiderare di balzare dentro il quadro e affondare gli occhi in quel coacervo di colore.
I fiori sono, in alcuni lavori, vere e proprie esplosioni e non è un caso se appartengono all’ultima parte del viaggio pittorico di Twombly. Artista ricchissimo e avido, così viene descritto, non fu mai collocato dalla critica americana nella Pop Art; questa sua ostinata originalità stilistica fu la sua fortuna: i suoi quadri sono valutati milioni di dollari e ambiti dai maggiori galleristi.
Non essendo “schematico”, si può solo ripercorrere a ritroso il suo progetto e intercettarne alcune coordinate, con una visione dall’interno, che sembra l’unica via percorribile, proprio come farebbe quello spettatore curioso e invadente. E tornando a quel processo alchemico stigmatizzato nella geologia delle opere, non è difficile individuare un alternarsi di strati di bianco, di rosso, di nero. La qualità dinamica dell’opera di Twombly si interseca con quella statica di depositaria del messaggio, è quindi un’opera magistrale che separa l’oro dal fango, e aggiunge un’aura di mistero e di sapienza, per quella inusuale competenza del maestro a rendere coscienti e ricchi sia il nero che il rosso l’uno dell’altro, stretti al confine tra il simbolico e l’astratto, uniti dall’invisibile catena dell’espressione del colore in piena luce, che sembra poter dire tutto, ma che di fatto rimanda sempre ad altro in un infinito specchio di rappresentazioni.
La catalogazione in “espressionismo”, infatti, è sempre relativizzante, perché non fa altro che dire continuamente che sotto l’espressione c’è una volontà di manifestare, di dire, di esprimere. Il messaggio “espresso” da Twombly è ancora totalmente indecifrato. Un’idea, un desiderio, di destituire il mito restituendo al sogno gli eroi e le anfore di un tempo passato.





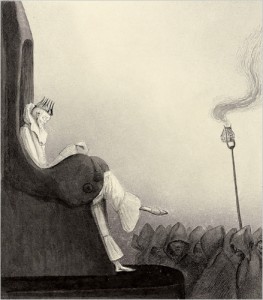 La vera funzione dell’Arte è rivelare la bellezza nascosta, l’impronta divina che è in tutte le cose.
La vera funzione dell’Arte è rivelare la bellezza nascosta, l’impronta divina che è in tutte le cose.
