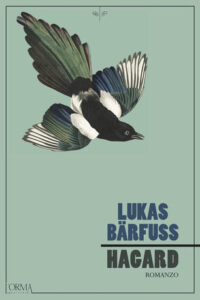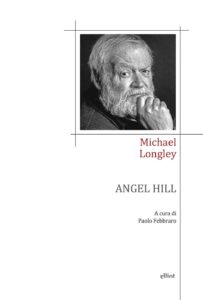di Irene Battaglini 29 aprile 2021
leggi in pdf HAGARD, LO SGUARDO DEL FALCO
autore Lukas Bärfuss
collana Kreuzville
editore L’orma
pagine 120
pubblicazione 03/2021
ISBN 9788831312592
Don Juan affermò che per vedere si deve prima fermare il mondo. Insomma, fermare il mondo era un’interpretazione corretta di alcuni stati di consapevolezza nei quali la realtà della vita quotidiana è alterata perché il flusso dell’interpretazione, che in genere scorre ininterrotto, è stato arrestato da un insieme di circostanze estranee a quel flusso. Nel mio caso, l’insieme di queste circostanze era la descrizione magica del mondo”. Così scrive Castaneda in Viaggio a Ixtlan[1]. Quello di Philip è una discesa agli inferi, guidato dal “demone” Hagard, nei sottofondi degradati di umanità e di cemento di una città il cui nome è una coordinata fantasmatica, e che in questo mirabile romanzo diventa lo scenario – a tratti magico, a tratti patetico – da cui si dipana la “via di conoscenza” di un uomo di carattere, codificato da una nevrotica contemporaneità, il cui flusso di coscienza, tenuto insieme senza alcuna presenza di sé, è interrotto da una chiamata inattesa all’individuazione.
Dire della trama, non servirebbe: si tratta di una rete a maglie larghe, di una vera e propria ragnatela, parafrasando Mario Lavagetto, di piccoli indizi, dai quali emerge la vertigine della libertà di Philip, il cui destino si compie sgretolandosi, e che attraverso una sarabanda di ricordi frammentari, ammonimenti superegoici e salti temporali, stabilisce di intraprendere un gioco di scacchi con la vita. Tuttavia la questione del destino di Philip potrebbe essere il canovaccio narratologico intessuto da Lukas Bärfuss per arrivare al cuore del problema: la vita di un uomo, indipendentemente da come possa essere vissuta, per chiarire la sua domanda di senso deve essere raccontata da chi ne sa seguire lo sguardo. Ha bisogno di un narratore al corrente degli antecedenti, delle variazioni di accordi, delle conseguenze delle scelte: lo stile di uno scrittore è, anche, il suo punto di vista. Non dico le sue opinioni, o il suo sistema di valori, e nemmeno la maestria: dico il vertice – in questo caso una mappa di vertici mobili che danzano forsennatamente – dal quale osserva. Quale piano, da quale orbita decide di salpare, da quale porta ci fa entrare, per seguire la “caccia” di Philip alla donna dalle ballerine color prugna, con le gambe di gazzella, il volto d’oro e invisibile, e il corpo flessuoso di passi che “sentono” il mondo?
“Hagard” indica quel falco che, nonostante sia tratto in cattività, non si lascia addomesticare completamente: è dunque un falco la cui natura selvaggia è solo parzialmente mitigata e maldisposta alla sudditanza.
Lo sguardo di Lukas Bärfuss è di falco libratore. I falchi «libratori» catturano la preda a terra, dopo aver perlustrato il territorio librandosi immobili nell’aria, oppure calandosi in picchiata da un “punto di vedetta”: un punto di vista, alto, molto più in alto di quello della maggior parte di coloro che si avvicendano nelle infinite traiettorie del mondo. Scrisse il drammaturgo svedese August Strindberg: “Lo sa lei come si vede il mondo dal basso? No, lei non lo sa. Agli sparvieri, ai falchi di rado gli si vede il dorso: volano troppo alti” [2], e ancora: “Abituati a osservare il mondo a volo d’uccello, e vedrai allora che tutto ti sembrerà piccolo e insignificante”[3].
Il lettore di Hagard – il romanzo laureato nel 2019 dal prestigioso premio Georg Büchner dell’Accademia Tedesca per la Lingua e la Letteratura (premio istituito nel 1951 e già assegnato a scrittori, tra gli altri, del calibro di Ingeborg Bachmann e Christa Wolf, Celan, Dürrenmatt, Thomas Bernhard, Elias Canetti, Günter Grass) si farà certamente catturare dall’occhio – che riscrive un mondo – di Lukas Bärfuss: un romanziere dal calibro introverso e disilluso alla Joseph Conrad, dal cuore emorragico di Jean-Claude Izzo, e dalla irredenta solitudine contemporanea di John Cheever.
Il respiro di Philip è affannato come di un lupo della steppa, è attento e circospetto, è solitario e affilato: la paura delle avversità (numerose, in cui si imbatte per non perdere di vista la bellissima creatura, “la dea” dalle ballerine color prugna) è una emozione primitiva che determina il rango del rapace, non la debolezza del suo cuore di fiera: si tratta di gestire eventi in rapida successione, come se il nastro della corsa si svolgesse dai fotogrammi opachi dei finestrini di un treno affannato, semivuoto, attanagliato ai binari eppure in una sequenza decisiva degna di un thriller psicologico, intriso di odori e da un immaginario tracciato erotico, con cui l’autore ammanta la mappa spietata delle molteplici realtà in cui si imbatte: si tratta di stati dell’essere che Philip, il protagonista, sperimenta per la prima volta grazie all’incontro con la donna-Anima, della quale non “vede”, suo malgrado, la natura selvaggia di Hagard, il falco non addomesticabile. Il suo sguardo, lo stile narrativo che sorvola e si libra, che si eleva e si staglia, che stana e che sovrasta e poi si avvicina come in una presa diretta, che memorizza volti e dettagli, che registra minacce, pericoli, è come di un falco su un territorio di caccia metropolitano, tuttavia all’acume della sua pupilla sfugge proprio la natura di ciò che rincorre: la creatura leggiadra è un’Anima della selva, che scompare tra gli alberi – come tra i vetri di un edificio -, si nasconde al tramonto in lividi appartamenti, paludi dell’essere entro cui sconfinano binari e fiumiciattoli sotto basse nuvolaglie che ricordano la Fiandra investigativa, pressante e annoiata, di Georges Simenon.
Philip è costretto, suo malgrado, a conoscere lo spirito putrescente dei “non-luoghi”, quegli spazi non identitari della sur-modernità, che nel suo volo incalzante verso l’infinito, braccando un’Anima indomita infilata in “soffici calze”, diventano, in una magica metonimia retrograda, i non-luoghi della sua psicologia individuale in eclissi, rappresentativi di un Sé acerbo, emotivo, sanguigno, che si sveglia al mondo: cespugli e reti, marciapiedi senza strade, opachi ristoranti, grigi scannatoi di provincia, scale mobili sospinte da gelidi nastri, caffè consumati freneticamente in maleodoranti sottopassi, metropolitane glaciali popolate da figure retoriche – ossimori indossati da uomini senza qualità come controllori e bigliettai o manager azzimati -, corridoi di anonimi condomini, self-service per la colazione popolati da uomini e donne che assomigliano ad allevamenti di pesci insipienti. Troviamo in “Hagard”, ad esempio, quadri che sono insieme sia di ridondanza analitica sia di estrema sintesi:[4]
“Quella razza Philip la conosce bene. Piccoli boia, scorticatori incaricati di tormentare il prossimo con strumenti quali i titoli di credito, le fatture scadute, l’ufficio fallimenti, la bancarotta; e ovviamente con la voce gracchiante, le vocali aguzze, le lunghe sibilanti. […] Dunque nell’edificio non ha sede un’unica azienda. È un immobile con molte utenze e molti affittuari. Studi di ingegneria, spedizionieri, contabili, call-center, forse persino ditte di import-export. Nella corte sembra esserci una tipografia. La ragazza potrebbe passare la giornata nei modi più disparati. Ma nessuno pare appropriato. È uno stabile privo di qualunque classe. La dea esige un tempio. Un intero piano come regno. La regina ha bisogno di ampi spazi. Ha la sua propria andatura e la deve tenere in esercizio, lui ne è testimone. Gli è impossibile immaginarsela tutto il giorno china su una scrivania. Forse lavora camminando, sfila da un tavolo da disegno all’altro con la matita tra le labbra. O altrimenti? Accoglie i clienti? Ripone negli armadi le pratiche lasciate in giro dai colleghi? Prepara la sala riunioni? Sistema la frutta? Cambia l’acqua ai fiori? Oppure il sorriso e il portamento sono le sue sole mansioni? È del tutto indifferente. A Philip basta poterla vedere. Ed è proprio quello che non sta facendo”.
Nonostante il velo manifesto sia sfrangiato e ripido, è proprio il grado simbolico di questa realtà finalmente fruibile che Philip apprezza: ora il suo passo veloce e il suo pensiero torrido possono appoggiarsi su una nuova rappresentazione del mondo grazie all’incontro con la provvisorietà. O meglio, grazie alla provvisorietà dell’incontro con una donna che nessun luogo abita: una donna i cui tacchi sono magici piedistalli dalle sette leghe, implacabile e vorace di tempo, una donna che sa il mondo, e che decide di non abitarlo mai abbastanza a lungo da poter restare impigliata in una trappola: è lei il vero cacciatore vigile, colei che, come direbbe Don Juan, assomiglia a quei “vecchi stregoni che avevano una fluidità favolosa. Bastava solo il più lieve spostamento del loro punto di unione, il minimo accenno percettivo ispirato dal Sognare, perché fossero subito in grado di tendere un agguato alla percezione, risistemare la loro coesione in modo da adattarla al nuovo stato di consapevolezza, ed essere un animale, un’altra persona, un volatile, o qualsiasi cosa”. [5]
È lei, la Dea dalle Ballerine Color Prugna, un Orfeo che non si volta, che non tentenna, non dubita, non cede il passo ai quesiti inattendibili: ed è per questo che è lei a salvare Philip da un destino che, altrimenti, sarebbe stato di eterna nostalgia per una vita altrimenti mai vissuta.
[1] Carlos Castaneda,Viaggio a Ixtlan (Journey to Ixtlan, 1972)
[2] August Strindberg, La signorina Julie, 1888
[3] August Strindberg, La stanza rossa, 1879
[4] Lukas Barfuss, Hagard, 2019, p. 104-105
[5] Carlos Castaneda, L’arte di sognare (The art of dreaming, 1993)