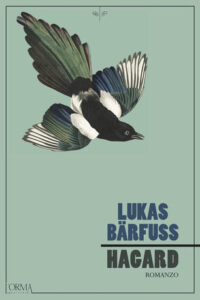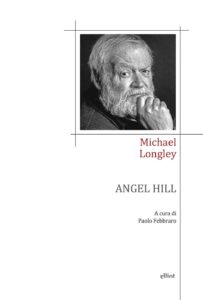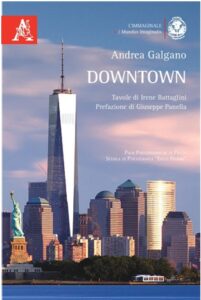di Andrea Galgano 13 febbraio 2021
leggi in pdf La scena di Pedro Calderón de la Barca
 Il saggio di Fausta Antonucci, docente di Letteratura Spagnola all’Università Roma Tre, Calderón de la Barca, edito da Salerno Editrice, offre la possibilità di approfondire l’opera dell’autore spagnolo in tutta la sua interezza, come portatore di una scena che raccoglie gli splendori del siglo de oro, fino all’intimità del raccoglimento, allo spazio del tempo in cui l’io si svolge senza residui e all’infinito universo della sua scrittura, che crea un mondo osmotico di registri e cromature linguistiche, per restituire la potenza umana del suo teatro, ancora troppo sconosciuto in Italia:
Il saggio di Fausta Antonucci, docente di Letteratura Spagnola all’Università Roma Tre, Calderón de la Barca, edito da Salerno Editrice, offre la possibilità di approfondire l’opera dell’autore spagnolo in tutta la sua interezza, come portatore di una scena che raccoglie gli splendori del siglo de oro, fino all’intimità del raccoglimento, allo spazio del tempo in cui l’io si svolge senza residui e all’infinito universo della sua scrittura, che crea un mondo osmotico di registri e cromature linguistiche, per restituire la potenza umana del suo teatro, ancora troppo sconosciuto in Italia:
«Le ragioni sono da rintracciare nel tenace pregiudizio ideologico che vede nella sua drammaturgia l’espressione di una visione del mondo che poco può dire alla nostra modernità; o nel pregiudizio critico altrettanto tenace nei confronti della grande poesia barocca; infine, non da ultimo, nella scarsità di traduzioni moderne, perché mentre il testo originale rimane vivo come tutti i classici, le traduzioni – abbondanti ancora nell’Ottocento – invecchiano irrimediabilmente in fretta». (p.7)
La mescolanza di comico e tragico, che si innerva nella costituzione del teatro spagnolo, compone le trame del teatro di Calderón, specie nelle prime prove, dall’assedio, colmo di equivoci, di Juda Macabeo, all’equilibrio storico, relazionale e sospeso di La gran Cenobia, al rapporto tra vittime e carnefici di La cisma de Ingalaterra e al rapporto tragico de El príncipe constante, fino alle passioni violente di La devoción de la cruz e sostanzia
«un paradigma composto da una serie di elementi caratterizzanti, sostanzialmente dei marcatori generici, ciascuno dei quali attiva nel destinatario il riconoscimento del modello di riferimento, e dunque un orizzonte di attesa, tanto più sicuro quanti più elementi del paradigma il testo subisce. Su questi elementi (protagonisti di altissimo rango; repentini mutamenti di fortuna; sogni, presagi nefasti, apparizioni; scene di violenza; pianti e dolore esibiti in scena; materia epica e storica; stile elevato; finale infelice […]» (pp. 50-51).
Tra fiaba, simbolo e polimorfismo di esiti, il suo teatro assimila appieno la tradizione gesuitica, seppure attraverso mediazioni, affermando un punto focale nell’uomo e nelle sue possibilità, nella ragione e nella bontà, nel turbamento dell’equilibrio instaurato da Dio, in una prospettiva fratturata e sghemba di salvezza.
Quando Don Chisciotte si trova nella caverna, dopo essersi legato con una corda e scomparso tra i rovi, i suoi amici lo trovano tramortito. Destatosi, afferma che nella caverna «todos los contentos desta vida pasan como sombra y sueño». La vera vita è un’altra, è altrove e il presente ha la consistenza di un sogno
Con la commedia La vita è un sogno, Calderón ci mette davanti agli occhi un interrogativo estremo e ultimo sulla stoffa del nostro essere e sulla sua intima e peculiare natura. Un immaginario re di Polonia, Basilio, esperto e studioso di astrologia, alla nascita di suo figlio Sigismondo, ha previsto che questi sarebbe stato un ribelle, un uomo prepotente e sanguinario, e che avrebbe obbligato lui, suo padre e suo re, a prostrarsi ai suoi piedi e cedergli il trono.
Per evitare che ciò accada lo fa rinchiudere in una torre sperduta, «un rustico palazzo, così poco elevato che non riesce a mostrarsi al sole», dove un «fioco lume, quella tremula fiamma, quella pallida stella che con incerti bagliori, palpitando di luce timorosa, rende ancor più tenebrosa la stanza buia con insicura luminosità».
Egli cresce, incosciente, sotto la custodia di Clotaldo, gentiluomo di corte, che lo istruisce alla religione cristiana e alle scienze naturali. Incatenato e vestito di pelli, si interroga sulla sua condizione:
«Ah sventurato me! Oh me infelice! O cieli, poiché mi trattate così, pretendo sapere che delitto ho commesso contro di voi con la mia nascita; quantunque capisca che col nascere ho già commesso un delitto; e la vostra condanna, il vostro rigore hanno avuto un motivo sufficiente, perché il maggior delitto dell’uomo è quello d’essere nato. Vorrei solamente sapere, per spiegarmi le mie pene (lasciando da parte il delitto di nascere), in che modo ho potuto più degli altri offendervi perché debba essere castigato più degli altri. Non nacquero gli altri?».
Rosaura, all’inizio figlia non riconosciuta dello stesso Clotaldo, travestita da uomo, a dorso di un ippogrifo («Ippogrifo violento, che corresti a gara col vento, dove, fulmine senza fiamme, uccello senza penne colorate, pesce senza squame e bruto senza istinto naturale, nel confuso labirinto di queste nude rupi ti sfreni, ti avventi, ti precipiti?») raggiunge la torre, trovandosi poco dopo sbalzata tra le rocce.
Lì scopre la prigione di tenebra del figlio del re, finendo per ascoltare i suoi disperati lamenti. All’inizio egli la minaccia e la scaccia, poi quando lei gli dice che è lì per volere del Cielo, la sua supplica e la sua grazia e la sua bellezza lo trattengono. Subito dopo, però, le guardie la trascinano via, Sigismondo invece, è ricondotto in prigione. Basilio, intanto, agitato e dubbioso sulla sua scelta, fa addormentare suo figlio e lo fa portare a corte, al risveglio il regno sarà suo. Risvegliatosi, diviene davvero, suo malgrado (inducendo Basilio ad aver ragione sugli astri), tirannico e quel potere lo induce a dominare anche se stesso.
Rimane solo un attimo di estasi, dinanzi alla soavità maestosa di Rosaura, uno scorcio di veduta platonica del reale che risveglia le idee. Dopo aver fatto riaddormentare Sigismondo, Basilio lo fa riportare nel carcere dove è cresciuto. Destatosi, racconta il suo sogno: «Sono dunque tanto simili ai sogni le glorie, che quelle reali sembrano false, e quelle simulate vere? Così poca differenza c’è tra le une e le altre, che si deve discutere per sapere se ciò che si vede e si gode è verità o menzogna?».
Quando Basilio annuncia di aver designato al trono i nipoti Astolfo ed Estrella, il popolo insorge in favore di Sigismondo, lo libera e lo proclama re di Polonia: «Che mai succede, mio Dio? Tu vuoi che un’altra volta io sogni grandezze che poi il tempo distrugge? Un’altra volta tu vuoi che fra ombre e immagini io veda la maestà e la pompa che il vento disperde?».
Ma il confine labile e sottile tra il sogno e la realtà si offre al richiamo di giustizia e di bontà: «O fortuna, andiamo dunque a regnare. Non destarmi se io dormo; e se è realtà quel che mi accade, fa’che io non mi addormenti. Ma realtà o sogno, quel che importa è di operare bene; se è realtà, perché è realtà; se no, per acquistare amici per quando ci sveglieremo». (atto iii, sc. IV)
La vita è un sogno è il sintagma di un dramma di esperienza e rinuncia, un’insegna ampia che si sgancia dalla ferinità, dalle inclinazioni astrali e dalla fantasmagoria, per raggiungere l’apertura all’Assoluto e ai valori morali, in una prospettiva tomistica, come scrive Mario Casella:
«Considerato nella sua individualità materiale, l’uomo, come tale, non è, per quanto distinto, che un semplice frammento dell’universo, in balia della fortuna e del caso, della sorte e del destino. È, cioè, un punto di intersezione delle molteplici influenze fisiche e cosmiche, animali e vegetative, etniche e ereditarie, di cui subisce necessariamente le leggi, ma come persona morale, egli è perfettamente libero, cioè capace di determinarsi ai mezzi e di introdurre nell’universo, con la sua libertà, una serie di avvenimenti nuovi di carattere duraturo».
Le figure sulla scena sono in bilico tra movimenti opposti: fato, disegno divino, libero arbitrio, conoscenza platonica, come testimonia l’acuto studio di Federico Sciacca. Fausta Antonucci afferma: «“Sogno è, come vogliono fargli credere Clotaldo e il re, l’esperienza fatta da Segismundo a palazzo; solo il risveglio (la prigione) è la “realtà”. Il principe però non crede mai davvero a questa versione dei fatti, perché il ricordo di Rosaura e il sentimento che prova per lei attraversano intatti la presunta frontiera fra sogno e realtà […]» (p.84).
La conversione di Sigismondo, scrive Ferdinando Castelli, «avviene per via di ragionamento, non di pura volontà». Tutto sembra svanire, ma qualcosa si impone e resta, «Tutto è finito, ma quell’immagine della bellezza non è finita», come la prima apparizione di Rosaura che risveglia in lui una dimensione sperduta di confessione e incompletezza, che gli fa riscoprire l’incanto e la bellezza di qualcosa di buono, vero e giusto per cui vivere: «Ogni volta che ti guardo, tu susciti in me nuova meraviglia, e quanto più ti guardo, tanto più desidero guardarti».
La bellezza avviene, come la ferita vicina di qualcosa di lontano a cui si appartiene, come annota Sciacca: «[…] Le cose non valgono per quel che si manifestano, ma per quel che nascondono. Farsi prendere dalle parvenze è renderle insignificanti, è restare carcerati nell’angustia del corporeo e nella caducità del tempo. Il punto di vista da assumere, affinché il sensibile acquisti significato e il tempo di un valore, è l’eterno, di cui tutto è immagine».
La libertà evidenziata nel dramma, è un crinale di scelte e di cultura, (come si rinviene in Basilio con l’astrologia), ma permane nel suo cammino di conquista, nel passaggio da individuo a persona, e come capacità di compiersi e di raggiungere il proprio destino, con la vittoria finale dell’umiltà e della giustizia.
L’esplorazione avvinta dell’onore coniugale minacciato dal corteggiamento di un innamorato, che aveva avviluppato il cuore della protagonista, segna i drammi maturi di Calderón, attraverso, da un lato, la frattura di passato e presente, dall’altro il rapporto tra onore e intervento a sua difesa.
L’amore coniugale, la violenza, gli intrecci, la giustizia, la salvezza della paternità (El alcalde de Zalamea (Il giudice di Zalamea)) o la sua ribellione, il conflitto interreligioso, l’indeterminatezza del dramatis personae, la gelosia, l’ambizione e il fatalismo destinano l’eternare dei contrasti tra i personaggi, nelle trame del destino eveniente e nei suoi ingranaggi, nel loro stoicismo controllato, e, infine, nel dramma catastrofico della caduta.
Anche nelle opere a carattere storico e celebrativo, quali Darlo todo y no dar nada, o En la vida todo es verdad y todo mentira, in cui la mescolanza di dati e suggestioni fantastiche si intrecciano in un connubio di identità e riacquisto di sé, come afferma la studiosa,«l’orizzonte generico della tragedia è consapevolmente eluso. Si tratta piuttosto di drammi, nel senso che dà a questo termine Joan Oleza quando studia la proposta teatrale del giovane Lope de Vega […]: opere teatrali dal progetto abbastanza complesso, dagli intenti ideologici più marcati rispetto alla commedia, dal tono serio, ma che eludono le emozioni tragiche e tendono a una conclusione conciliatrice» (p.173).
I drammi religiosi legano la vita e la morte della figura dei santi (e lo scontro con le autorità pagane) a una sorta di pathos ultimo, di apoteosi finale, che rappresentano la loro forza vitale fino all’ultimità del loro sacrificio, alla loro accettazione della morte e all’epica critica. La domanda elementare dell’uomo, in Calderón, è una storia che tocca il sublime fino al mito, all’inserzione della Natura.
Qui il mito è un’abbondante scenografia di fondi e sfondi che appaiono sulla scena come meraviglia del mondo rappresentato e rottura dell’illusione teatrale, costruzione e distruzione affettiva, seguono strade diverse: «dall’espansione della comicità, all’introduzione di un lieto fine estraneo alla tradizione mitica classica, all’importanza preponderante di un intreccio amoroso condotto secondo i modi della commedia più che della tragedia» (p.209).
L’auto sacramental, Il gran teatro del mondo, dato alle stampe nel 1655, pone un modulo disseminativo–ricapitolativo ampio e suggestivo. Meta–teatro, dove l’Autore, Dio, convoca a sé, in una festa il Mondo, il Re, il Ricco e il Povero, il Bambino («Tu morrai senza nascere)», e distribuisce loro le parti, imponendo di rappresentare, nell’immensa pagina dell’universo, la commedia dell’umanità: «Cenerà con me accanto: chi, senza alcun errore, / avrà eseguita la parte assegnatagli. / Ivi tutti e due (il re e il povero) eguaglierò nel premio».
L’Autrice scrive:
«La finezza e la capacità inventiva di Calderón consistono nel creare allegorie “continuate”, che funzionano lungo tutto l’arco dell’intreccio da lui ideato mettendo in relazione gli elementi drammatici con altrettanti concetti teologici, senza che per questo il gusto dello spettacolo diminuisca e il peso didascalico sia eccessivo. Come dice lo stesso drammaturgo, prendendo in prestito una metafora della pittura, arte che gli fu specialmente cara: «L’allegoria non è altro che uno specchio, che trasforma / la fantasia [l’intreccio inventato] in verità [la verità teologica]; / ed è tanto più elegante / se la copia sulla tavola / riesce così somigliante / che al vederne una si pensi / di starle vedendo entrambe»» (pp.309-310).
La salvezza non è disgiunta dalle opere e perché l’uomo possa compierle, Dio li ha dotati di libertà. La volontà di Dio è assoluta e per salvarsi occorre ritornare al suo bene e svolgere la parte assegnata: si salva la discrezione, il Povero, e dopo purificazione, il contadino, il Re e la Bellezza. Tutti hanno implorato pietà e chiesto perdono e accolti nella mensa celeste.
Hans Urs von Balthasar sostiene che: «In questa mensa celeste non c’è assorbimento del mondo in Dio, bensì risonanza cristologica nel banchetto messianico–eucaristico: in tal modo l’attore centrale e invisibile dell’opera, l’Uomo Dio, diviene indirettamente tematico, allo stesso modo che fin da principio […] era stato il nascosto presupposto dell’opera».
Il conferimento e la vastità teologica di Calderón impone alla scena la sostanza della natura umana, nella sua debolezza, nell’inquietudine, nella fragile inclinazione e nel peccato, come commenta Ferdinando Castelli:
«Ecco l’elemento che illumina il teatro di Calderón: il peccato originale che si riflette nei peccati personali. Il drammaturgo non si dispera. Ritrae la condizione umana, e la ritrae con eccelsa arte drammatica, per far risaltare la salvezza operata da Cristo. Nello stesso tempo vuole esortare l’uomo a non compiacersi nel peccato, che è morte, ma a vincerlo ricorrendo alla Grazia».
 Antonucci F., Calderón de la Barca, Salerno Editrice, Roma 2020, p.364, Euro 25.
Antonucci F., Calderón de la Barca, Salerno Editrice, Roma 2020, p.364, Euro 25.
 La poesia di Ljubomir Levčev (1935-2019), uno dei più grandi poeti bulgari, è tempio di precisione furiosa. Poesia che affastella contraddizione e ironia, si ammanta di una temperie di assurdo e cromature vitali, che insegue la nostalgia dell’infinito, e guarda con attenzione e fedeltà, come scrive Roberto Galaverni, «la vita, il mondo, gli altri, sé stesso, proprio come ci si aspetta da un poeta. E lo fa spesso e volentieri per mettere in luce il rovescio, la trama nascosta, la verità e dunque la morale inattesa delle cose. Ma e qui sta il punto, l’intelligenza e l’arguzia delle sue osservazioni non risultano affatto intrise, come quasi sempre accade, di sarcasmo, risentimento o disamore vero l’esistenza».[1]
La poesia di Ljubomir Levčev (1935-2019), uno dei più grandi poeti bulgari, è tempio di precisione furiosa. Poesia che affastella contraddizione e ironia, si ammanta di una temperie di assurdo e cromature vitali, che insegue la nostalgia dell’infinito, e guarda con attenzione e fedeltà, come scrive Roberto Galaverni, «la vita, il mondo, gli altri, sé stesso, proprio come ci si aspetta da un poeta. E lo fa spesso e volentieri per mettere in luce il rovescio, la trama nascosta, la verità e dunque la morale inattesa delle cose. Ma e qui sta il punto, l’intelligenza e l’arguzia delle sue osservazioni non risultano affatto intrise, come quasi sempre accade, di sarcasmo, risentimento o disamore vero l’esistenza».[1] Levcev L., I passi dell’ombra, a cura di Giuseppe Dell’Agata, introduzione di Vladimir Levcev, Bompiani, Milano 2021, pp.350, Euro 20.
Levcev L., I passi dell’ombra, a cura di Giuseppe Dell’Agata, introduzione di Vladimir Levcev, Bompiani, Milano 2021, pp.350, Euro 20.