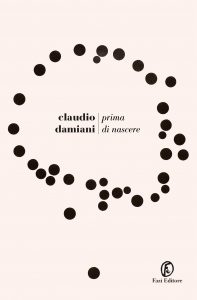di Andrea Galgano 16 giugno 2021
leggi in Pdf Odisseas Elitis
 «Ho colto la mia immagine tra un mare che si affaccia dal muretto bianco di calce di una chiesa e una ragazza scalza cui il vento solleva la veste: un momento felice cui tendo un agguato cercando di catturarlo con parole greche».
«Ho colto la mia immagine tra un mare che si affaccia dal muretto bianco di calce di una chiesa e una ragazza scalza cui il vento solleva la veste: un momento felice cui tendo un agguato cercando di catturarlo con parole greche».
La dimensione europea di Odisseas Elitis (1911-1996), luce fulgida della poesia contemporanea greca e premio Nobel per la Letteratura nel 1979, assurge, da un lato, al debito innegabile verso éluard, Valéry e Breton e, dall’altro, alla potenza raffigurativa greca immersa in una ricchezza elusiva e luminosa «ma anche poesia dell’ombra, dell’angoscia e della ricerca interiore, vicina ai grandi classici dell’epoca classica, Saffo soprattutto, e poesia filosofica e di riflessione esistenziale che talora arriva a prendere in considerazione un suo dialogo con la storia fino a realizzare una fusione armonica di queste due tendenze senza più distinzione tra pensiero e sentimento, tra l’ispirazione lirica e quella filosofica, tra prosa e poesia[1]».
La pubblicazione, presso Crocetti, delle sue Poesie[2], a cura di Filippomaria Pontani, con traduzioni di Filippo Maria Pontani e Nicola Crocetti, consegna la bellezza rinnovata, l’accento puro e umbratile, l’irradiazione infinita del tempo verso l’Assoluto, in una sinfonia sensuale e compiuta che raggiunge la metafisica solare e il corpo della lingua (si pensi alle torsioni, alle ellissi de Il Piccolo Marinaio, dove il metalinguismo raggiunge una sorta di elastica purezza), attraverso segnali che caratterizzano la poesia di Elitis come specchio vitale dell’altro verso delle cose e tensione.
Come avviene, ad esempio, nei movimenti di alterità frammentata del dialogo di Maria Nuvola, dove si addensano spostamenti di tangibile e intelligibile o alla densità ritrattistica di Fratellastri:
«naturalistica, metastorica e glottocentrica. […] Il parametro naturalistico si riferisce alla grande attenzione, determinante per la poesia di Elitis, per il micro e macrocosmo della natura: un cosmo nativo ed estraneo, vicino e lontano, animato e inanimato, vegetale, animale, umano: un cosmo dal quale emergono fanciulle amorose, simboli di emozione sensuale ed estetica. La metastoria allude alla deviazione o al superamento della storia, quando e dove essa sia segnata da implicazioni belliche e politiche, da stragi intestine e da ferite infette».[3]
Filippomaria Pontani afferma:
«Poesia come sensazione, trasparente come luce, luminosa come il sole, magica come il mare, concreta e forte come la Grecia; poesia come frutto di una lingua che non conosce il chiaroscuro, lingua perenne che guida la parola sull’onda della sua forza morale prima ancora che estetica o espressiva; poesia come “fonte di innocenza colma di forze rivoluzionarie”, come mito che non è più quello marmoreo e atteso delle storie antiche ma cresce come frutto di un processo autonomo e idiosincratico di “mitizzazione” del reale secondo canali tutti propri. Questa è la poesia di un Greco (Ellinas), di un vagabondo (alitis), di un uomo libero (elèftheros), di un devoto seguace di éluard (in particolare L’amour la poésie), pronto ad assumere sin da giovane uno pseudonimo (era nato come Odisseas Alepudis nel 1911 a Iraklio di Creta) per precipitarvi un precocissimo testamento di ideali».[4]
In Orientamenti (1940), il sipario greco di fiamma, l’alfabeto dei paesaggi, la sillaba di mare e terraferma, le evocazioni e i richiami, la metrica della materia, il colore degli arcipelaghi segnano il tempo dello zefiro egeo, i baci dell’aurora, l’orizzonte ampio dei risvegli e i notturni insanati delle dita dei cipressi, «in un pervicace ilozoismo sinestetico che trascolorava dal mare al giardino, dai melograni alle fanciulle, dal vento al bacio, dall’estate all’uva, dagli uliveti ai giacinti, dalla notte al fuoco, dalla roccia al fuoco[5]».
Inoltre, lo sciabordío d’amore è una memoria turchese di braccia dischiuse, palpebre insonni ed epigrammi di luce, fino alle clessidre dell’ignoto e al segreto della trasparenza:
«S’infuria il sole, la sua ombra incatenata dà la caccia al mare / Una casetta, due casette, il pugno chiuso dalla rugiada profuma ogni cosa / Fiamme e fiamme vanno in giro a svegliare porte chiuse delle risate / è tempo che i mari si presentino ai pericoli / Che volete chiede il raggio, che volete chiede la speranza / calando la sua camicetta bianca / Ma il vento ha seccato la vampa, due occhi pensano / Senza sapere che fine faranno così denso è il loro futuro / Verrà un giorno che il sughero imiterà l’àncora e ruberà il sapore dell’abisso / Verrà un giorno che la loro duplice identità diventerà una sola / Più in alto o più in basso delle vette che ha incrinato il canto del Vespro / Di stasera, non importa, l’importante è altrove / Una ragazza, due ragazze, si curvano sui loro gelsomini e scompaiono / Resta un torrente a raccontarle ma proprio lì le notti si sono chinate a bere / Grandi colombi e grandi sentimenti coprono il loro silenzio / Pare quella loro passione sia irredimibile / Nessuno sa se verrà il dolore a spogliarsi insieme a loro / Le trappole scarseggiano, le stelle indicano agli amanti gli incantesimi / Tutto balza, si aggroviglia – pare sia giunta l’immortalità / La cercano le mani stringendo il loro destino che ha cambiato corpo e si è fatto vento / Forte – pare sia giunta l’immortalità».
Il femminile di Elitis è una transustanziazione di grazia e bellezza, un concerto di giacinti, orizzonti remoti e ricordo glauco, voci che si dimenticano, viaggi di dita sui pioppi che spartiscono il vento e labbra introvabili, come le parole che affilano l’immenso:
«Emozione. Le foglie tremano vivendo insieme e vivendo separate sui pioppi che spartiscono il vento. Prima dei tuoi occhi è il vento che mette in fuga questi ricordi, questi ciottoli – le chimere! L’ora è liquida e tu ti appoggi su di lei, piena di spine. Penso a coloro che non hanno mai accettato salvagenti. Che amano la luce sotto le
palpebre, che quando il sonno è allo zenit esaminano svegli le loro mani aperte. Voglio chiudere i cerchi aperti dalle tue dita, e applicarvi sopra il cielo perché non sia mai diversa la loro ultima parola. Parlami; ma parlami di lacrime».
E ricolme dell’isola di Thera (Santorini), esse attraversano la notte che erra nei deserti degli astri, come nascita primigenia e porfirogenita:
«IX
Io non ho fatto altro. T’ho presa come tu prendesti la natura intatta e l’officiasti ventiquattro volte entro le selve e i mari. T’ho presa in quello stesso brivido che rovesciava le parole e le lasciava lungi come aperti in surrogabili gusci. T’ho presa compagna nella folgore, nel terrore, nell’istinto. Perciò ogni volta che cambio giorno stringendomi il cuore fino al nadir, tu fuggi e sparisci vincendo la tua presenza, creando un deserto di Dio una tumultuosa inesplicabile felicità. Io non ho fatto altro che quello che ho trovato e imitato in Te!
X
Ancora una volta tra i ciliegi le tue labbra introvabili. Ancora una volta tra le amache vegetali i tuoi antichi sogni. Un’altra volta nei tuoi antichi sogni le canzoni che si accendono e svaniscono. Dentro quelle che si accendono e svaniscono i caldi segreti dell’universo. I segreti dell’universo».
Oppure attraverso la pienezza dell’istante che lega abisso e brillìo, estati azzurre, labbra rosse e rocce di enigma, lontananze e sabbia tra le dita, il corpo dell’amata diviene il primo giorno sulla terra, tra i melograni folli e lidi inodori:
«Hai sulle labbra gusto di procella / Un vestito ch’è rosso come il sangue / Giù nel fondo dell’oro dell’estate / L’aroma dei giacinti – Dove mai vagavi / Calando ai litorali ai golfi con i ciottoli / Là c’era un’alga gelida salmastra / Più in fondo un sentimenti umano dava sangue / Aprivi attonita le braccia e ne dicevi il nome / Salendo lieve a specchi diafani d’abissi / Dove l’asteria tua brillava».
Nel corpo dell’estate si afferma l’assoluto imprendibile, la densità dell’istante, la goccia che trema nel sole, il fremito nudo dell’ultima pioggia e le variazioni su un raggio, come illibata libertà:
«Aroma eccelso del dito immilla la passione / Il mio occhio aperto duole sulle spine / Non è la fonte che brama gli uccelli dei due seni / Quanto il ronzio di vespa sulle anche nude. / Datemi la cicatrice dell’amaranto le magie / Della giovane filatrice / L’ “addio” l’ “arrivo” il “ti darò” / Caverne di salute lo berranno alla salute del sole / Il mondo sarà la morte o il doppio viaggio / Qui nel lenzuolo del vento lì nello sguardo dell’immenso».
I 14 quadri che compongono il Canto eroico e funebre per il sottotenente caduto in Albania, dato dopo aver rischiato la morte a causa del tifo, racconta la genesi dell’immolazione e il dramma della libertà e «proietta il sacrificio di un singolo combattente entro uno scenario di “morte e risurrezione” (emblematico il rintocco delle campani pasquali nell’ultimo testo) che coinvolge l’intera stirpe ellenica, ma più ampiamente l’uomo stesso, che tramite la lotta per la libertà e l’espiazione redime i luoghi e il cosmo portandoli a una compiuta perfezione[6]».
La passione ritorna in Dignum est (1959), dove l’inno di ringraziamento e celebrazione della tradizione liturgica ortodossa, unisce le campiture religiose, in particolare del Genesi, alla salmodia della Passione, fino al Gloria che prorompe come gemma di luce e dà vita e respiro alla bellezza.
Il travaglio della storia accompagna la sortita di ogni pienezza, la folgore di ogni umana tensione e l’avviluppo delle contraddizioni del tempo. L’autobiografia e il salmo, la voracità delle cose e la gloria di ogni lingua e stratificazione.
Il cuore dell’innocenza perduta, la lotta, il riscatto, la compiutezza morale, la fragranza ricolma della realtà, in tutta la sua gratuità (rocce, il fruscìo delle onde, le lacrime, muri, case, olivi e giardini, il corpo femminile disteso, i melograni, la sabbia di tenebra) condiscono la stilla di acqua limpida della poesia, dove, come afferma Filippomaria Pontani, il thànatos è anima del maschile, innervando il territorio della femminilità e della soggettività di Eros.
L’albero di luce e la quattordicesima bellezza (1971), che rimanda alle donne sciite, attraversa la crisi della Grecia odierna, non solo appropriandosi di una lacerazione di rimpianto e nostalgia, ma anche attraverso l’inserzione di un vocabolario autobiografico di infanzia e adolescenza e dell’enigma bianco dell’anima:
«Lo so che tutto questo è nulla e che non ha questa lingua che parlo un alfabeto / Visto che il sole e i flutti sono una scrittura sillabica che tu decifri solo nei tempi del dolore e dell’esilio / E la patria un affresco con strati successivi franchi o slavi se mai ti provi a restaurarli te ne vai in prigione all’istante e rendi conto / A una congerie di Potenze straniere tramite la tua / Come succede per le calamità / E tuttavia immaginiamo un’aia di remoti tempi che può stare in un grande casamento che vi giochino bambini e che chi perde / A norma di regolamenti sia tenuto a dire agli altri e a dare qualche verità / Quando sono alla fine tutti tengano in mano un piccolo / Dono argenteo poema».
Il poema-luce di Monogramma restituisce l’infinita sensualità dei passaggi quotidiani: i bisbigli, i pleniluni, i varchi del mare, il silenzio delle stelle, come un tempo remoto di un affresco diruto di incanto e profumo («Il tuo corpo nella posa del pino solitario / Occhi di orgoglio e di abisso trasparente / Dentro la casa con la credenza vecchia / I merletti gialli e il legno di cipresso / Io solo ad aspettare la tua prima epifania / Nella loggetta in alto o dietro sulle pietre del cortile / Col cavallo del Santo e l’uovo della Risurrezione»):
«Tanto la notte, tanto l’urlo al vento / Tanto la goccia all’aria, tanto il gran silenzio / Attorno il mare la tirannica / Volta del cielo con le stelle / Tanto il tuo minimo respiro / Che ormai non ho nient’altro / Entro le quattro mura, il soffitto, il pavimento / Per gridare di te (e la voce mi colpisce) / Per odorare di te e gli uomini s’infuriano / Perché ciò che è intentato, portato da un altrove / Non lo reggono gli uomini ed è presto, mi senti / È presto ancora in questo mondo amore mio / Per parlare di te e di me».
Elitis procede per analogia di sensazioni, laddove il paesaggio femminile è natura vivificata, genesi geometrica e ecfrasi di cielo:
«È ancora presto dentro questo mondo, mi senti / Placati non si sono i mostri, mi senti / Il mio perduto sangue e l’appuntito, mi senti / Coltello / Come ariete che corre dentro i cieli / E spezza agli astri i rami, mi senti / Sono io, mi senti / Ti amo, mi senti / Ti tengo e ti porto e ti metto / L’abito candido d’Ofelia, mi senti / Dove mi lasci, dove vai, chi mai, mi sent / È a tenerti per mano sopra i cataclismi / Liane enormi e lave di vulcani / Verrà giorno, mi senti / Che ci seppelliranno e le migliaia d’anni poi, mi senti / Di noi faranno pietre luccicanti, mi senti / Perché vi brilli l’impietosa indifferenza, mi senti / Degli uomini / E in mille pezzi via ci getti, mi senti[…]».
I sintagmi della rêverie, la liturgia, la divinazione suprema ed eliocentrica della luce diventano ultimità ierofanica che tenta di trasformare la realtà, congiungere morale e bellezza, sospendere sintassi ed enigma, inquietudine vitale, prisma rifratto e destino, come galassia ribassata e fogli nel sole.
O anche nel blu di Iulita, in cui Elitis fa confluire il passaggio del respiro, la sacralità del vento, il mito citereo, il tempo amante, fino alla nitidezza dell’anima, affamata e assetata di eterno:
Anche in un frammento di Briseide e in una conchiglia dell’Euripo si trova
Ciò che intendo. Deve avere avuto una fame tremenda nella bonaccia agosto
Per volere il meltèmi; così da lasciare un po’ di sale sulle ciglia e
In un cielo blu il cui nome benaugurante sentirai tra i tanti
Ma nel profondo è il blu di Iulita
Come se fosse venuta prima la scia del respiro di un bimbo
Che vedi avvicinarsi coì nitidamente i monti dirimpetto
E la voce di un’antica colomba fendere l’onda e perdersi
Se il bene è sacro, di nuovo dal vento
Gli viene restituito. Tanto si moltiplica dai suoi stessi figli la Bel-
Lezza e tanto l’uomo cresce prima che due o tre volte
Lo raffiguri il sonno
Nel suo specchio. Cogliendo mandarini o ruscelli di filo-
sofi se non anche
Un villaggio mobile di api sul pube. E sia
L’uva fa bruno il sole e più candida la pelle
Chi altri oltre la morte ci rivendica? Chi pratica ingiustizia dietro ricompensa?
Un accordo armonico la vita
a cui si frappone un terzo suono
Ed è questo che dice veramente che cosa getta il povero
E che cosa raccoglie il ricco: fusa di gatto, rametti intrecciato di agnocasto
Assenzio con capperi, parole che si evolvono con una vocale breve
Baci e abbracci da Citera. Così, a cose come queste si aggrappa
L’edera e si fa più grande la luna perché vedano gli innamorati
In che blu di Iulita puoi leggere la ragnatela del destino
Ah! Quanti tramonti ho visto e quanti corridoi di teatri antichi Ho attraversato. Però il tempo non mi ha mai preso in prestito bellezza
Per ottenere una vittoria contro il nero e prolungare la durata dell’amore cosicchè Il canto dell’allodola che è in noi sia più ingegnoso e melodico
Dal suo pulpito
Nube accigliata che uno schietto “no” solleva come una piuma
E poi ricade e tu ti sazi ti sazi ti sazi di pioggia
Diventi coetaneo dell’intatto senza conoscerlo e Continui a farti il solletico con le tue cugine nei recessi del giardino
Domani un suonatore ambulante ci annaffierà di fiori della notte
E nonostante ciò saremo un po’ infelici
come solitamente nell’amore
Ma dal mastice dell’argilla sale un sapore eretico
Per metà di odio e sogno per metà di nostalgia Se continueremo a essere percepibili come uomini che
Passano la vita sotto cupole punteggiate da tritoni di smeraldo, allora
Sarà mezzo secondo dopo mezzogiorno
E la sublime perfezione
compiuta in un giardino di giacinti
Cui è stato tolto per sempre l’appassire. Un po’di grigio
Che una sola goccia di limone rasserena allorchè
Vedi ciò che intendevo dall’inizio incidersi
Con caratteri nitidi
sul blu di Iulita.
[1] (a cura di) Minucci P., Odisseas Elitis. Un europeo per metà, Donzelli, Roma 2010, p.X.
[2] Elitis O., Poesie, a cura di Filippomaria Pontani, Crocetti Editore, Milano 2021.
[3] Maronitis N.D., Contributo sulla poetica di Odisseas Elitis. Poesie in rilievo e a tuttotondo, in Odisseas Elitis, cit., pp.18-19.
[4] Pontani F., in Elitis O., cit., p.7.
[5] Id., cit.
[6] ID., cit., pp.8-9.
 Elitis O., Poesie, a cura di Filippomaria Pontani, Crocetti Editore, Milano 2021, pp. 240, Euro 16.
Elitis O., Poesie, a cura di Filippomaria Pontani, Crocetti Editore, Milano 2021, pp. 240, Euro 16.
Elitis O., Poesie, a cura di Filippomaria Pontani, Crocetti Editore, Milano 2021.
- È presto ancora, a cura di Paola Maria Minucci, Donzelli, Roma 2012.
- Il metodo del dunque e altri saggi sul lavoro del poeta, a cura di Paola Maria Minucci, Donzelli, Roma 2012.
(a cura di) Minucci P., Odisseas Elitis. Un europeo per metà, Donzelli, Roma 2010.
 Il mondo di Vicki Feaver è un’esplosione esplorata di pienezza. Lo è nella sua poesia, La fanciulla senza mani, ispirata alla fiaba dei fratelli Grimm e alla fiaba russa, per cui una fanciulla senza mani, appunto, tagliate dal padre, ricrescono, quando protende le braccia in un fiume per salvare la sua bambina che rischiava di annegare.
Il mondo di Vicki Feaver è un’esplosione esplorata di pienezza. Lo è nella sua poesia, La fanciulla senza mani, ispirata alla fiaba dei fratelli Grimm e alla fiaba russa, per cui una fanciulla senza mani, appunto, tagliate dal padre, ricrescono, quando protende le braccia in un fiume per salvare la sua bambina che rischiava di annegare. Feaver V., La fanciulla senza mani e altre poesie, a cura di Giorgia Sensi, Interno Poesia, Latiano (Br) 2022, pp. 188, Euro 15.
Feaver V., La fanciulla senza mani e altre poesie, a cura di Giorgia Sensi, Interno Poesia, Latiano (Br) 2022, pp. 188, Euro 15.