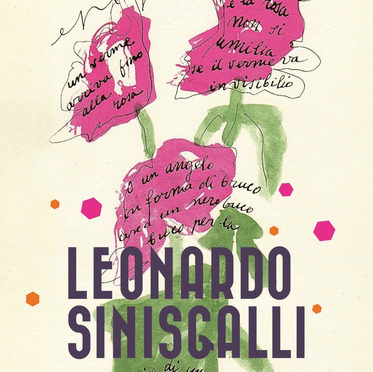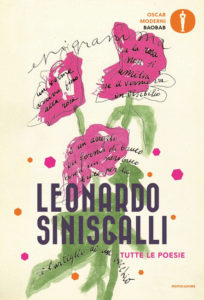di Andrea Galgano
4 marzo 2020
leggi in pdf L’ellisse vitruviana di Leonardo Sinisgalli tra la scienza e l’arte
 La pubblicazione, per Mondadori, di Tutte le poesie di Leonardo Sinisgalli (1908-1981), a cura di Franco Vitelli e con il contributo della BCC Basilicata, toglie, finalmente, la ricezione elitaria della sua poesia, poiché, come Vitelli afferma: «troppo forte è stata la capacità anticipatrice, per cui si è trovato in dissenso col suo tempo e contemporaneo della posterità, la quale ha messo in pratica le sue idee geniali quando per lui andavano prendendo un’altra piega».
La pubblicazione, per Mondadori, di Tutte le poesie di Leonardo Sinisgalli (1908-1981), a cura di Franco Vitelli e con il contributo della BCC Basilicata, toglie, finalmente, la ricezione elitaria della sua poesia, poiché, come Vitelli afferma: «troppo forte è stata la capacità anticipatrice, per cui si è trovato in dissenso col suo tempo e contemporaneo della posterità, la quale ha messo in pratica le sue idee geniali quando per lui andavano prendendo un’altra piega».
Il suo incontro musaico è un segno infinitesimo di inquietudine e di spostamento che insegue l’arcaica visione di un meravigliato itinerario, di un legame scientifico e metamorfico con l’umano, in un chiasmo di orizzonti e ombre:
«Sulla collina / Io certo vidi le Muse / Appollaiate tra le foglie. / Io vidi allora le Muse / Tra le foglie larghe delle querce / Mangiare ghiande e coccole. / Vidi le Muse su una quercia / Secolare che gracchiavano. / Meravigliato il mio cuore / Chiesi al mio cuore meravigliato / Io dissi al mio cuore la meraviglia».
Il suo simulacro musivo risente di una vivace doppiezza, che se, da un lato vive dell’agone prospettico “rinascimentale”, in cui scienza (matematica, in particolar modo) e arte confluiscono in un unico proscenio di disciplina e metodo, dall’altro la vertigine poematica costruisce un’istanza di luce che riunisce grottesco e ironico, dolce furore familiare e «colore carnale».
La scena rappresenta, pertanto, uno strappo di opacità. La parola di Sinisgalli, irrorata dalla lezione di Mallarmé, Ungaretti e Valéry, distesa sulla geometria cartesiana e sull’architettura albertiana, ricerca il numinoso prodigio della «fulmineità dell’atto creativo», dove «Troppi eventi nella natura e nell’intelletto accadono in un istante: sono cariche e scariche di energia enorme, di energia animale e cosmica, che distruggono la cosa per creare l’immagine». In tale mobilità, nata dalla apicale prosa leonardesca, Sinigalli bracca l’immaginario algebrico, la geometria e la metrica dell’invisibile, unendole con le forze della inner vision poetica.
Nel suo sincretismo, che gli permetterà di progettare, dapprima, la pubblicità della Olivetti, allestendo a Milano, tra il 1936 e il 1940 una rivoluzione anticipatrice della pop art, facendo coesistere la linea della grammatica visiva di Kandinskij e il dramma plastico di Consagra con gli automi, per poi fondare e dirigere la rivista «Civiltà delle Macchine», per Finmeccanica, in cui fondere la nuda polifonia del sapere scientifico con l’osmosi letteraria, come egli stesso afferma in una intervista a Ferdinando Camon del 1965:
«L’inverno del 1953, a Roma in un ufficio di Piazza del Popolo, quando io misi a fuoco il progetto di Civiltà delle Macchine […] la cultura dell’Occidente era rimasta incredibilmente arretrata e scettica nei confronti della tecnica, dell’ingegneria. Voglio dire che erano sfuggite alla cultura le scoperte di Archimede e di Leonardo, di Cardano e di Galilei, di Newton e di Einstein. Io volevo sfondare le porte dei laboratori, delle specole, delle celle. Mi ero convinto che c’è una simbiosi tra intelletto e istinto, tra ragione e passione, tra reale e immaginario. Ch’era urgente tentare una commistione, un innesto, anche a costo di sacrificare la purezza».
Successivamente, il suo desiderio di unità sincretica tra discipline confluirà anche nella direzione di «La botte e il violino», bimestrale dell’Eni di Mattei. L’inseguimento delle Muse cerca le ombre, i compagni che gridano a perdifiato, le monete rosse, l’ultima luce chiamata nella piena dei canali e le mani affondate nel grano in una tiepida suoneria, fino al ricordo intriso d’autunno che respira il vento di Porta Nuova. La terra, l’inquieto nomadismo, il reticolo memoriale di strade, luoghi, fiumi, città confluiscono in un perfetto squilibrio di tempo. Tempo arcaico, cosmico, ciclico, percepito in tutte le gradazioni affettive, come i rosei del rosa dolce delle case, la figura paterna, il mattino fondo e roco dell’essere.
È l’energia che strepita e che segna il territorio del suo immaginario vissuto nella percezione e nell’ingresso della natura «nelle nostre capsule, nelle parole e nei simboli, nelle lettere e nelle cifre. Ci entrano anche i pensieri. Entrano le formule semplicissime che regolano il mondo. Le equazioni di Einstein sono brevi come le formule dell’acqua e del sale. Dio è laconico».
E poi ancora, nella vita di transito del poeta «entrano in giuoco delle cariche di energia incommensurabili, che vivono magari per attimi infinitesimali e si consumano in un soffio. Tuttavia non sono i fenomeni del mondo fisico che possono offrirci qualche analogia di questi transiti, ma proprio alcuni fenomeni biologici cosmici e nucleari». L’energia di Sinisgalli è sì visiva e tattile ma è fatta di aria capovolta, che fissa l’immagine in una sproporzione che diviene «coscienza dello spazio terrestre» (Giuseppe Pontiggia), come afferma Augusto Ficele: «Sinisgalli sarà perpetuamente turbato dal fissare una grammatica speciale all’interno di capsule a cui sfuggiranno quei transiti celesti, quelle piume invisibili che irrobustiscono il cielo. Mobilita tutte le sue forze cognitive, non smette mai di indagare il vuoto, di tracciare tutte le possibili spirali del sapere, e se la matematica non si stanca di fabbricare ipotesi, la poesia scopre ciò che non esiste»: «Eri dritta e felice / Sulla porta che il vento / Apriva alla campagna. / Intrisa di luce / Stavi ferma nel giorno, / Al tempo delle vespe d’oro / Quando al sambuco / Si fanno dolci le midolla. / Allora s’andava scalzi / Per i fossi, si misurava l’ardore / Del sole dalle impronte / Lasciate sui sassi».
La Lucania di Sinisgalli appartiene al tempo remoto e arcaico della primigenia. Cadenza il ritmo favoloso della realtà, avverte tutta la sovrapposizione temporale attraverso l’indizio, la prova e il presagio di una rêverie al presente, laddove la terra abita l’esistenza in tutta la sua drammatica contemplazione di scena e scoperta di ambiente, come se si volesse possedere quello strappo, quella acrobazia dolorosa del quotidiano, quella memoria vitale che raccoglie cocci ed epigrafi, racconti e fiammelle, nell’aria sfatta dell’amore che, a fatica, scioglie nodi e segni perduti nella luna di settembre, per ricordare, sentire e indovinare:
«Lo spirito del silenzio sta nei luoghi / della mia dolorosa provincia. Da Elea a Metaponto, / sofistico e d’oro, problematico e sottile, / divora l’olio nelle chiese, mette il cappuccio / nelle case, fa il monaco nelle grotte, cresce / con l’erba alle soglie dei vecchi paesi franati. / Il sole sbieco sui lauri, il sole buono / con le grandi corna, l’odoroso palato, / il sole avido di bambini, eccolo per le piazze! / Ha il passo pigro del bue, e sull’erba, / sulle selci lascia le grandi chiazze / zeppe di larve. / Terra di mamme grasse, di padri scuri / e lustri come scheletri, piena di galli / e di cani, boschi e di calcare, terra / magra dove il grano cresce a stento (carosella, granoturco, granofino) / e il vino non è squillante (menta / dell’Agri, basilico del Basento!) / e l’uliva ha il gusto dell’oblio, / il sapore del pianto».
In La vigna vecchia, l’orma dell’urto con le cose si fa sempre più composita. Vi è ancora una primitiva forza che appartiene a una mitologia domestica che si spoglia indecifrabile, accostando «le concrete illuminazioni», come ha avvertito Giacinto Spagnoletti, alla «pluralità irreale delle visioni» (Oreste Macrì), innervando i rimbalzi di luce alla sua continuazione: la polvere, il quartiere sotto la collina, la vigna e il fondo degli alberi, il cratere spento, il freddo di aprile, il febbraio dolce e amaro, la memoria quasi fossile. Ma se con L’età della luna, il margine della imprendibilità della realtà, come un lungo appunto di postille puntuali, che omaggiano anche il taglio inciso di Fontana, fa convergere l’esattezza del verso nella prosa poetica e dimostrando il profondo attaccamento alla poesia, distaccata da ogni meccanizzazione e quasi sorvolando l’inaridimento dei luoghi (anche mentali), con Il passero e il lebbroso (1970) l’entità della sua vocazione poetica attesta lo sgomento e lo sconforto («Le parole non vengono sulle labbra, / solo un alfabeto da carcerati / parlato con le dita. / Tu ti penti di aver perduto / la vita per dovere. / Puoi trascorrere ore e ore / a guardare le foglie nuove. / Il mondo è lontano di là»), la lotta della non-poesia, per affermare l’ultimità dell’ars poetica, l’attrito alimentativo della concisione, il battito della felicità, presa per la coda:
«Bolsi sulla ghiaietta sotto gli olmi / ammirano le foglie / ancora verdi, trasparenti / a fine ottobre. / Non c’erano venuti mai / insieme in tanti anni. / Sono qui tutte le mattine alle undici / per consiglio dei medici. / Girano a passi piccoli, / il luogo non è immenso, / lo percorrono in un’ora / sempre nello stesso senso. / Quando stanno meglio / e possono camminare spediti / fanno una visita / al Museo di Storia Naturale. / guardano i mammut, i cristalli, / gli scheletri dei pesci e degli uccelli: / teste grandi come teatri, ossa / sottili come aghi. Siedono / sulla panchina davanti al lago».
L’anima di Sinisgalli diviene un volo sospeso e rappreso che fa tinnire le boccole contro i muri, che ricerca la parola unica e assoluta, e che assomiglia alla mosca che si posa e poi si discosta. Restano così le cose più insignificanti a sopravvivere, il dialogo d’inverno e il rito dell’amore bandito, rilasciato in un’ellisse di forza:
«Restano sempre le cose più insignificanti / a sopravvivere / fourrures, souvenirs, / l’amante che ti morde l’orecchio, / il più sciocco, il più vecchio / ti gira intorno, ti guarda morire. / L’amore arrivò davanti a me / come un dannato. / Sceglieva per i nostri riti / le ore del mattino, / voleva essere strozzato in una gelateria vuota. / Sarebbe salito su un palco / nudo, alla gogna, / colpito da pietre e flagelli / senza dolore, senza vergogna. / Ma i banditi d’amore / vivono all’inferno. / Finchè vivo, finchè affogo / non brucerò il suo ritratto. / Parlerò col fuoco, parlerò col gatto / queste sere d’inverno».