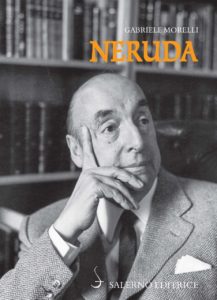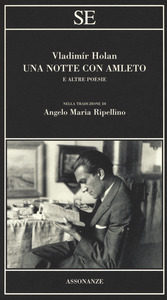di Andrea Galgano 9 agosto 2019
leggi in pdf AUGUST VON PLATEN. IL NITORE SENZA SOSTA
 Il gesto lirico di August von Platen (1796-1835) è una materia solitaria e fugace, che si dipana in un’epoca pervasiva di attriti e ombre, la Goethezeit («possiede qualità brillanti, e tuttavia non possiede l’amore», così affermò, di lui, Goethe), che tenta una via peculiare, che si discosta tanto
Il gesto lirico di August von Platen (1796-1835) è una materia solitaria e fugace, che si dipana in un’epoca pervasiva di attriti e ombre, la Goethezeit («possiede qualità brillanti, e tuttavia non possiede l’amore», così affermò, di lui, Goethe), che tenta una via peculiare, che si discosta tanto
«dalla generazione dei Romantici, che a quell’influenza avevano cercato in tutti i modi di sottrarsi, quanto da quella dei suoi coetanei, che con fatica cercavano una propria via capace di condurli, che con fatica cercavano una propria via capace di condurli oltre le premesse. Solo e solitario per destino ma anche per vocazione, Platen seguì un proprio itinerario nel quale giocò un ruolo fondamentale l’idea, e l’ideale, della bellezza. […] Il mito della bellezza si esprime così in una poesia che, frutto di studio appassionato, aspira al nitore, alla perfezione e alla pregnanza della lirica classica e come questa tende a celebrare il poeta come divino artefice; ideale luogo di ambientazione di questo progetto tanto ambizioso quanto utopico è il paesaggio italiano, da Platen vissuto – sia a livello di reminiscenza, sia nella realtà fattuale – come un Altrove benefico rispetto all’angustia ispiratagli dal suo paese e dal suo tempo».[1]
La pubblicazione, presso Elliot, grazie alla solerte cura di Andrea Landolfi, delle Poesie (1816-1834)[2], restituisce una sosta di forma e di bellezza, e di nitore viandante, riappropriandosi, così, di un equilibrio raffigurativo fatato, quasi aereo: «Venne Flora, alle tue foglie / il profumo tolse, e disse: / Tu sarai gioia per gli occhi, / l’oro l’aria inebrieranno».
Il marchese di Hallermünde, il cui rapporto con la Germania, risulta essere conflittuale e straniante, sia per il conflitto della sua omosessualità e sia, come sostenuto da Landolfi, per una sorta di poetica «di impronta fortemente elitaria e solipsistica, che tende a trasformare il proprio sostanziale isolamento nella altera solitudine di colui che si sente prescelto a più alti destini[3]», avverte tutta la lacerazione splendente della materia, il suo irretimento e la dolcezza immortale: «Se fanno una ghirlanda questi fiori / a ornarti il capo di colori belli, forse / mi dirai grazie e non me ne vorrai / per quel che è buono e quel che lo è di meno: / Che mai potrebbe darti la poesia? / Tu stesso sei per me un dolce poema, / e se anche il tedio spesso ti intristisce / tu metti ali al canto del poeta».
O ancora, come una invocazione solenne e leggera, il canto di Platen è un’anima nascosta e febbrile, si espande come meta incerta, occulta sentimenti per renderli vitali e feriali nell’orizzonte sottile della poesia:
«Nel maggio voluttuoso della vita / quando l’anima ferve di entusiasmo / io sento che nel desiderio ardente / la mia fiamma vitale si consuma. / Non un vento che tiepido e dolce / mi sorprenda, mi scompigli i capelli; / oppresso e vuoto, inerte navigante / vago per il silente deserto dell’Oceano. / Chi mi dirà cosa devo fare? / Se valgo qualcosa, se posso tentare? / Se otterrò ciò che devo senza pianto? / Tanta fatica al prezzo di un sudario! / Venite dolci canti, dopo il lungo sonno / infondete coraggio al mio cuore / affinchè non sprofondi nel sogno, / non si perda in passioni sviate».
In mezzo l’aspra polemica con Heinrich Heine, che nei Bagni di Lucca, ne denigra la figura e la sua latente omosessualità, costretta ad essere occultata e dissimulata, nel sistema culturale tedesco del tempo e pagata a caro prezzo («Solo lievi parole avete per giudicarmi, / leggere nel mio cuore non vi è fato: / ah, ogni scherzo è solo oblìo di me, / ogni sorriso pago a caro prezzo»):
«Un animo gentile si esprime solo in forma confacente, e questa la si può apprendere solo dai greci, o dai moderni che tendono alla perfezione greca, pensano alla greca, sentono alla greca, e in tal modo comunicano all’uomo i propri sentimenti”. «All’uomo, s’intende, non alla donna, come sogliono i poeti romantici», osservai» […] «il volume recava sul frontespizio: “Poesie del conte Augusto von Platen”, […] e, sulla pagina interna, la scrittura a svolazzi: «Pegno di calda, fraterna amicizia.».[4]
Già nei Diari, Platen aveva espresso tutta la potenza del dolore cieco, la refrattaria precarietà, il suo amore sperduto per lo studente ventunenne Eduard Schmidtlein e per un primo, iniziale per una giovane nobildonna, la ferita o-scena e irrimediabile dell’indicibile, e il patimento oppresso e muto dell’alterità: «Io vado errando / oppresso e muto / chiedi perchè? / Oh, non lo chiedere! / Troppo dolore / mi opprime il cuore: / come potrei / non esser triste? / Si secca l’albero / smuore il profumo, / le foglie cadono / ingiallite al suolo, / un freddo brivido / irrompe impetuoso: / come potrei non esser triste?».
Lo stesso amore è una scheggia infilata nelle carni, un rimando di sogno e ardore, dove la stoffa onirica sedimenta la materia della poesia, il suo gesto vivente e alchemico che invoca la luce, prima di ogni tempo, e che fronteggia l’anima dispari di Arimane, già messo a fuoco da Leopardi:
«Cos’è che ci consola, che ci dà / voglia e coraggio di indugiare quaggiù? / Noi sogniamo vivendo, / noi viviamo sognando. / Non appena cediamo al sonno / ci abbandona il vano nostro io / e da altre sfere brividi presaghi / accorrono benigni a cullarci. / Dopo aver scontato dure pene / e superato prove dolorose / possiamo sperare di svegliarci / là dove ci addormentammo. / Lasciateci dunque aspirare / con fede e coraggio ai più beati spazi, / perché noi sogniamo vivendo, / perché noi viviamo sognando».
Ma le stagioni più profonde e intense, Platen le vive in Italia. Raggiunge Roma il giorno del suo trentesimo compleanno, Napoli e la costiera (Sorrento, Capri, Paestum, Amalfi, tra il 1827 e il 1834) nel 1828, e poi ancora il Nord Italia e il Sud, tra Basilicata, Calabria, e l’ultima meta della Sicilia.
Andrea Landolfi scrive:
«l’Italia di Platen […] è minuziosa e minima […]. Libero dalle costrizioni e dalle dissimulazioni impostegli dal proprio ambiente, Platen trova in Italia una sua dimensione all’insegna di un vorace e febbrile attivismo volto a immagazzinare quante più immagini, nozioni, sensazioni, esperienze possibili. Ciò che soprattutto lo attira, accanto alle sopravvivenze dell’Antico, è quella presunta “innocenza” che, a lui come già al Goethe soprattutto siciliano, la tragica arretratezza del paese sembrava garantire».[5]
Camilla Miglio gli fa eco:
«Il suo non fu un Grand tour tradizionale. L’andare a sud non era solo una ricerca di radici culturali, o goethiani ringiovanimenti dell’anima, quanto una fuga. Il suo viaggio si può leggere anche come tentativo di sottrarsi a chi intendeva sorvegliarlo, e soprattutto punirlo, in seguito agli scandali sessuali che ne provocarono l’allontanamento dalla scuola militare e poi dall’università. Classicista ma anche orientalista, era preso dal demone della bellezza e della lontananza (degli antichi greci e latini ma anche dei persiani medioevali, maestri di versificazione erotica)».[6]
Negli anni napoletani e in particolar modo nel settembre del 1834 conosce Giacomo Leopardi e Antonio Ranieri. Alla vista del poeta recanatese scrive:
«Chi conosca Leopardi soltanto delle sue poesie proverà, al vederlo, un certo pavento. Egli è infatti piccolo e gobbo, ha il volto pallido e sofferente e accresce i suoi dolori col modo di vivere, poiché scambia la notte con il giorno e viceversa. Senza potersi muovere né, a causa dello stato dei suoi nervi, impegnarsi in alcuna attività, conduce un’esistenza davvero triste. Tuttavia, conoscendolo più da vicino, la sgradevolezza dell’aspetto scompare al cospetto della raffinata cultura classica e della simpatia della persona».[7]
È una vicinanza di intenti, la misura più vicina alla dismisura che li accomuna.
La stretta congiuntura della ricerca estetica e della forma conclusa, del paesaggio in fieri, lagunare o rurale, del labirinto dell’essere, come iato inscindibile, non riescono a sanare una ferita di sperdimento: un amore totale, un desiderio ineffabile.
I suoi sonetti offrono il gesto chiaro di un mysterium tremendum, che tenta di rifuggire i falsi incanti, la sofferenza e la sparizione, ma che sente il duro e irrefrenabile bisogno di felicità, come cortina inafferrabile.
La sua libertà, promessa e colta come falce, diventa nostalgia, struggimento, bellezza irraggiungibile, come la gloria di Venezia («Perchè dov’è bellezza regna amore / nessuno si dovrà meravigliare / se non saprò nascondere del tutto / che l’anima ho divisa dal tuo amore. / Lo so, mai invecchierà il mio sentimento, / ché s’avvilupperà stretto a Venezia: / sempre dal petto sorgerà un sospiro / per una primavera appena in boccio. / Come può lo straniero ringraziarti / se anche il cuore tuo volle allietarlo / blandendo così in dolci pensieri? / mezzo non v’è che mi avvicini a te, / e solo vedi me muovere il passo / su e giù ogni notte per piazza San Marco»), perduta dentro un sogno di ombre, o di Firenze, anime immobili e respiri di carne:
«Libero io mi vorrei serbare, / nascosto al mondo intero / navigare vorrei su quiete acque, / dall’ombra delle nuvole coperto. / Accompagnato dagli uccelli in volo / dal peso della terra liberarmi, / cullato dal più puro elemento / fuggire gli uomini e le loro colpe. / Solo di rado toccherei la terra / e senza mai lasciare il mio vascello / un bocciolo di rosa coglierei / per ritornare poi subito al largo. / Vedrei da lungi pascolare i greggi, / crescere fiori e rinnovellarsi, / le contadine cogliere le uve, / falciare gli uomini il grano odoroso. / E null’altro godrei che il chiarore / del giorno, eternamente puro, / e una coppa d’acqua fresca, / che mai il sangue possa accendermi».
Il tempo dei Ghazal è un crampo di desiderio. Un sogno straziato, un pendolo continuo dell’io tra la fatalità e la fralezza, la diversità e la bellezza. Quest’ultima avvinta e ricercata, in tutto il suo tremendo e fertile dominio.
In questa ebbrezza, quasi intontita e chiara, si afferma tutta la vertigine della sua salmodia, l’appartenenza al sublime e chiaroscurale movimento dell’essere.
Platen è il poeta della spezzatura sontuosa dell’essere. Il cui regno radicale è quello della Bellezza, della primavera, della fioritura umbratile delle cose e delle sue piaghe.
Come se fosse presente alla tavola dell’amore. Un bacio, una bocca, un fondo di volti e notti estive, che nutrono abbondanze e giovinezze, che sentono la pena del cielo stretto e che diventano canto di ombra spaventosa:
«Se tacere dovrà i propri pensieri, / se la ragione cederà all’insania, / se la mollezza bacerà la sferza / del forte come un sacro scettro: / allora, sazio del variopinto giuoco, / mosso da brezze più serene e pure / il manto deporrà dell’illusione / e dei sensi la tramata veste”. / Esistono due anime che in tutto si comprendano? / Chi scioglierà l’enigma? Chi un’anima affine / di cercare non smetterà fino alla morte, / fino alla morte continuerà a cercare».
Nel 1835, Platen fugge da Napoli in mano al colera (se ne ricorderà Emilio V. Banterle nell’opera teatrale Leopardi. Storia di un’anima) e si imbarca per Palermo, passando per Caltagirone e Segesta. Poi sulla costa orientale, trova ospitalità presso il conte Landolina e qui si ammala di tifo. Gli sarà fatale. Muore il 5 dicembre e viene sepolto nel parco di Villa Landolina (oggi Museo Archeologico) a Siracusa.
Nel 1930, Thomas Mann innalza lo strazio di Platen attraverso un tempo oltre-tempo. Per la sua novella La morte a Venezia, cifra il protagonista chiamandolo Gustav, che oltre ad adombrare Mahler, diviene anche l’anagramma perfetto di August e il suo cognome Aschenbach, non è altro che il suono consonante di Ansbach, la città natale di Platen. Nella luce sirena di Venezia, appoggiato all’orizzonte, guarda ciò che prima sorgeva: le cupole e i campanili del suo sogno. La poesia era compiuta come un tremendo passaggio di bellezza nuda.
[1] Landolfi A., August von Platen o la trappola della bellezza, in Von Platen A., Poesie (1816-1834), cit., pp.11-12.
[2] Von Platen A., Poesie (1816-1834), a cura di Andrea Landolfi, Elliot, Roma 2019.
[3] Landolfi A., cit., p.12.
[4] Heine H., I bagni di Lucca, in Heine A., Italia, impressioni di viaggio, Rizzoli, Milano 1951. Vedi anche Mayer H., La lite tra Heine e Platen, in I diversi, Garzanti, Milano 1977 (poi 1992), pp. 194-209.
[5] Landolfi A., cit.p.13.
[6] Miglio C., Le strade del desiderio in Heine e Platen, in “Il Manifesto”, 7 settembre 2014.
[7] Von Platen A., Die Tagebücher des Grafen August von Platen, a cura di G. von Laubmann e L. von Scheffler, 2 voll., Stuttgart, Cotta 1896-1900; ristampa anastatica: Hildesheim Olms, 1969, vol. II, p.962.
 Von Platen A., Poesie (1816-1834), a cura di Andrea Landolfi, Elliot, pp. , Euro 19,50.
Von Platen A., Poesie (1816-1834), a cura di Andrea Landolfi, Elliot, pp. , Euro 19,50.
Von Platen A., Poesie (1816-1834), a cura di Andrea Landolfi, Elliot, Roma 2019.
- Die Tagebücher des Grafen August von Platen, a cura di von Laubmann e L. von Scheffler, 2 voll., Stuttgart, Cotta 1896-1900; ristampa anastatica: Hildesheim Olms, 1969, vol. II.
Heine H., I bagni di Lucca, in Heine A., Italia, impressioni di viaggio, Rizzoli, Milano 1951.
Mayer H., La lite tra Heine e Platen, in I diversi, Garzanti, Milano 1977 (poi 1992), pp. 194-209.
Miglio C., Le strade del desiderio in Heine e Platen, in “Il Manifesto”, 7 settembre 2014.