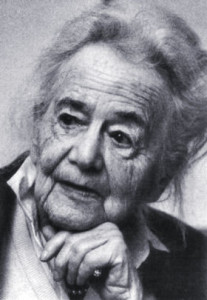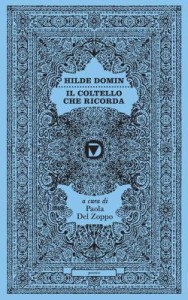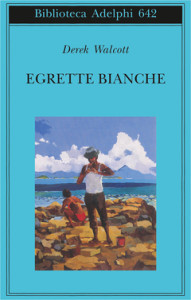di Andrea Galgano 20 novembre 2016
leggi in pdf Davide Rondoni e lo stupore di tenebra
 Il nuovo libro di Davide Rondoni (1964), La natura del bastardo, edito da Mondadori, scompone il frammento in chiarità sperata, mescola la luce buia in una traversata luminosa di «cuore sbranato e cuore niente» che raccoglie polvere e preghiera, domanda elementare e acqua, come ferita e incanto di viaggio sterminato e di fioritura aerea.
Il nuovo libro di Davide Rondoni (1964), La natura del bastardo, edito da Mondadori, scompone il frammento in chiarità sperata, mescola la luce buia in una traversata luminosa di «cuore sbranato e cuore niente» che raccoglie polvere e preghiera, domanda elementare e acqua, come ferita e incanto di viaggio sterminato e di fioritura aerea.
Lo sterminato viaggio cerca la profondità e l’esplosione deflagrata dell’essere in tutte le cose:
«rosa notturna che ho esplosa in testa / ferita dell’alba / cuore rovinosa festa / tremano le inferriate la cassetta di bottiglie i baci i mai / più / sterminato viaggio di cosa qui / passaggio dominatore / e tu / non sei più tu / uomo d’aeree fioriture / di rose / cerca la profondità, deflagrazione / dell’essere in tutte le cose».
In Rondoni convivono due anime: quella incontaminata affermazione della presenza dell’essere e la dismisura attonita dei dettagli di ombra e silenzio luminoso, come se ad accompagnare il tempo dell’io ci fossero due schegge di spavento e incanto, sospensione sbagliata e attraversamento d’infinito.
Scrive, infatti, Alessandro Zaccuri:
«Lo spavento e l’incanto rappresentano da sempre i poli più riconoscibili nella poesia di Davide Rondoni. Spavento come consapevolezza del rischio, però, non come rifiuto della realtà. E incanto come apertura alla vita, non come compiacimento di sé. […] In questo canzoniere recalcitrante – nel quale la ripresa a distanza di temi e lemmi ha la stessa funzione delle rime che si ritrovano ad emergere con quieta necessità – le cronache d’amore si mescolano di continuo con le vicende della contemporaneità, tra la provincia italiana e i sommovimenti laggiù in Siria o in qualche altra parte del mondo che d’ora in poi non sarà più lontana».
È l’esito di una chiamata delle cose, la sospensione dell’infinito come «una sbarra che ci traversa», l’imperversamento della Natura, il richiamo bisbigliato delle cose che mescola e imbastardisce, riflette il gemito della bellezza come un sigillo lavorato nelle oscillazioni dell’universo, nel vuoto e nella domanda ultima, aperta nella finitudine:
«Cane, o / bestia o infinito d’un infinito, cosa / sei un dio, un festone / dimenticato / appeso ai rami ai fari in discoteca / viso oscurato che pulsa / un niente / in questa notte l’universo / oscilla, in questa notte / l’universo esce a bere / cerca energia / in un altro big-bang, in un altro quartiere? / dopo festa / dopotutto ipermercato vuoto / come se avessero telefonato: ragazzi / l’alluvione, prendete / ogni cosa che potete – / o deserti scaffali della testa / vetro che perde / la scritta nel fiato / ti chiamano energia oscura del creato / mormorare di colpo: tutto amato tutto andato? –».
La natura bastarda ha la cifra dell’assoluto come segno, meta colta nel soffio del vivente e nella beatitudine estrema di ciò che compie, nell’aria persa dei «sedili di un’auto abbandonati sul pendio / schienale sudicio davanti al cielo, / la città strana scena, follie / e oblio / vedi l’alba? la notte come grande nave ci abbandona / ritira l’àncora di stelle, la sua catena / tra le costole mi suona…».
La poesia non celebra il reale, si intesse con la sua trama segreta e oscura e con la concrezione delle immagini, i lampi e i detriti, che sono nulla senza desiderio senza fine, senza il grido dell’alba, senza la luce folle della gloria: la prima occhiata aperta nell’aria allarmata, i ventagli infiniti e la resa delle stelle:
«Se non hai nella fessura da cui ti entra il porco mondo negli occhi almeno la piccola luce febbrile di un desiderio senza dine, e non guardi mai come grida l’alba anche su luride vetrate, non perdere tempo, non è questa roba intrattenimento – qui come in un sacco di poesie si dicono al vento cose dure e fantastiche, del tipo: / nessun albero / crea la luce folle della sua gloria, / dopo la notte di blu lampi e detriti / la prima occhiata aperta nell’aria allarmata / trova il perdono del rosa, i ventagli infiniti – / tira fuori una birra, il sorriso più antico che hai, ha forse fine il mistero del mondo? L’ultima stella a cosa si arrende quando l’alba dal giorno è divorata dolcemente? sei forse tu chi accende i primi neon nelle fabbriche gli occhi di tuo figlio, i fari dei treni sui binari ghiacciati? / nessun battito d’ala o di cuore / crea il luogo e il tempo / dove si arrischia e distende».
La fame dell’essenziale, la fame bastarda, il mormorare della natura e del destino è un’uscita verso il cielo tra le rovine di Roma e la linea A della metropolitana. L’amore, no, non è mai giusto, non penetra soltanto nelle fibre, compie uno scarto, una chiamata, una promessa che profuma di dismisure e verticale desiderio.
È viaggio, avventura, forza di abisso, non già per lo sconvolgimento quanto piuttosto per il suo sproposito di grido e fiamma che muove, perché fa nascere cose protese che non finiscono qui, come arde un velo oltre la giustizia e la giustezza:
«L’amore non è giusto / il ventaglio duro / splendido dei rami / si apre contro / il viola azzurro / mattini, sere / l’amore è un albero ma il fusto / s’inabissa, deve sparire / per nutrire / lo slanciato assenso che dà all’aria / e lei in un felice incendio lo incorona – / l’amore è un ragazzo che quando gli parli / fa un altro discorso / occhi lupo bianco, nubi / fa nascere cose che non finiscono qui / ma fuori dalla giustizia, in terra e in cielo / – e brucia sempre nell’aria il suo grido, / come arde un velo».
Il nascondimento, la sospensione delle cose, le esistenze delicate sono affermate dall’io che le guarda. La realtà (il suo sperdimento spaesato e la sua fioritura indocile) esprime la sua lontananza infinita di troni d’aria e inseguimenti.
Esiste una leggerezza indomita di tracce dimenticate e recuperate come collisioni dorate e immensità di universo. La muta sventura è un pianto salvato.
Il cuore decifra e insegue, nasconde le cicatrici dove «i mari invernali della mia mente cercano ancora / le tue dita d’aurora – anche dal vetro opaco / mi hai toccato le labbra – / ti cerco sempre nuova / vita, / impestato di te, gioia senza possibile cura».
Ma è ancora l’amore a opporsi alla fine, alla morte, al limite, a ciò che basta:
«bastami non bastarmi amore / fai giorno insinuando il tuo sguardo / sotto le palpebre / cucite / imbastardisci me / di te / nelle vie dove allunga le dita l’aurora, nei bar / dopo la chiusura / il tempo dell’ultimo attacco / sta venendo / in un’alba come sempre quando / la prima luce alla tenebra s’afferra / e da ogni parte si svuotano / parcheggi, muovono eserciti, stormi / s’alzano da terra e / iniziano a mormorare le maree — / toccami la mano, danzatore ferito / ritmo che mi batti / spezzato, infinito».
Il mormorare della realtà non è solo il dettaglio attraversato e trascritto che ricorre in tutte le sue sfumature, bensì è sospeso attraversamento (lei guarda la scrittura dei rampicanti), epifania guerriera e improvvisa come presentimento e sospiro sulle labbra.
Tutta la bellezza che compone il teatro della scena del mondo è fatto di segni e attraversamenti, stupori e transiti che incendiano l’orlo dei cieli e le luci notturne, grido delle stelle a miriadi e bagliori lontani, e ogni lemma dice ciò che accade, lo frastaglia, lo dispiega in tanti volti, varchi e passaggi che avvisano lo splendore:
«L’isola da lontano lanciava ancora bagliori, feriva / gli occhi, forse segnali millenari, sogni, / fiori bianchi a miriadi di notte sulle scogliere… / Palermo, sono dolci le sere / a camminare sperduti / dopo aver lavorato, sfiniti / e la mente non sa più che pensare / vuole solo sentire lui / il respiro del mare… / E tu che gesticoli al telefono e vai / ti discosti e mi lanci un’occhiata / ragazza maghrebina, / dolce, ferita, innamorata – / e mi ricorda ama, senza disperare / ama con dolore, / bastardo trovatore, ama / per non meno di questo avviso di splendore».
L’attraversamento del mondo strepita, allora, negli istanti, e nella strana gioia nel petto, come un appuntamento o una presenza, e persino la tentazione del vuoto. Ma nel termine più oscuro rifulge qualcosa di inaspettato che visita e promette.
L’unica forza smisurata è un gesto che riscopre il battito del mondo, nessun riparo nell’aria che risale. E poi ancora sconfinamenti, latrati perduti e l’ombra del grande strano splendore («Venne il bacio, uno solo e leggero sul fiume – / niente lo avrebbe motivato mai / nessun circuito o apprendimento neurale / solo quel grande strano splendore – / Poi tu o la tua ombra m’ha fissato serissima: / dimmi se lo sai, macchine non siamo, dimmi / non lo saremo mai, vero?»), in un Volto che si fa carne e ama da morire: «il Verbo, sorride, viene dal profondo / del cielo e della natura, stupisce i vivai di comete, le piogge bianche del sole / e si fa carne, ama da morire, ha un volto / un volto… imbastardisce pure lui…».
Nella poesia di Rondoni avviene sempre qualcosa di inatteso e di desiderato. L’amore delle mani giunte che ripercorre le linee fiato di Beatrice, il così sia senza fine e l’intuarsi come segno dell’impossibile. Farsi tu, essere tu come impazzito d’amore e la carezza dell’immiarsi, mondo risorto e suo segreto: «[…] – solo un impazzito / d’amore poteva senza potere più nulla, più nulla / inventare queste parole / Io mi intuo come tu ti immii / nella commedia umana e celeste / farla precipitare per le scale del suo dolore / qui tra i denti e i compostissimi furenti / baci, le tende rotte alle finestre / darti questa carezza è il segreto del mondo? / immiati, m’intuo e / spegni la luce che vediamo nella notte / sorgere la città».
La bellezza non è mai relegata in uno squarcio di affezione: è primaria, primordiale, solleva le trame del tempo, lo imbroglia, ne ferma il giogo. È il rifugio della casa sui crinali alla apertura degli occhi come un sussurro dinanzi alla tempesta, una domanda solo di amore alla musica sospesa del mondo: «L’alba sui crinali / dopo la pioggia / è indecisa / aperture del cielo / e tristezze dell’aria quasi color di perla – / un essere vola via dalla staccionata / percorro la strada deserta / odore fresco di gasolio e terra bagnata / da giorni / cerbiatti color cenere mi fissano dai campi / il verde nella foschia si prepara a splendere – / che occhi inquieti contemplare / per dire grazie serrando la giubba del vento / la musica ancora segreta del mondo».
In questo lunghissimo e profondo itinerario i figli rappresentano la domanda di un mosaico senza fine che chiede a Dio di tenerli: Clemente, il più piccolo «attaccato alle spalle» («non avrò ricchezze da lasciarti / ragazzino che porterai il mio nome e quello / di mio padre, ma quando / c’è una curva da fare e non sai / cosa ti può aspettare / prepara gli occhi, prepara il cuore»), Carlotta («Finché si gonfierà il sole, figlia mia, / il cielo riprenderà fiato / si gonfierà, sì, esploderà il sole / in un silenzio smisurato / l’attimo finale dell’universo guardato da niente, nessuno / o saremo tutti presenti – mi dirai: “babbo…” – / ci cercheremo la mano / tutti lì in un attimo felice, perso?»).
Oppure come il canto irrotto per la madre, stremato e immenso fondo:
«Quanto sono stato lontano da te / come se dovessi consumare con tutte le forze l’amore / che mi hai dato / e in tutti i viaggi / e baci e parole cercare stremato il fondo / di quel che mi hai donato / Non c’è posto del mondo, non c’è delirio / che non abbia il tuo sorriso, il tuo martirio, / ma non hai reso dominio la tua femminile vastità / Sei divenuta il silenzio alto della valle / mia madre, albero fiorito alle mie spalle».
La comunione delle parole è un profilo di grazia. Nella rastremata durezza veggente della guerra imminente, in un rosario-gesto impotente e glorioso, nel respiro farfalla tra le labbra che mette in fuga gli stormi della paura, il mare diventa impronta notturna di buio che consegna l’umano alla sua stupefatta mortalità, lungo la danza violenta delle stelle:
«Parla al buio il mare / riflessi d’oro, fanali sospesi / parla al buio il mare / parla al buio / riflessi / fanali, / l’oro dell’inverno, noi così stupidi / magnificamente mortali / all’uscita dall’hotel / l’ho sentito dalle rive gridare / cupa e azzurra forza, così solo / oltre la statale, sotto la non luna / le stelle rotte / le sue immense non parole / che sanno tutto, / come nasce l’onda / e si inabissa l’amore».
O come in una consegna gonfia della vastità, la vita si ascolta nel suo segreto esploso e ineffabile che rinasce inerme e senza ritorno:
«Non ridarmi più indietro / quel che mi hai rubato, la luce ultima, / la quiete, via / l’albero esploso della mente / non ridarmi più quel che mi hai / strappato / non ridarmi indietro niente, meglio / finire in te che morire me / in me solo / tieniti tutto, dimenticami – / perdimi / dentro di te, completamente».
La vera destinazione dell’umano si compie solo amando, è una fretta di assedio, è una lotta con l’indicibile nudo: uno strappo, un luogo fisico e ubriaco che non finisce mai, assetato di senso, ebbro di nodi, che si annida nelle nostre traversate, nella nostra esperienza, nel nostro giudizio come cammino di verità. Strappato in tutta la sua forza di abbandono, in tutto il suo fiato di movimento e danza, nella essenzialità tesa e astrale di un abisso che trema e ama «la prima eternità / chiamata lontananza» come vita salvata:
«Possiamo soltanto amare / il resto non conta, non / funziona, / al mattino appaiono / la tazza, il vecchio pino, le zolle umide, fumo / dell’alito mentre apri l’auto / nel gelo. Potevano non apparire, non arrivare / più qui, alla riva degli occhi. E l’estate / c’era, c’è, nella calda bruna memoria / dei rami tagliati, / i visi diventano ricordi / le voci gridate stracci silenziosi, i denti conoscono il sapore / del niente e l’oblio che ha portici / e portici infiniti. Possiamo soltanto amare / strappandoci felicemente figli dalla carne / parlando d’amore continuamente / ubriachi feriti, vili / ma con gli occhi lucenti come laser / di fiori splendidi e il canarino nel palmo della mano. / Mormorare come dare baci nell’aria. / Il rametto profumato non si raddrizza / con i colpi della nostra ira, lo sguardo / di tuo figlio non perde il velo di tristezza / se glielo togli mille volte / dal viso…
Possiamo soltanto amare / fino all’ultimo nascosto spasmo / che nessuno vede / e diviene quella specie di sorriso / che si ha nell’abbraccio finalmente / di morire come scendendo nell’acqua.
Le stelle a miriadi saranno testimoni, e i venti / passati una volta accanto / sulla gioia profonda delle ossa / diranno: era fatto di allegria, amava, / oppure diranno niente e poi niente / per sempre. Possiamo soltanto amare, / il resto è il teatro amaro dell’impotenza sotto il sole giaguaro».
Ogni lontananza, in Rondoni, è prossimità. La luminosità delle figure oblique si accompagna alle soglie del bello imperioso e indifeso del mondo, all’ultima parola che si consegna, all’ultimo respiro che recide il nome dal niente traversando le nascite.
Non c’è incertezza di altrove, esiste l’altrove richiamato e ferito ma rilucente in tutta la sua pienezza mai rassegnata, in tutta la sua nudità crepitante. I luoghi della poesia sono dettagli eterni di un dispendio perpetuo che schiude la verbalità ultima e oscura allo stupore “bandito” e all’amore. È il suo sì, l’estremo e stellare sigillo con le lacrime sulle ciglia: «l’ultima parola / baciando in bocca la tenebra sarà: / meraviglia».
 Rondoni D., La natura del bastardo, Mondadori, Milano 2016, pp. 144, Euro 18.
Rondoni D., La natura del bastardo, Mondadori, Milano 2016, pp. 144, Euro 18.
Rondoni D., La natura del bastardo, Mondadori, Milano 2016.
Zaccuri A., Rondoni dà voce alla contaminazione che salva, “Avvenire”, 11 novembre 2016.