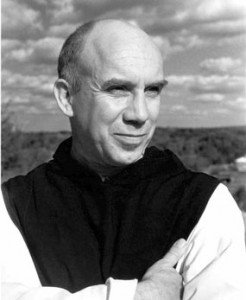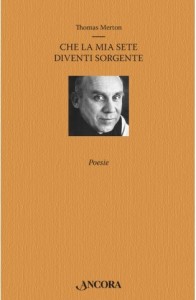di Andrea Galgano 12 novembre 2015
leggi in pdf Giorgio Orelli: La trafittura dell’attenzione

La trasparente immanenza di Giorgio Orelli (1921-2013) ticinese, scomparso novantaduenne nel novembre 2013, dopo una operosa e intensa attività di insegnante, traduttore, critico e studioso, formatosi sotto il magistero di Gianfranco Contini a Friburgo, abita una collocazione di margine e confine, che diveniva, tuttavia, come scrive acutamente Massimo Raffaeli, «virtualmente debitoria di testualità più centrali», laddove «una coscienza metalinguistica sovraordinata» avevano finito «in un primo momento con l’iscrivere nel senso comune l’idea che si trattasse di un poeta di grande dignità e rispettabilità ma privo di una propria e aggettante fisionomia. Né lo aveva favorito la precoce inclusione nella celebre antologia di Luciano Anceschi, Linea lombarda (’52), che lo riconosceva tra i più promettenti post-montaliani ma lo collocava ai bordi di una tradizione regionalista e, per così dire, «laghista». Solo il tempo avrebbe detto che immediatamente alle spalle di Orelli c’era sì Montale ma buon ultimo di una risorgiva che, transitando da Pascoli, si originava dal grande invaso di Dante».
Lo spasmo dell’attenzione intiepidita e dislocata al frammento, come testimonia la severissima scelta de L’ ora del tempo (1962) che raccoglie le produzioni precedenti, avviene nello specchio vigile di una presenza che segue il disegno dell’occasione oggettuale, riconosciuta in una affabilità quotidiana che crea sorprese e impronte corpose e immanenti, che oscilla, come annota Francesco Napoli, tra «disegni prevalentemente portati per tratti incisi e graffiti, animata da personaggi il cui accento realistico, pur evidente, sembra orientarsi verso vaghe valenze simboliche. E ci sono altre significative presenze, animali, comuni e non, formanti un autentico “bestiario” di più certa valenza simbolica».
La riduzione a frammento permette al poeta di incidere il suo spazio vitale, attraverso il ritaglio dell’istante, in una zona dicibile.
L’ora del tempo, allora, vista in una dimensione di calco dantesco, fa prevalere lo sguardo contrastato e contrastante di un tempo avverso e in fuga, quasi sversato dalle mani: «Penso l’inverno di questo paese. / Bianca stanza, orto solo, frutto nudo. / Scordati degli uccelli, i fili, i rami. / Di rovere le foglie, così brune, / se un soffio le trascorre come scricchiano: / colei che ne ha parlato è già lontana. / Penso la neve sozza, e intanto fugge / questo reo tempo, il cielo si fa bianco. / Contro l’occhio pervaso di sclerotica / la banderuola non si muove più» (Di gennaio).
Oppure la densa apertura dell’essere si rinnova in una trafittura che lascia segni ma cerca la sua propria fenditura di nascita: «ogni anno è un anno che passa. / Ogni sera c’è un vecchio che si sporge / dalla finestra, getta gli occhi / sulla strada, vuota rapido il vaso, / chiude in silenzio le imposte. / (Non vedo spesso che un candido braccio.) / Le madri sanno lunghe trafitture. / Ma ogni anno che passa è tuttavia / un figliolo che nasce» (Paese), dimostrando la correlativa presenza di due mondi accostati e incisi, racchiusi in una scrittura balba, tra i giocatori di carte e le capre che si rincorrono, urtandosi: «Le capre, giunte quasi sulla soglia / dell’osteria, / si guardano lunatiche e pietose / negli occhi, / si provano la fronte / con urti sordi» (Sera a Bedretto).
Scrive Tommaso Lisa:
«Nel suo fine gioco fonico-semantico frasi fatte, elementi linguisticamente opachi elevati, tramite la tecnica del tassello verbale, s’intrecciano al prestigio araldico di emblemi. Tecnica alla base dell’impersonalità della poetica dell’oggetto filtrata attraverso Eliot, la cui cifra traspare nelle descrizioni degli interni di Prima dell’anno nuovo, o in strutturazioni del décor vissuto come correlativo di situazioni esistenziali».
La concisione del tempo, la memoriale densità aggrumata, l’assembramento oggettuale, la lacerazione dell’aria, divengono cadenza di bozzetti e scansioni naturali che destinano il tempo a una cronologia segnata e netta di una sperdutezza corriva: «Per noi silenziosi / e freddi nelle mani che toccano / le canne del fucile chiamerà / la luna il tasso fuori dalla tana? / Ora sono fuggiti gli scoiattoli / che si rincorrevano a coppie sui pini: / la sera che ascoltiamo le canzoni / spegnersi tra le stalle dove crepita / acre la nostra infanzia, / forse gloriosamente / muore l’estate. / AI boschi bruni, alle pietre più grige / ci riconosceremo: anticamente / fedeli come gli occhi degli amici. / E sarà il tempo che le pernici / desteranno col loro canto i pascoli» (Per Agostino).
Quella stessa estate vola improvvisa, come un vuoto valicato di giorni, inscritto dalla mente: «[…] Siamo pochi, la sera un pastore / ci conta alla solita svolta / del sentiero, / toccandoci con la sua frasca la schiena. / Fischiano uccelli divisi / e valicano i limiti del nostro giorno: / ne resta un vuoto dove la mente inscrive / l’aquila che segnò lenta la fine / d’un’estate, d’un anno» (L’estate).
L’inclusività oggettuale coglie l’ora esatta in una istantanea segnata, come sostiene Lisa, in un «calco del reale incastonato nel testo […] per depotenziarne la carica emblematica e riportare la percezione del soggetto alla materialità del dato»: «In quest’alba che quasi non odora / di fieno e di letame / i padroni di tutto il Viale / della Stazione sono tre piccioni / partiti insieme da presso l’ardita / bottega ove si vende / l’orologio che segna / l’ora esatta per tutta la vita» (L’ora esatta).
La preclusione minuta di Orelli attraverso «una poesia degli istanti bloccati, del senso di valico insuperabile tra il soggetto e la realtà», che commenta Lisa «[…] mantiene il maggior distacco nella descrizione delle cose, degli interni, mostrandosi un realista nel rappresentare le situazioni in modo fotografico, aggiungendo una pronunciata pulsione scopica che sfiora il feticismo quando il microcosmo cantonale ricorda l’iperdettagliata campagna pasco liana, rinnovando l’ossessione per il “nido”, inventario di oggetti caricati affettivamente. Con questi scenari ticinesi a fare da amalgama, gli oggetti aprono l’autoreferenzialità del testo, intessuto di citazioni in un contesto colloquiale, a una dimensione extra-linguistica, definendo, attraverso la precisa rilevanza dei nomina, la saldatura tra la poetica dello sguardo […] e il fenomeno esteriore, portatore di nient’altro se non di sè».
L’elencazione esclusa e memorativa si coagula nelle impossibilità epifaniche dell’età adulta, mentre il fanciullo, «dondolando sul baratro, a metà / del suo viaggio, pareva uno spauracchio / con un secchiello in una mano, l’altra / stretta ad un cappio» e «per arrestarsi gli è bastato un piede, / un urto dolce, e già lieto sul prato / andava, colmo di latte il secchiello».
O ancora, la traboccante memoria acerba libera il frangimento di ogni ordine. I fanciulli che godono della protezione di santi sconosciuti, che appartengono al trambusto, si appropriano di un dialogo naturale infinito e senza cesure: «Ma se trabocca una memoria acerba, / è la trottola, ancora, liberata / da giovanili e fiduciose mani, / che sbaraglia l’immobile pattuglia / dei birilli ordinati in campo aperto, / s’insinua vittoriosa tra le mura, / a travolgere gli altri, i più codardi, / col consenso dei santi sconosciuti».
Questa memoria colpita e franta racchiude due linee che si intersecano pur non appartenendosi: la linea che non cade del fanciullo e l’interrogazione scoperchiata e sospesa dell’adulto nell’intermediaria posizione animale che connota il tempo, in un inventario trasfigurato e rarefatto di panorami e viste: «Perché il cielo è più ingenuo / splendono bacche rosse, / fanciulli seminudi / giocano coi superstiti camosci. / Gli scoiattoli uccisi / si sono ritrovati per salire / in lunga fila dal Padreterno / a perorare la mia causa» (Perché il cielo è più ingenuo), o dove la caccia strepita e la martora riconduce a una morte che restituisce la vita in tutta la sua arsi drammatica: «A quest’ora la martora chi sa / dove fugge con la sua gola d’arancia. / tra i lampi s’arrampica, sta / col muso aguzzo in giù sul pino e spia, / mentre riscoppia la fucileria»).
L’espressa gamma linguistica si attesta in un caleidoscopio che coglie l’arazzo dei contrari, il dettaglio sospeso delle alternanze come schermi di esistenza sparsa che non recidono, come annota Raffaeli, «quella antica radice percettiva: piante, animali, esseri umani popolano la poesia di Orelli senza l’ambizione di essere dei simboli o delle allegorie, sono presenze, figure, voci che si stagliano ad altezza d’uomo e si muovono nell’orizzonte d’attesa della pura normalità. Lo spazio e il tempo le immettono al presente e nel campo acustico/visivo con una naturalezza da brividi proprio perché nulla (nessuna metafisica, nessun credo, nessuna poetica predeterminata) le vorrebbe mai lì. E si direbbe che esse esistono, o che tornino a farlo, soltanto come tracce o impronte di una vita che è o che comunque è stata vera, dopo tutto e nonostante tutto».
Scrive Pier Vincenzo Mengaldo: «Questa attenzione smussa continuamente gli effetti di sorpresa che pure la poesia di Orelli produce col suo cannocchiale ora aperto ora rovesciato a cogliere il “piccolo”, e produce continue soste nella realtà, vista piuttosto nei suoi dettagli costituitivi che come massa: è notevole, in un poeta che mette in scena tante “cose”, l’assenza dell’enumerazione caotica, mentre è invece frequente l’anafora che separa e scandisce. Psicologicamente, ne nasce qualcosa che, senza escludere affatto la malinconia, si può chiamare ilarità».
Ma in questo occhio caleidoscopico, la ricca nomenclatura della realtà si comunica attraverso l’oggetto, la linea, la sfumatura. Procede in una vertiginosa pazienza che, montalianamente, offre la sua luce di bufera, virata di acciughe-rondini e foglie nei fitti argenti: «Tu credevi che fosse uno scherzo del vento / controcorrente: fitti argenti, scompigli / d’un attimo, là, presso gli scogli del molo. / ma erano le acciughe: lontane dai pesci più grossi / facevano bizze stupende fingendo le rondini quando / s’impennano nel volo e virano, le foglie / dei gàttici, la gola del ramarro, / le punte dei piedi d’Ilaria / toccate da una luce di bufera».
Il racconto mai disfatto di Orelli, messo a fuoco, nelle Sinopie (1977) è diario balneare e narrazione che porge il ritmo abile a saltare, come la trama del reale costituito in immagini trasparenti e frammentarie che riferiscono gli abbozzi preparatori dell’affresco umano («D’altri / pure vorrei parlare, che sono già tutti sinopie / (senza le belle beffe dei peschi dei meli) / traversate da crepe secolari») che giacciono sulle conversazioni, sui quadri familiari, sull’attraversamento di suoni e presenze in una quotidianità usuale e sfumata: «Calmo, limpido il mare / che prende e dà memoria / e a te darà sopra tutto salute. / Il cielo in qualche zona / ha l’azzurro nutrito dal ferro / delle ortensie sul Ceneri. / «Vieni», dici, « fa’ il morto, / è così facile.» A me / che appena il vivo so fare».
«Nell’arte di raccontare “per sinopie”», sostiene Antonio Porta, «Orelli è “il maggior fabbro”, il suo procedere per disegni nervosi prepara il miracolo della fioritura finale,quando, per un istante, appare il colore e il racconto non si conclude pur concludendosi, nel senso in cui l’immagine o il movimento finali tengono il discorso aperto e nello stesso tempo gli imprimono una direzione di significato».
Il suo arazzo intriso di colori, in «un arcobaleno allegro e muto», sosta nella quotidiana scena del mondo, dove la familiarità delle cose si incontra con l’attenuata disposizione della vita vivente e vissuta e dove l’ampiezza dell’ambiente ticinese fa sgorgare la sfuriata di una piccola danza di elementi, il cui continente irriducibile, come annota Silvio Ramat, diviene terra varia, «in quanto aspra e gentile, sognante e pratica, gremita di segni d’operosità industriale e tuttavia prodiga di robinie […] e di gelsi, di superstiti rogge e di marcite. Sinopie dà semmai più rilievo al bosco e al monte, al “fiorito errore” dei pendii, motivi di una quotidianità che si conferma prevalentemente extraurbana, e misteriosa la sua parte».
Orelli scrive, infatti, in Momento ticinese: «Proprio allora suonò mezzogiorno / s’udirono gridi / di bambini, e dall’ombra del nostro campanile / apparve, coperto di lamine per gli uccelli dei ronchi, / un vecchio. / Ed io ora mi chiedo: a che serve ricordare / come lampeggiava nel sole? come, / senza vento, strideva».
«Con il passare del tempo», scrive Pietro De Marchi, «del nostro ritratto non rimane che la sinopia: si smarriscono i vivaci colori della primavera e dell’estate della vita, ai quali allude la beffarda presenza della vegetazione rigogliosa, i peschi e i meli che ad ogni ciclico rinnovarsi della bella stagione si caricano di fiori e di frutti. I colori, nella poesia di Orelli, sono un senhal della vita, una «epifania del visibile nelle sue determinazioni più terrene e familiari», come ha scritto Maurizio Chiaruttini».
La naturale fenomenologia del dato, fatto di apparizioni e brevi passaggi che mutano il gesto e l’azione, si condensa in un’aperta mutevolezza di registri espressivi e stratificazioni fattuali (epigrammi, appunti di diario, racconti di viaggio, epistole satiriche), che diventano l’orlo del mondo dentro lo sguardo, la sua orbita d’attesa, serbando, come scrive Massimo Raffaeli «la memoria di attimi, la loro miracolosa perfezione, a eternarli se possibile in un giro veloce di versi che dallo scatto della clausola andasse a ritroso per successive vibrazioni, per onde acustiche e contrappunti fonici. Sono, queste, le adnominationes (paronomasie, figure etimologiche, poliptoti, anadiplosi) per cui la sua poesia va famosa ma, queste, non sono mai l’esibizione di una sapienza retorica bensì la necessaria intramatura, con ogni evidenza fonosimbolica, per cui l’immagine e la parola si incontrano ovvero il suono e il senso, in connubio e/o conflitto, si richiamano e infine si combinano», alternando ogni possibilità linguistica.
Con Spiracoli (1989) che richiama le fessure nella roccia per le quali entra il grotto d’aria, Orelli realizza il suo spezzone sull’orlo delle narrazioni, come se si scrivesse sulle briciole, come se si portasse aria negli interstizi delle geografie umane.
Scrive Tiziano Rossi:
«Le sue magiche e un po’ ipnotiche ambagi verbali sanno crescere pian piano su di sé, introdotte dal percorso che via via esse aprono, ma traducono soprattutto una straordinaria consonanza con le increspature del mondo, così sfrangiato e mobile. Ogni perdita del filo argomentativo, ogni smarrirsi in centrifughe minuzie si rivelano infatti come altrettante prensioni (e inglobamenti) di realtà apparentemente liminari, e come salutari rovesciamenti della gerarchia delle cose: l’effimero si fa eterno, lo splendore si appanna, il microcosmo vibra e si pronuncia…. È per questa via che la natura manifesta tutta la propria dovizia di sembianze e correlazioni, e ci intriga: ghiandaie, mosconi, faine, piccioni, corvi, asini, mucche, merli, capre, cicogne, nibbi, salamandre, farfalle, e glicini, betulle azalee, meli, girasoli (presenze che possono intersecare i nostri giorni) compongono sottili disegni sui quali non pendono verità decisive, né massime etiche generali. Le figure del regno vegetale e animale sono sia oggetto che oggetto di stupore, si atteggiano talora in pose ben educatamente impettite, talaltra salutano gli umani (e forse li giudicano) o additano insoliti spazi di libertà, e anche patiscono agguati, trasmutano, corrono pericolo e meritano compassione; ma in ogni caso il loro “meraviglioso” non è qualcosa di conferito a priori e non ha metafisiche valenze: la natura, insomma, è proprio naturale e non riducibile ad unum».
La farcitura linguistica di Orelli rappresenta l’orlo di una fascinazione improvvisa che aggiunge scene rasoterra, versi e luoghi pronunciati in una preziosa destinazione di fogli familiari e vertiginosi, dove si evidenzia la brevissima alternanza «fra il realistico e lo stilizzato, fra il “buttato via” (come si dice a teatro) e il letterario e il prezioso, tra il quotidiano e quello che possiamo chiamare il suo personalissimo surrealismo del quotidiano: con una sottilissima capacità di suggerire la natura sfuggente di quanto ci circonda. Ma anche di disegnare attraverso di esso […] l’immagine di quanto lo trascende e ci trascende, la lontananza di ciò che è vicino. Orelli, sempre molto autocosciente, ha scolpito tutto ciò in un bell’endecasillabo ossimorico che chiude una poesia di Spiracoli, nel «verzicante eterno dell’effimero» (Pier Vincenzo Mengaldo).
Ma è in questo verzicante eterno dell’effimero che si scova la disadorna appartenenza a luoghi e persone in un cerchio familiare, al frammento che scheggia il tempo e la vita, come sentenza polifonica e ironica, come esclamazione e interrogazione che appuntano e squinternano l’esistenza in un colloquio di radici: «È un attimo / diceva dentro il casco / quel peso mosca incavigliato in rossa / Kawasaki, / morosa stinta schiva / Povero cristo svagato è andato / poco dopo a insaccarsi che neanche / un kamikaze di Allah, / lei se l’è / cavata chi sa come, dicono» .
La linearità bandita che proclama il suo canto scorciato e profuso rappresentano, come annota ancora Tiziano Rossi, «il frutto agro ma necessario di una specifica porzione dell’essere, la propaggine imprescindibile di quella particolare (e maligna) cellula di realtà».
L’appartenenza alla materia vivente tratteggia la sua fenomenologia che cerca la vita dove si manifesta, il frammento che si piega alla gemmazione, al «colore difficile da dire», al territorio minimo che allude senza riferire.
L’asimmetria dei suoi alati tremori che origliano il «fresco smeraldo in l’ora che si fiacca», l’incerto confine come figura che si libra e traccia che si fonda nel profondo memoriale, condensano la trafittura di un mosaico, che come sottolineato da De Marchi e Beretta, contribuisce a far virare il testo «da una “scaglia” di fatti oggettivamente indeterminati ad un frammento-apologhetto liricamente vivido, che racchiude una narratività in potenza», e sottolineando come la visio di Orelli sia maggiormente tesa a una protrusione di alterità allegorica.
La fascinazione inclinata e araldica, per usare una espressione di Mengaldo, diviene quadrante visivo di una sibillina arcadica che ammaina il fiato in una densità di istante.
E in questo segreto consumabile, spesso il contraltare, come descritto da Beretta in Certo d’un merlo il nero, «è un’allegoria che ha come oggetto la morte – una “danza macabra” nella quale nel breve volteggiar di qualche giorno (quattro contati, poi l’ultimo è indefinitamente detto «un mattino») sono le trasformazioni di forma e di colore di un volatile ucciso e rimasto schiacciato «nel breve buio d’un sottopassaggio» (v. 4) a parlarci di una vitalità e sopravvivenza che, ancora una volta, è materica – qui addirittura obbediente alle leggi della chimica organica».
Il riscatto della vista, l’orlo che tocca i fiati di nebbia, l’essere che deborda senza coordinarsi, invocano ogni lontananza di incenerimento, sistemano, disseminandosi, le loro variazioni ancipiti e innalzando ogni morte stanca: «Così che di sull’orlo / più d’una nuova potè raccontarmi / lo spazzino-necroforo / esperto solo di trasmutazioni / rapide / e in un mattino / pareva lentamente incenerirsi / ma nei fiati di nebbia del ritorno / ancora suppurava / toccati di bianco volani andavan variando / protesi verso piogge / sottili, già primaverili».
La nuova vita che si annuncia poi si destina attraverso le petrarchesche esortazioni finali a una infinitesima variazione di orli e, come scrive ancora Beretta, «la presenza mai venuta meno dei “vivi” resti del volatile permette, si intuisce, allo «spazzino-necroforo» che non sa scorgere l’infinitesimale vita che ancora anima il merlo morto, dei commenti “di circostanza”. In questa “allegoria che ha come oggetto la morte”, come l’ho chiamata, l’elemento umano è dunque “cieco” […] e confinato all’«orlo» dell’evento positivo e portatore di speranza – la morte-metamorfosi del merlo»: «ditelo ai merli sui marmi invernali / prima che i fiori del diavolo / moltiplichino il becco / delirino azalee».
La permeabile cangiante mutevolezza cromatica, misurata attraverso l’interazione linguistica, come sostiene Ariele Morinini, che apre Il collo dell’anitra (2001), partendo da un passo del De rerum natura di Lucrezio (II 798-805), dispone l’interrogazione dell’io sulla frangiatura della luce indicibile che risplende, sulla vita, innanzitutto, ma anche sulla corteccia delle cose scostate, sviluppando una linea retta continuativa con le precedenti raccolte: «[…] Già nella luce stessa trasmuta un colore / se rifulge perché lo percuote obliqua o diritta; / così cambiano al sole le piume dei colombi / che di torno alla nuca coronano il collo, / e infatti talvolta sono rosse di fulgido piropo / e paiono talaltra mischiare all’azzurro il colore / dei verdi smeraldi», così come vibra la remota bellezza scialacquata di Altri cardi: «Viola del non-pensiero / neanche a due passi da me / astronauticamente / remota, perché / giochi alla donna assente / se perfino la fascia / d’ozono si risente / con te, con questa tua / bellezza scialacquata / di bar in bar e a zonzo / sul quai?».
È come se le cromature si dispongano a celebrare le lettere della luminosità, il passaggio cangiante delle cose, dove «i fiori lilla sui gambi e lì, / perfettamente combaciando le ali, / ognuna su un fiore pareva / suggere il paradiso»: «Non conosco l’azzurro / tuo preferito / che hai visto solo in Egitto / e il nostro esiguo cielo / di rado ti rammenta / e nemmeno, fra tanti, il tuo giallo: / non forsizia o mimosa, ma se mai / ginestra, con quel verde / tenace nel pietrisco, corniolo se mai, / quelle ombrelle graziose, o la nuova / farfalla che a un tratto ritorna / gialleggiando con altra / dove lucertole vagano liete / fra i nostri resti mortali».
I quadranti di Orelli, allora, poggiano la loro ascesi sull’epigramma funebre, l’invettiva, la prosa rammemorativa, la sospensione infantile che inventa linguaggi, il dettato allusivo e l’estate racchiusa in fascicoli. L’immagine del destino si racchiude nei cerchi familiari, nella «prossimità creaturale e nel distacco», come scrive Mengaldo, tra uomo e animale, nella bicicletta che guarda il mondo e lo ferma, nel riepilogo che annuncia istanti irriducibili e scandisce il ritorno allo scavo lessicale, ai dialetti che accertano scene autonome, alla citazione incastonata e, infine, alla «duplice declinazione dell’eteroglossia aleatoria dei frammenti di conversazione che si riverberano per «blocchi impensati» nel parlato interiore». (Agostino Casu).
Scrive il poeta: «”Noi che ci siamo conosciuti al margine di noi.” / Sì che / non è strano se non ti ho detto / ciò che sapevo ti sarebbe stato / a cuore più di tante altre cose: / se l’ho ucciso quel falchetto o no. / No, non l’ho ucciso, non / perché allora volevo che vivesse, / e mi chiedo: era un nibbio coda lungo- / forcuta? Una poiana / dall’iride variabile? un astore / cinerino? O quel becco / azzurro era d’un gheppio? / “Nevica, e le mimose / già fiorite si piegano.” A presto» (A Cristina), o quando ricorda gli amici Luzi e Sereni, quando tutto bastava a colorare le ore, persino un umano specimen: «Venendo in questo posto per me quasi / di vacanza in ogni giorno dell’anno / estero sottomano che bastava / a colorarci stranamente l’ora, / ho visto, seduto su un carro / di fini tronchi grigi / un ragazzo: di schiena, viola stinto / il berretto, un ginocchio / alto piegato a spostarmi / l’occhio dal lago alla neve dei monti, / così lucente a tratti / che in corpo non pareva più vivo».
L’orlo della vita, libro che si attesta sulla terminazione dantesca, che il poeta non è riuscito a terminare ed organizzare, ci permette di tracciare, grazie alla cura di Pietro De Marchi, l’estremità orelliana in tutta la sua concisione poetica, nella brevità episodica che rammaglia le occasioni transitorie e, in definitiva, il suo abbandono alla visione della realtà e delle sue peculiari relazioni, in tutte le sue minute trafitture e ascensioni splendenti: «Sembra eccessivo l’odore/ di gelsomino in cui vo ringioito / da una farfalla / bianchissima che vòlita / vantandosi di nulla / e in cima alla salita controvento / sbietta verso un giardino, / si posa su un corimbo/ di melo, si fa fiore» (Farfalla).
Commenta Massimo Raffaeli: «Orelli sembra tornato allo stampo più antico, a una specie di idillio, l’immagine segue il moto lieve quasi di un haiku, che il metro asseconda, la lingua assapora i nomi delle piante e si imbeve della loro patina in evidente stato di soddisfazione. Ma non c’è affatto idillio, semmai c’è un rito lento, inesorabile, di metamorfosi per cui la farfalla che sembrava svagata e perduta a un certo punto cambia direzione, trova il proprio ramo, si confonde con un fiore e, alla lettera, di colpo si fa fiore: nulla lo lascerebbe immaginare ma questo è uno dei modi possibili, e tra i più singolari, per alludere senza alcuna retorica a ciò che un giorno fu detto il sogno di una cosa».
È l’apertura di una frequenza iconica che poggia il suo significato sul ricordo e sul cerchio familiare, sul fantastico dell’infanzia e sugli spiragli dell’adolescenza, sulla liminale coscienza di episodi di viaggio, sul tempo della vecchiaia in tutte le sue sfaccettate epifanie, come vite in disparte, tratteggiate da pochi intimi lampi di umanità primigenia, fino all’oggettualità desueta della buca delle lettere, ad esempio, dove come scrive De Marchi, «l’io lirico si rammarica per gli effetti nefasti della razionalizzazione, che fa inopinatamente scomparire le gialle cassette della posta dai muri dove se ne stavano tranquille da decenni, come da sempre, circondate da una “natura naturale”, abbandonata a se stessa e quasi fasciata d’eternità».
È l’orlo della vita che dispone sull’abisso e sul suo margine d’ombra, il lembo che giaciglia e l’altalena che lascia cicatrici.
 GIORGIO ORELLI, Tutte le poesie, a cura di P. De Marchi, con introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo, Mondadori, Milano 2015, pp. 480, euro 22.
GIORGIO ORELLI, Tutte le poesie, a cura di P. De Marchi, con introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo, Mondadori, Milano 2015, pp. 480, euro 22.
ORELLI G., Tutte le poesie, a cura di P. De Marchi, con introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo, Mondadori, Milano 2015.
AA.VV., Poesia degli anni Settanta, a cura di Antonio Porta, prefazione di Enzo Siciliano, Feltrinelli, Milano 1979.
AA.VV., Per Giorgio Orelli, a cura di P. De Marchi e G.Torelli, Casagrande, Bellinzona 2001.
BERETTA A., Le «Metamorfosi» di Giorgio Orelli. Lettura di «Certo d’un merlo nero» da Spiracoli, e confronto con una redazione precedente finora inedita, «Per leggere», XII, 23 (autunno 2012), pp. 25-46.
BERNASCONI Y., Gli animali di Giorgio Orelli: “L’ora del tempo”, in «Rivista svizzera delle letterature romanze: fascicolo italiano, 2008, pp. 59-68.
BONALUMI G.- MARTINONI R., MENGALDO P.V., Cento anni di poesia nella Svizzera italiana, Armando Dadò editore, Locarno 1997.
CASU A., recensione a GIORGIO ORELLI, Il collo dell’anitra, Garzanti, Milano 2001 in «Semicerchio», (http://semicerchio.bytenet.it/articolo.asp?id=558)
DE MARCHI P., Dove portano le parole. Sulla poesia di Giorgio Orelli e altro Novecento, Manni, Lecce 2002.
ID. – RAMAT S., Un arcobaleno allegro e muto. Per gli ottant’anni di Giorgio Orelli, in «Poesia», giugno 2001.
ID. – MONTORFANI P., L’orlo della vita, in «Poesia», luglio-agosto 2013.
LISA T., Le poetiche dell’oggetto da Luciano Anceschi ai novissimi. Linee evolutive di un’istituzione della poesia del Novecento, Firenze University Press, Firenze 2007.
MARCHESINI C., Sulla poesia di Giorgio Orelli: «Sinopie» (senza le belle beffe dei peschi dei meli), «Forum Italicum», XXII, 2 (September 1988), pp. 163-175.
MORININI A., «Il collo dell’anitra» e precedenti: sulla lingua poetica di Giorgio Orelli, in «Strumenti critici», a. XXX, 3, settembre-dicembre 2015.
NAPOLI F., L’ora del tempo di Giorgio Orelli, in «Poesia», dicembre 1990.
PELLINI P., Il san buco e i sentieri da capre. Sulla poesia di Giorgio Orelli, Vecchiarelli Editore, Manziana 2004.
RAFFAELI M., Un poeta al Bagno Sirena: ricordo di Giorgio Orelli, 21 marzo 2014 (http://www.leparoleelecose.it/?p=14313).
ID., Orelli, l’idillio ticinese si fa immanenza, in “Il Manifesto”, 18 ottobre 2015.
ROSSI T., Spiracoli di Giorgio Orelli, in «Poesia», maggio 1989.
SEGRE C., Laudatio per Giorgio Orelli pronunciata a Lugano il 16 maggio 2008, in occasione del conferimento al poeta ticinese del Premio Fondazione del Centenario della BSI, «Cenobio», rivista trimestrale di cultura (http://www.cenobio.ch/index.php?option=content&task=view&id=257).