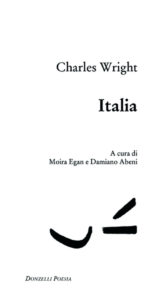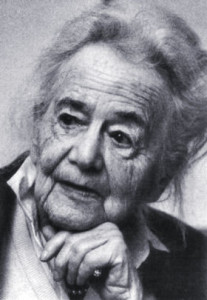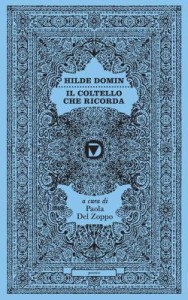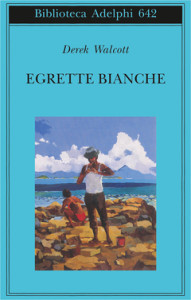di Andrea Galgano 5 aprile 2016
leggi in pdfJohn Keats, L’ultimo canto dell’usignolo
 La parola di Keats (1795-1821) affonda il suo movimento inquieto nelle sorgenti delle sue fondamenta ancestrali, nella solitaria prolusione della sua solitudine prima che trasmigra nella diurna luce che lotta con i notturni ad Hampstead, nel passo lieve che, partendo dallo zaffiro tepore Robert Burns, a cui dedicherà un sonetto struggente, denso di tremore e colori mortali, e la lingua anteriore alla materia tragica di Chatterton, e immergendosi nella perpetuità di Spenser, sussurra l’allegoria della vita urgente che si scioglie in un’allusione primitiva e sensuale, poiché, come scrive Cortázar, «Gli sono estranei i bruschi cambiamenti, le metamorfosi; come il fico celebrato da Rilke, John nasce frutto, senza lo spettacolo e la vanità di un fiore che lo anticipi»[1].
La parola di Keats (1795-1821) affonda il suo movimento inquieto nelle sorgenti delle sue fondamenta ancestrali, nella solitaria prolusione della sua solitudine prima che trasmigra nella diurna luce che lotta con i notturni ad Hampstead, nel passo lieve che, partendo dallo zaffiro tepore Robert Burns, a cui dedicherà un sonetto struggente, denso di tremore e colori mortali, e la lingua anteriore alla materia tragica di Chatterton, e immergendosi nella perpetuità di Spenser, sussurra l’allegoria della vita urgente che si scioglie in un’allusione primitiva e sensuale, poiché, come scrive Cortázar, «Gli sono estranei i bruschi cambiamenti, le metamorfosi; come il fico celebrato da Rilke, John nasce frutto, senza lo spettacolo e la vanità di un fiore che lo anticipi»[1].
La sua veggenza in tumulto è la cristallizzazione della memoria del suo universo apollineo, dove la parola si mostra vedendo, e canta le meraviglie mattutine, la pienezza della mete prossime, prima della sera di oro piumato e dei diamanti tremuli che sorprendono l’estasi dell’improvviso bagliore (A mio fratello George, vv. 25-26) e l’ampio portale delle luce sgranata:
Oggi le meraviglie del giorno voglio contare: / Il sole quando le lacrime bacia asciugando / Che riempiono gli occhi del mattino; – / Gli spiriti grandi, cinti d’allori, quando dal piumato / Oro della sera si sporgono; e la vastità del mare, / Il suo azzurro verde, le navi, gli scogli, le grotte, / Le speranze e le paure – la sua voce misteriosa, / Che chiunque ascolta pensar deve al futuro / E a ciò che è stato. [2]
La luce della natura rappresenta la sottile sostanza che irrora la placenta del reale, in una vigilanza poetica che avverte l’irruzione voluttuosa ed esterna di ciò che accade.
L’assedio delle immagini di Keats compie l’entusiasmo del suo miracolo di incanti verbali, di giochi di fantasia espressiva e di placide invocazioni alle divinità, alle quali porge il suo desiderio e i suoi simboli, e le esperienze diventano intimità fisiche e gesti creati dal tempo sensibile: gli steli affusolati sollevano i diademi delle stelle, tra le ombre inclinate nelle lontananze di cristallo e i sentieri interminabili dei boschi, il «suono senza suono» che scivola tra le foglie, le campanule e le calendule, le rugiade e i ruscelli, la gloria delle fonti e la carne della frescura del destino che enumera ogni infinità cosmica (Ero in piedi, sulla vetta sottile d’un colle).
Come il sonno che accompagna i germogli del papavero e dei salici e bisbiglia tenere nenie, arruffando le trecce di donna, promanando la poesia che giunge con il fragore di un sussurro soave del misterioso splendore che «ci respira / Attorno nell’aria libera» (Sonno e poesia, vv. 29-31) e ascolta la numinosa fragranza che erompe, nell’attesa di un’investitura di luce abbagliante, nel santuario di estasi, nel respiro di baie fiorite, dove un angolo alberato diventa l’Elisio. Silvano Sabbadini sostiene che:
Il problema etico coincide in Keats in maniera assoluta con il problema estetico: che la morte, il male, abbiano una giustificazione, che oltre loro si dia, appunto «qualcosa che è reale», coincide con la possibilità stessa che la poesia esista oltre l’epoca storica della sua morte. L’opposizione tra la realtà e il reale è al centro della riflessione keatsiana. Se la poesia, col secolo nuovo, è uscita dalla vita per trasformarsi in museo […], la funzione del poeta, e la sua fatica, saranno quelle dell’autonomia assoluta, una autonomia che coinciderà con l’autocreazione […].[3]
Il caleidoscopio keatsiano si sorregge in tutta la sua feconda visionarietà di foschia e riposo, nell’attimo in cui si scopre la nuda fertilità del cuore che desidera rubare i baci dalle facce scontrose delle ninfe, giocare con le dita e mordere le spalle tremanti «per un morso tenero e duro quanto le labbra possono» (Sonno e poesia, ivi, v. 109) e dove la poesia diventa «uno scroscio inesausto / di luce è la poesia; il supremo dei poteri; / una potenza semiaddormentata sul proprio braccio destro» (ivi, vv. 235-237) e la forza delle muse si nutre delle pietre e delle spine della vita.
L’enumerato e caduto inventario contiene lo slancio prolisso di una virulenta pacatezza che chiude il testo, ondeggiando: «Un lembo / Del manto erboso scivolando galleggia / Sui bordi dell’acqua, e ondeggia lieve / Sul cristallo del fondo, come quando / Calmo l’oceano solleva la sua distesa grandiosa / E levigata sulle rive rocciose, e fa oscillare / Le alghe pazienti, che perdonate dallo sciabordare / Tutta si sentono addosso la lor casa ondosa» (ivi, vv. 374-380).
La trasmigrazione amorosa di Endimione è un arabesco di visioni naturali, trascendenze e digressioni, in cui la ricerca dell’io-uomo-poeta della bellezza ideale[4] si spinge fino alla figuralità immortale di Cynthia, in un romance che altera il tempo e se ne appropria, aderendovi in una scoperchiata orlatura di bellezza, ancora immersa in un pulviscolo temporale:
Una cosa bella è una gioia per sempre: / cresce di grazia; mai passerà / nel nulla; ma sempre terrà / una silente pergola per noi, e un sonno / pieno di dolci sogni, e salute, e quieto fato. / Perciò, ogni mattino, intrecciamo / una catena di fiori per legarci alla terra, / malgrado lo sconforto, il disumano vuoto / d’animi nobili, i giorni tristi, / le perniciose e ottenebrate vie / della nostra ricerca: sì, malgrado tutto, / Una forma bella il drappo toglie / allo spirito triste. / Così sole, luna, / alberi antichi, e nuovi, germoglianti felicità d’ombre / per l’umile gregge; e narcisi / col verde mondo in cui abitano; e chiari ruscelli / che cercano un fresco tetto / contro la torrida stagione, il cespuglio nel bosco, / con la spruzzata di boccioli della bella rosa muscata: / e così anche la magnificenza del destino / che immaginiamo per i morti illustri; / tutti racconti belli uditi o letti – / una fonte infinita di bevanda immortale, / cola per noi dall’orlo del cielo (Endymion, I, vv. 1-24).
Come sostiene Simona Beccone[5], il rapporto che si instaura tra le diverse morfologie temporali tiene conto dei paradigma materiale, interiore e dell’emozione:
Il primo paradigma temporale è quello del mondo materiale, di cui Endymion fa parte (e che quindi corrisponde alla sfera dell’umano) e nel quale egli agisce e si muove (la sfera del naturale). Questo livello corrisponde al tempo della natura e dell’umano, inteso come successione lineare ed irreversibile degli eventi e dei processi in atto nel mondo materiale che, inevitabilmente, nascono, si sviluppano, decadono e muoiono. […] Il secondo paradigma temporale che emerge in altri passi digressivi e in altre immagini di Endymion corrisponde all’ordine temporale del divino e dell’assoluto, del quale fanno parte Cynthia e tutte le figure soprannaturali del poema e in cui sono anche inclusi alcuni elementi del mondo naturale che […] stringono un particolare rapporto analogico con quest’ordine temporale (come, ad esempio, le stelle e l’acqua). […] L’informazione narrativa di Endymion si regge su un frequente dialogismo di voci che, a turno, prendono la parola in una continua plurivocità. Tramite la voce che di volta in volta emerge nel testo, si manifesta un terzo ordine temporale, corrispondente a quello della sfera interiore e comprende sia il piano del pensiero razionale sia quello dell’emozione. Come luogo del pensiero e dell’emozione questo tempo della mente, che chiamerò tempo-psiche, è retto da una doppia logica. Da una parte, quando emerge il pensiero razionale e conscio, il tempo si configura come una successione lineare e irreversibile analoga alla struttura del tempo-durata. Dall’altra parte, quando invece emerge il pensiero emozionale, il tempo si configura come la dimensione della simultaneità e della ricorsività nella quale ogni istante psichico coesiste con tutti gli altri, si ripresenta ad intervallo costante ciclicamente e ricorsivamente ed è, per questo, affine al tempo-eternità. [6]
La dinamica percettiva e relazionale messa in atto da Endymion-Keats si ravviva quando l’esilità della tensione del rapporto con l’oggetto amato si rende minima mentre si dilata quando la distanza è maggiore, creando uno spazio asimmetrico di perdita e di abbandono.
La stessa epifania originale del trinomio natura-divinità-poesia dei circuiti del poeta è fame di un’umanità che non anela a placarsi e nel luogo della poesia trova permanenza fisica e ideale, non soltanto transizione accessoria. Keats rimane in una struttura profondamente metafisica, che anche nella morte di ogni visione, peraltro comunque irrimediabilmente destinata a perire, il reale si riconduce alla vita e alla sua origine: la realtà dell’arte è nel suo eterno presente, in quanto portatrice di un messaggio estetico e destinataria del sacrificio della nostra temporalità umana.
È il tempo che egli porta sempre nelle mani: l’indizio della simbologia mitica che prorompe in una continuità di poesia e visione tornando alle fonti. Aderisce all’antico per farlo vibrare di nuovo, in un computo di immagini fondali che ascoltano il mondo e ne fanno coseità sensuale, che incarna la bellezza e la verità del tempo esteriore e «quando il poeta non vede sufficiente bellezza attorno a sé, la crea (Endimione), ma quella creazione non si oppone, né sostituisce, né denuncia; quella creazione subentra nell’ottavo giorno, prolunga, senza negarla, la settimana della Genesi»[7].
L’esperienza del mondo sensibile, in Keats, si evidenzia attraverso l’immersione nel teatro naturale, percorso in una densità figurale che tocca vertigini e fondali, altezze ed astri, anfratti e recessi terrestri. L’evasione descrittiva addensa il suo centro propulsivo e fruitivo attraverso il piacere e l’inserzione divina, si appropria della fluidità del divenire e della vitalità in una concentrazione di gioia e dolore, fine e morte, transitorio ed eterno.
La sua dinamica interiore percepisce la passione in una interferenza di fioritura. È l’interruzione limitante della durata umana, perturbata dagli elementi materiali del mondo:
[…] Supponiamo che una rosa provi sensazioni. Un bel mattino, essa fiorisce e gode di se stessa; poi, però, sopraggiunge un vento freddo e il sole si fa ardente. La rosa non ha scampo, non può eliminare i suoi travagli nati con il mondo: allo stesso modo, l’uomo non può essere felice ignorando che quei travagli esistono, e gli elementi materiali prenderanno il sopravvento sulla sua natura. I corrotti e i superstiziosi chiamano comunemente il nostro mondo “valle di lacrime”. Chiamate il mondo, vi prego, “la valle del fare anima” e allora scoprirete qual è la sua utilità [.. . ] Dico fare anima intendendo per “anima” qualcosa di diverso dalla “intelligenza”. Possono esistere milioni di intelligenze o scintille della divinità, ma esse non sono anime fino a quando non acquisiscono identità, fino a quando ognuna non è personalmente se stessa (lettera al fratello George e alla cognata Georgiana, 14 febbraio-3 maggio 1819). [8]
Commenta Simona Beccone:
La rosa non è un elemento che sboccia e poi inesorabilmente è destinato ad appassire e morire descrivendo una parabola prima ascendente e poi discendente con un punto di partenza e uno di arrivo. Questo fiore è invece un elemento del mondo naturale che sboccia e, mentre “enjoys itself”, è disturbata dal “cold wind” e dall’“hot sun” che interferiscono ciclicamente sulla sua condizione di enjoyment. Quelle che Keats sta descrivendo solo due analoghe condizioni di godimento che accomunano la rosa (“enjoy”) e l’uomo (“happy”) e che sono entrambe caratterizzate da un andamento sinusoidale.[9]
Il dramma della transitorietà e del limite non si esplica attraverso una nostalgica sperdutezza[10] di un universo scomparso ma diviene irreversibile paradigma temporale, in cui la successione degli eventi impone trasformazione e finitudine, e laddove si viene a creare una forte sperequazione tra presente e passato. La sofferenza drammatica della attualità interiore afferma l’ansia della sua proiezione e, allo stesso tempo, la percezione franta di una tensione espatriata, laddove l’oscillazione degli stati d’animo si accompagna a una perdurata proiezione soggettiva che unisce gioia e distruzione, morte e malattia, respiro e interruzione.
Dove la natura rappresenta l’epifenomeno dell’eterno e del divino e, in particolare, della dinamica stimmung amorosa, declinata in ogni trasognata trasfigurazione possibile, dalla fluidità all’abito lunare della terra, dal colore delle acque al punto dello sguardo, dalle magiche fioriture alla danza delle brezze e dei papaveri, il raccoglimento dell’io avverte, inesorabilmente, il pondus della solitudine, infilato in un passaggio di tramonti e notturni, nel momento in cui le stelle ospitano il cielo.
L’incontro amoroso è lo stupore apparso che si offre alla percezione ma che, allo stesso tempo, destina la fine in un’aura sospesa di sogno e di separazione nominata.
La transizione[11] è lo strappo illusorio e disilluso di una dimensione ridestata che penetra nella trama conoscitiva. Non esiste più sospensione o desiderio bensì solo idealizzazione tracimata dalla veglia, nel momento in cui l’io porge la sua relazione alla frammentazione del tempo, all’enorme ricchezza sensoriale ed affettiva, in prima istanza, visiva, dove la sospensione dell’anima nel tempo è assorbita e sparita nel canto. Irrompe il pensiero, spodestando il sogno e le sue delizie affettive, lasciando vuoto e simmetrie interrotte:
Il piacere è un ospite frequente; ma il dolore / si stringe a noi crudelmente, come il bradipo che rode / il tenero fianco del cervo: tardi, a fatica, / è scacciato dal piacere lento a tornare. / Quanto nauseante, quanto fosco l’ozio odioso / di stanchi giorni, più intenso ancora, / per la pre-cognizione d’una notte insonne! / Simile dolore m’aggredì, anche più greve, / di quando abbandonai il colle dei papaveri: / e un’era lunga di lenti momenti mi strisciò / pigramente accanto, prima c’altra contentezza / spazzasse di colpo il melanconico livore di morte. / Sì, tre volte ho visto quel bell’incanto; / ancora una volta torturato da una nuova vita. (i, vv. 906-919).[12]
Il pensiero di Keats, e di poeti come Blake e Yeats, si impone all’attenzione della psicologia contemporanea, in cui l’Io dell’uomo matura, attraversando il punto più cieco della frammentazione del tempo. Sostiene la psicologa dell’arte Irene Battaglini:
Dal dominio incontrollato di questo “mito”, o meglio di questa più complessa dinamica mitopoietica [qui l’autrice si riferisce all’Apollineo che domina i compartimenti scientifici della psicologia e della medicina contemporanea, ndr], [13] discende quel processo che ha spinto tutto l’Occidente a degradare, in fasi successive, l’immaginazione, l’anima e il femminile: le tre dimensioni oscure che il Logos tenta di controllare, negare, ingabbiare. In questo testo rivoluzionario, “smitizzante”, Hillman riprende l’immagine del poeta John Keats in una lettera al fratello (1819): «Chiamate, vi prego, il mondo la valle del fare anima. Allora scoprirete a che serve il mondo».L’idea, anticipata nel Vala di William Blake (The four Zoas, Prophetic Books, 1797), è l’immagine che riesce più di altre a trasmettere la forza delle idee di Hillman, e che rimarca in Re-visione della psicologia (1983) citando Yeats da Sailing to Byzantium «.. . l’ uomo è ben misera cosa, /giacca stracciata su uno stecco, a me-no/che l’anima non batta le mani e / canti, canti più forte / ad ogni strappo nella sua veste mortale, / né vi è altra scuola di canto che studiare / i monumenti della sua magnificenza.. . ». Non sono proprio questi i poeti cui Meg Harris Williams e Donald Meltzer faranno riferimento nella loro indagine sul conflitto estetico? Il merito di Hillman è di aver re-introdotto nel dibattito interno alla psicologia termini che era di riferimento per la religione, la storia, l’epica. Aver quindi ricondotto all’interno della psicologia la mitopoiesi, la rilevanza dei temi cari alla Grecia, discutendo di Cristianesimo non in termini teologici, ma in connessione con le implicazioni psicologiche, psicopatologiche e cliniche dell’uomo contemporaneo. Se per Eraclito «I confini dell’anima, nel tuo andare, non potrai scoprirli, neppure se percorrerai tutte le strade: così profonda è l’espressione che le appartiene», in Hillman anima è il “fattore” del cambiamento, l’innesco del processo di trasformazione.[14]
In una lettera all’amico John Hamilton Reynolds del 3 maggio 1818, Keats, pur dichiarando di allontanarsi da Milton e Wordsworth, dispiega la capacità percettiva individuale in tutta la parabola umana, utilizzando l’espressione «Grande dimora con molte abitazioni» un prestito da Giovanni, xiv, 2, e sviluppando «la possibilità di confrontarci con un mistero; perché questa è la vita: nebbia e mistero da cui, afferma Keats, il poeta coglie sprazzi, brandelli di verità se riesce a sopportare il peso dell’incertezza»[15]:
[…] Paragono la vita umana a una Grande dimora con molte abitazioni, solo due delle quali posso descrivere perché le porte delle altre sono ancora chiuse per me. La prima in cui entriamo la chiamerò Stanza dell’Infanzia o dell’Incoscienza, dove restiamo finché non cominciamo a pensare. Rimaniamo lì a lungo […] non ci curiamo affatto di affrettarci; ma vi siamo alla fine impercettibilmente portati dal destarsi in noi del pensiero, appena entriamo in questa seconda stanza, che chiamerò stanza del Pensiero-Fanciullo, la luce e l’aria ci inebriano e non vediamo che delizie e meraviglie, e pensiamo di intrattenerci lì per sempre felici. Ma uno degli effetti di aver respirato quell’aria è che il nostro sguardo si è così affinato che ora vede fin dentro il cuore e nella natura dell’Uomo – e ci persuade che il mondo è pieno di Miseria e Crepacuore, di Dolore, di Malattia e di Angoscia – per cui questa Stanza del Pensiero-Fanciullo a poco a poco si oscura e allo stesso tempo su tutte le pareti si aprono delle porte – ma sono tutte buie, tutte danno su anditi oscuri. Non vediamo una proporzione di bene e male. Siamo nella nebbia. Noi siamo ora in questa condizione. Sentiamo il peso del Mistero […].[16]
Analizzando il processo di doppia significazione della realtà, Irene Battaglini commenta:
In Keats, conoscitore dell’inconscio naturale, uomo della “radura dell’essere”, l’infanzia dell’anima è orizzonte atemporale in cui navigano i paradossi della realtà. La realtà acquisisce una dinamica impropria, dissonante, in caduta libera nell’eclissi del cuore dell’uomo moderno, prima che risalga la corrente della tentazione – che si appresserà di lì a poco – di una deriva nichilistica. È nella dinamica concavo-convesso del sinusoide che si staglia il profilo della Valle del Fare Anima. Poiché fare anima è possibile soltanto laddove la luce si fa più oscura, e non sulle vette luminose dell’Io. [17]
E con Simona Beccone:
Il superamento della prima fase percettiva, quella dell’immediatezza del sentire guidato dalle “sensations”, coincide con il risveglio del “thinking principle”, o principio di ragione. […] In primo luogo, l’individuo prende coscienza del piacere delle sensazioni (nella prima fase solo immediate e senza autocoscienza) e si illude che questa condizione debba durare per sempre proprio in quanto le rapporta implicitamente all’ordine del tempo. […] L’avvento del “thinking principle” ha tuttavia anche un rovescio: esso comporta la scoperta che l’apparente permanenza delle “sensations” è un’illusione e, di conseguenza, la presa di coscienza che questa condizione di piacere non è destinata a perdurare. Il risveglio del principio di ragione coincide in questa fase con la consapevolezza della presenza del tempo-durata, che scorre e non permette di rimanere per sempre nella condizione di felicità data dalle “sensations”.[18]
La transizione dal sogno al risveglio viene ridestata dalla percezione circostante, sottile come una crepa, fine come un confine da ridisegnare, dove la rimembranza, antitetica a Leopardi è trama invocata di oblio, dispositivo memoriale, l’ultima venuta della nostra genesi, coniugazione parallela all’origine, lavoro vivo dell’istante[19] che si scioglie, si mescola, unisce (oneness) e culmina nell’intensità affettiva:
Dove sta la felicità? In quel che invita / le nostre menti pronte a una comunione divina, / comunione coll’essenza; fino a splendere, / del tutto alchimizzati, e liberi dallo spazio. Guarda / la limpida religione del cielo! Avvolgi / un petalo di rosa attorno al dito affusolato, / e rinfrescati le labbra; / taci, quando l’aerea enfasi / d’un bacio di musica impregna i venti liberi, / e con sensibile tocco sciogli / eolio incantesimo dai lucenti grembi; poi vecchi canti si destano da tombe cinte di nembi; vecchie cantilene sospirano sopra il tumulo del padre; / spettri di melodiose profezie delirano / attorno alla zolla dove posò il piede Apollo (libro I, vv. 777-790).
O ancora il costante splendore che incorona la frequente sospensione dell’apocalisse dell’edonismo umanistico[20] che destina l’amore alle sue appartenenze:
Sentiamo queste cose? – in quel momento siamo entrati / in una specie d’Uno, e il nostro stato / è simile quello d’un fluttuante spirito. Ma ci sono / più ricchi coinvolgimenti, incantamenti assai / più distruttivi del sé, che portano, per gradi, / all’emozione principale: la corona d’essi / è fatta d’amore e d’amicizia, e poggia alta / sulla fronte dell’umanità […] E questo è l’amore: il suo influsso, / sui nostri occhi, genera un senso nuovo, / al che trasaliamo e ci agitiamo; finché alla fine, / sciogliendoci nel suo fulgore, ci mescoliamo, / e così ne diventiamo parte (i, vv. 795-802).
Il principio di costruzione dell’Io, la negative capability, congiunta (e divisa) alla wise passivity di Wordsworth, ossia «[…] quando un uomo è capace di stare nell’incertezza, nel mistero, nel dubbio senza l’impazienza di correre dietro ai fatti e alla ragione […] perché incapace di rimanere appagato da una mezza conoscenza»[21], poggia il suo contenimento nella tolleranza nella convivenza con «con ambiguità e paradossi», per essere in grado, attraverso una sorta di eroismo tragico[22] di
accontentarsi di mezza risposta, di tollerare l’ansia e la paura: quella di restare nell’incertezza, nel tentativo di permettere l’emergere di nuovi pensieri o percezioni. Significa entrare in relazione con ciò che muta e che ci terrorizza senza cedere al pressante istinto a reagire, significa dunque tollerare una perdita di sé e sostenerla. […] La capacità negativa, se praticata seriamente, mette infatti a contatto l’individuo con ciò che Keats chiamava The Unknown, ciò che non si conosce, ciò che è di là da venire, che può essere colto solo da un’intuizione, ciò che nell’ambito poetico può essere chiamato in vita solo grazie allo sforzo creativo dell’immaginazione e che offre la possibilità di aprirsi a dimensioni sconosciute di sé e del mondo. [23]
L’ignota destinazione delle cose nel reale si accorda al dolore della perdita trasfigurata, all’unità prima dell’essere, al rivelarsi del poema filato dei segni del tempo piccolo, in cui la memoria è raffronto ipnotico astenuto. Il risveglio, pertanto, è eccesso statico. La tela dell’anima si placa nella veglia: tutta la realtà circostante, agitata e ammansita, assume connotazioni umane, in cui la relazione emotiva risulta essere una inner vision, densa di separatezza e finitudine che, persino nella coppia lessematica di opposti, condensa tutte le trasformazioni possibili, capovolgendo la gioia in minaccia:
La memoria non si dovrebbe chiamare conoscenza […] Ora a me pare che chiunque potrebbe come il Ragno filare dal suo interno la propria aerea cittadella – le punte delle foglie e dei rami su cui il Ragno si appoggia all’inizio dell’opera non sono molte, eppure esso riempie l’aria delle proprie circolari volute di squisita bellezza. L’uomo dovrebbe accontentarsi di appigli altrettanto scarsi sui quali appuntare la fine tela della sua Anima, e tessere un arazzo empireo – un ordito di simboli decifrabili dall’occhio spirituale […] la mente di un uomo può andare assolutamente per conto suo, incrociarsi con quella di un altro in innumerevoli punti, e ritrovarsi alla fine del viaggio. [24]
La descrizione di un lungo sussurro di viaggio compone tessiture, in cui lo svolgimento della scrittura è l’intimità prospettica del tempo che unisce memoria di stagioni e anxiety of time.
La dura gemma della temporalità diviene, quindi, scansione di memoria inevitabile, epifania di futura conquista, prima che tutto si nasconda in una coordinata e in un passaggio di tempo in transito che accompagna pienezza e crescita, presentazione di un mondo in relazione liminare con l’infinita gamma del proprio fondo e con la fragilità «che s’accompagna con le cose che sono solo potenzialmente vive»[25]:
[…] E, mentre l’anno / lussureggiante cresce negli stillanti steli, dolcemente guiderò / la mia piccola barca, per molte ore tranquille, / in acque che si immergono fresche sotto le pergole. / Tanti e tanti versi spero di scrivere, / prima che le margherite, orlate di vermiglio e bianco, / si nascondano nell’erba folta; e prima che le api / ronzino attorno ai globi del trifoglio e ai piselli odorosi, / sarò quasi a metà della mia storia. / O che la stagione invernale, spoglia e bianca, / non la veda incompiuta; ma il vigoroso autunno, / con l’universale tinta d’oro vecchio, / mi sia tutto attorno quando sarò alla fine (Endymion, vv. 45-57).
L’unione è stata interrotta e la delizia della pienezza è ora preda dilatata e infelice di un tempo non condiviso e smisuratamente lontano dall’oggetto amato, come accade ad Endymion: «Il rapporto tra melanconia e la percezione dell’ora non più da parte di Endymion è infatti di natura causale: il senso della transitorietà dell’unione con l’amata e del godimento delle bellezze del bower, che corrisponde alla consapevolezza della presenza temporanea del divino nel mondo (naturale e umano), è una coscienza dell’esistenza reale del tempo-durata che si pone come una causa dello stato di melanconia»[26].
Newell F. Ford sostiene, dunque, che il poema «è una sorta di gradevole miscellanea, un paradiso di squisitezze che mescolano mito naturale e passione, un giardino di caprifoglio rampicante e labirintici percorsi, un traliccio istoriato per grappoli di “belle cose”, terrestri, sotterranee, marine, aeree – “una piccola regione dove vagabondare” come Keats stesso l’ha descritta»[27].
L’eterna poesia è la gemma che contorna la sua esistenza, la dimensione senza fine che ordina la realtà e accorda la verità all’universo sensibile, la scompone in una extra-temporalità solenne che tocca l’essere in una solitudine ascensionale isolata che si svolge, senza attenuarsi, compiendo il suo “oltre” di tremori assoluti, in attesa di compimento e affermando il suo percorso «attraverso gli elementi, e il suo scopo è la trasformazione»[28]: «Ho scoperto che non riesco a vivere senza la Poesia – senza la poesia eterna – »[29].
La rimembranza keatsiana, pertanto, riattiva la ritrovata memoria personale, in un’antica melodia, in una immaginazione che diviene madre lingua dell’oblio, materia muta di memoria che libera il suo deposito fondo e il sogno di Adamo assunto come vero, creando simmetrie percettive tra entità mentali semplici e complesse ed
[…] è capace di dar voce nella sua forma funzionale, a quegli stessi pensieri, reali, che ha anche il suo lettore. In questo caso l’opera d’arte è il luogo dove l’autore e il lettore si incontrano a metà strada e si avvicinano empaticamente. […] La sorpresa di cui parla Keats («have you never been Surprised with an old Melody»), si genera nell’aspettato ritorno, della medesima emozione o dei medesimi pensieri, che avviene nella mente del fruitore del testo artistico e coincide con la rimembranza o con un ritrovamento del sé del passato nell’incontro rinnovato con l’opera d’arte. L’opera d’arte ha il potere di riscattare una precisa condizione emotiva e speculativa dal temporaneo oblio in cui si trovava e di ripristinarla esattamente come si era presentata in passato nell’anima individuale (“Soul”). [30]
Perché come afferma Simona Beccone, il periodo di vita intermedio, sviluppato nella percezione temporale e visto nell’intersezione della crescita dimidiata fra opposti[31],
è un’immagine della liminarità […] tramite la quale Keats caratterizza, sempre in termini temporali, una zona di transizione tra due dimensioni ontologiche differenti, come accade ne La vigilia di Sant’Agnese, l’arco di confessione e la veglia vicaria inscenano il preludio di immagini tremanti nella magia dell’atemporalità. In questo caso particolare, però, si tratta della soglia tra la capacità immaginativa e creativa inesperta e quella invece matura: [32] «La fantasia di un ragazzo è sana, e la fantasia d’un uomo maturo è sana; ma c’è un periodo di vita intermedio, nel quale l’animo è in fermento, il carattere indeciso, il modo di vita incerto, l’ambizione ha la vista corta: di qui vengono il sentimentalismo, e le mille sgradevolezze che quegli uomini appena menzionati necessariamente debbono saggiare procedendo nella lettura di queste pagine» (Teignmouth, 10 aprile 1818).[33]
Il vivente, declinato dalla domanda del poeta, unisce l’indeterminatezza alla affermazione, come soglia indecisa e raccordo di due epoche umane, che cercano compiutezza e desiderio impaziente. Scrive Cortázar:
In Keats gli elementi sono orientati alla sensibilità; ora egli misura l’orrore della sua scelta, della sua dedizione poetica verso una non-identità, verso il ritmo cosmico. Si sente annegare, invadere, dissolvere come il chicco di grano in terra, la vicinanza dell’elementale, di questa pioggia che lo conquista poco a poco senza che possa resisterle, gli rivela l’instabilità della sua persona, la sua elementarità.[34]
Pertanto, nell’elementarità del suo paradiso perduto, Keats, come scrive Nadia Fusini
«depone l’io come un re la sua corona […] esce dalla sovranità dell’io, intendendo un al di là dell’essere: un dis-inter-esse (così lo chiama), dove non l’io ma l’Altro sia sovrano» ed è grazie allo sversarsi oltre l’ansia, la febbre e la stanchezza e, quindi, «fuori nell’esteriorità del canto che può forse avvenire […] l’accesso al di là dell’essere». [35]
Il suo angolo santo proclama la conoscenza degli affetti e l’avvenire dell’altro in una dinamica di stupore, di sogno e di musicalità impressa, in una nebbia che attende l’estasi della sua incompiutezza, la penombra lenta delle cose, ferme nell’attesa sopportata nella capacità negativa, vissuta nell’uscita dell’io, proteso all’apertura della sua identità e arreso nella cura della relazione, dove misurare allora il luogo della poesia, la sua sensualità territoriale, l’abbandono dell’ideale per il reale.
Il poeta-usignolo esibisce la sua remota regione pura e perduta, e la sua scena ibridata di suoni che accostano territori lontani, che si immergono nel cono d’ombra della sua visione fantastica che dilata il crampo del genio nostalgico e dell’immortalità. La poesia scopre il velo di questa tensione che si inoltra nella caducità, nel bene eterno del suo canto, che, essenzialmente etico, coincide direttamente e proporzionalmente con il problema estetico configurato nella Bellezza immortale della sua vitalità disperata che dialoga con l’eternità naturale immutabile (è-ciò-che-è)[36]. (Ode all’Usignolo).
Il sostrato caduco dell’esistere vibra nella geografia di un grido che si dispiega e si dissolve, tentando persino di annullarsi in intossicazioni effimere e tattili[37] (i numbness pains: cicuta, vino, oscurità svanita) e vivendo la ottenebrata misura di gioia e dolore, colore e movimento, lotta e affanno, pienezza e privazione, arte e processo vitale che intensifica la fuga dal reale e la dissoluzione latente di malinconia.
L’usignolo, «arborea driade dalle lievi ali», che decifra l’estate con la felicità della gola spiegata incapsula l’io lirico del poeta in uno scenario di grido che percorre i faggi verdi e le ombre innumeri, che perlustra le sovraincisioni dei mondi e i teneri fallimenti, che trova ostacolo nella fusione con il canto integrale della natura: il dramma sensuale e saturo del poeta raggiunge la distorsione di un’esistenza incisa ed esclusa.
Keats intensifica la sua visione attraverso i parallelismi del mondo che guarda e le sue ascensioni celebrano la fuga di un desiderio di appartenenza e fusione in una pienezza che non è sua e che gli viene smisuratamente negata[38], per dimenticare la sua oppressione urgente, l’immobilità che distorce, la destituzione del colore[39], il compimento che non trova sponde e celebra l’intatta orma della Bellezza:
Sparire, lontano, dissolvermi, e dimenticare poi / Ciò che tu, tra le foglie, non hai mai conosciuto: / La stanchezza, la malattia, l’ansia / Degli uomini, qui, che si sentono soffrire, / Qui, dove il tremito scuote gli ultimi, scarsi capelli grigi, / Dove la gioventù impallidisce, si consuma e simile a un fantasma muore, / Dove il pensare stesso è riempirsi di dolore, / E la disperazione regna, dalle ciglia di piombo, / Dove la bellezza vede spenta la luce dei suoi occhi / E l’amore nuovo non riesce a piangerla oltre il domani. (vv. 21-30).
Sulla tensione di inappartenenza e di volo irraggiungibile e reciso che evade, così scrive Robin Mayhead:
Ci accorgiamo ora perché Keats non ha avuto torto nell’attribuire la sua depressione a «being too happy in thine happiness». Si immagina che l’usignolo sia felice perché non umano, perché non ha mai conosciuto «the weariness, the fever, and the fret» dell’esistenza umana. Il poeta sa troppo bene che la felicità che lui sente nel seguire fantasticamente l’uccello nel suo mondo «among the least» non può rimanere, dopo tutto è un essere umano, e ciò che è umano deve morire. La sua depressione è allora implicita nella stessa felicità. [40]
La tenera poesia fallita si immerge in una rarefatta atmosfera lunare che attrae e appaga, si scorge un baluginio di luce che attenua la profondità dell’oscurità nella sua foresta di intime fate stellate. La Bellezza si rivela nell’intuizione di una dolcezza soffusa, nella propizia stagione e nella partecipazione sognata di ciò che è intorno. Keats muove i sensi come grappoli visivi e gradazioni semantiche che ammantano la progressività delle stagioni, come la rosa muschiata, colma di germoglio:
E lì, con te, subito la notte è tenera / Con la sua luna regina sul trono / E le fate stellate tutt’intorno: / Qui, invece, adesso, non ce n’è più di luce, niente, / Se non quella che dal cielo è soffiata / Giù dal vento, nel buio verde e tortuoso di muschio. / I fiori che ho intorno, non il vedo, / E neppure l’incenso dolce che impende sui rami, / Ma nell’oscurità profumata intuisco ogni dolcezza / Con cui il mese propizio rende ricca / L’erba, il bosco e il selvaggio albero da frutta, / Il biancospino e l’arcadica eglantina, / Le viole, presto appassite, sepolte tra le foglie, / E la figlia più grande del maggio maturo: / La rosa in boccio, muschiata, piena di vino di rugiada, / Casa sussurrante d’insetti nelle sere estive (vv. 38-50).
Poi scompare questa luce e la morte («easeful Death»), oggetto di intensa riflessione, si dipana nella sua stanza interiore come requiem altissimo, in una gravida pesantezza di distanze e culmine poetico. Essa attenua le percezioni[41] e le fa scomparire, facendo desiderarla come cessazione[42].
L’ascolto dell’usignolo nella notte fuggente è l’ascolto del suo compimento attraverso il canto, e la sua voce «unisce il soggetto lirico a tutto il passato». [43] La frattura degli incantesimi lo riporta alla solitudine e alle sue terre deserte che ricompongono la frattura e la rimozione delle due esistenze parallele e in fuga ed esse «sono il mistero, ma non possono essere popolate da mortali, l’esistenza umana include un’ignoranza del mistero anche se il mistero è il principio centrale della vita degli uomini».[44]
Il poeta ritorna alla sua spazialità infranta del mondo, alla separatezza dell’accesso all’origine, all’invisibile che si porge, alla morte come subjectum della oneness, alla sua vita spezzata che inutilmente cerca di sconfiggere il fuoco fatuo del fenomeno, per afferrare lo stagionale passaggio dell’uomo in una transizione nella datità dell’immagine, in un passaggio simbolico ed onirico di visione che diventa rapporto e accesso allo spazio impensabile tra sensi e pensiero, realtà spirituale e materiale, e dimensione al di là dal mondo dove percepire l’atto secreto dell’intelletto, il suo dono immeritato e inscenando la dilaniata nostalgia del suo intimo bisogno:
La poesia non risponde di questo tempo e di questo mondo, per Keats. Essa è parola che sgorga in risposta all’epifania dell’infinito nel finito mondo delle cose e degli esseri: risponde di quel presentimento di altro che si sente nell’Ombra: desidera con l’Altro fellowship. Che vi sia poesia testimonia che v’è desiderio dell’Altro: desiderio di relazione con ciò che è a-venire, con ciò che si offre come l’incompreso, l’ignoto; e minacciato in certo senso di disfare le condizioni stesse dell’esistenza del soggetto che desidera. Di rubargli ad esempio la sovranità dell’io. [45]
Scriverà a Benjamin Bailey, interrogandosi sulla utilità dei long poems:
[…] Chi ama la Poesia non preferirebbe forse avere una piccola regione in cui vagare di fiore in fiore, e in cui le immagini fossero così numerose che molte se ne potessero perdere e ritrovarne delle nuove a una seconda Lettura? dove ci fosse cibo in abbondanza per una passeggiata di una settimana in primavera? Non preferirebbero questo a qualcosa che si fa in tempo a leggere prima che la signora Williams scenda le scale? il lavoro di una Mattina al più? Inoltre un Poema lungo mette alla prova l’invenzione che secondo me è la stella polare della poesia, come la fantasia è le vele, e l’immaginazione il timone. I grandi poeti hanno forse mai scritto dei pezzi brevi? [46]
La sua valle artefice costituisce lo scenario «mediante il quale e nel quale un uomo passa dal mero esistere all’essere», [47] e in cui la scomparsa trascendenza si attenuerà nella nebbia che costruisce l’io, per cui egli «vira continuamente ogni polarità al suo opposto»[48] e «[…] la forma della poesia è per Keats il luogo ove viene messa in scena l’assenza della conciliazione e il suo bisogno irrinunciabile, dove la dialettica tra sogno e realtà si risolve in quella «visione», in quella stasi epifanica che coglie nella sua fugacità il momento, proiettato in una nostalgia del futuro, della conciliazione». [49] Scrive infatti Keats:
Supponiamo che una rosa abbia delle sensazioni, fiorisce una bella mattina, è felice – ma ecco che viene un vento freddo, un sole troppo caldo, la rosa non può farci niente, non può eliminare ciò che la disturba; è qualcosa di connaturato al mondo come la rosa stessa: allo stesso modo l’uomo non può essere felice, la sua natura è soggetta agli agenti materiali. Il nome che viene comunemente dato a questo mondo dalla gente superstiziosa e fuorviata è “una valle di lacrime”, da cui dovremmo essere redenti da un intervento arbitrario di Dio e assunti in Cielo, – Che concetto ristretto e limitato! Chiamiamo per favor e il mondo la “valle che fa l’Anima”. Vedrete allora a che serve il mondo […] Dico “che fa l’Anima”: Anima in quanto la distinguo dall’Intelligenza – Ci possono essere intelligenze o scintille della divinità a milioni, ma non ci sono Anime – finché quelle scintille non acquistano identità, finché ognuna non è personalmente se stessa. […] Come fanno queste scintille che sono Dio ad acquistare identità – così da avere ciascuna una beatitudine propria all’esistenza individuale di ciascuno? Come, se non tramite il mondo? […] Chiamo il mondo una Scuola che ha lo scopo di insegnare a leggere ai bambini. Chiamo, il cuore umano l’abbecedario che si usa in quella Scuola, e chiamerò il bambino che impara a leggere, l’Anima fatta da quella Scuola e da quel libro. […] Il Cuore non è solo il sillabario, è la Bibbia della Mente, è l’esperienza della Mente, è il capezzolo da cui la Mente o l’intelligenza succhia la propria identità – così come sono varie le Vite degli Uomini – allo stesso modo varie diventano le loro Anime, e così Dio con le Scintille della propria essenza fra tanti esseri individuali […].[50]
Come accade nel III libro di Endymion, l’antecedente musa lunare, allora, svolge lo sguardo stupito nel tempo immutabile che serra il confine stellato e inciso, come apparizione mitica, come colloquio astrale solitario di minute verso ciò che è desidera la fellowship with essence, «relazione e dialogo intonato verso quell’essenza che è altrove»[51],
[…] e proprio sulla corteccia contro cui poggiava / aveva inciso una mezzaluna, e attorno esercitò / la sua bravura in minute stelle. L’albero rigoglioso / aveva gonfiato e inverdito la pia incisione, / ma non l’aveva cancellata» (Endymion, Libro iii, vv. 794-798), tra le sue ombre e la presenza d’aria, il labbro d’argento e il fruscìo dei rami, come un unico territorio altro e fenomenologico: «Quando il tuo respiro d’oro s’offusca a ponente, / furtiva esse ascende al trono, / e lì siede umilissima e tutta sola; / come se non ci fosse corteo al suo seguito; / come se il tuo occhio, sublime Poeta, non fosse volto / verso di lei con le Muse nel cuore; / come se le stelle ancelle non si tenessero in disparte, / aspettando i messaggi piedi-argentei (Endymion, Libro III, vv. 44-50).
L’algido fulgore di Fanny Browne attribuisce all’immobile poeta-amante, come il genio di Endimione sul monte Latmos che abbandona e si immerge nella bellezza e a cui Luna porge la sua diluviata lucentezza e la sua liminale fertilità, inarrestabilmente in attesa del suo amore dilatato, la sua specola extratemporale ed eterna che ripete la breve felicità avuta sulla terra: «Triste, triste / è stata la nostra attesa; ma sciocca paura / mi trattenne dapprima; e poi i decreti del fato, / e si convenne che, / uscendo da questo mortale stato / tu fossi, amore mio, per imprevista metamorfosi / fatto spirito» (iv, vv. 988-993).
La palpebra sublime di Endymion si appropria dello splendore cavo delle tenebre notturne, misurando il vuoto dell’abisso e la memoria-fondale, si unisce, altresì, con la materia per abitarla, elevandosi dalla terra e facendosi acqua, e si congiunge con il magma lunare del cielo in una materna cavità che salva e riceve.
La tensione protesa, la perdita, l’eremita fissità e immutabilità stellata, le purificate ed eterne acque in circolo che offrono la loro mobilità alla continuità del tempo, trasformandolo, le nevi che ricoprono divengono il segno cifrato del divenire e la comparsa di una tramutazione dell’oltre-tempo nel suo scomposto firmamento di allegoria onirica da decifrare che dilata il mito nella sublimità.
Fanny coincide con l’esistenza del poeta, con l’inguantato firmamento che li tocca, con la sua estate più vera. Non bastava il lucore albino dell’isola di Wight, né le farfalle, né la corrispondenza intensa e astrale a sottrarlo alla morte e nemmeno il nascosto anello. Un grido, una nostalgia che sospende le ciglia in esilio prima della morte, che annuncia il prolungamento dell’amore nell’oscurità, il grembo che traluce dalle finestre e dal cuscino:
Il mio credo è Amore; e tu ne sei il dogma. Mi hai rapito grazie a un potere cui non posso resistere; eppure fui capace di resistere finché non ti vidi, e anche dopo averti vista mi sono sforzato spesso di “ragionare contro le ragioni del mio amore”. Ora non ne sono più capace. Il dolore sarebbe troppo grande. Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te.
Tuo per sempre
John Keats.[52]
La totalità stellata è il frammento della sua esistenza postuma, come le ali di musa stropicciate che risalgono per imparare la pace perduta e i solari incantesimi, la luce del nuovo giorno, il mondo che si costruisce nel tormento dell’isolamento tremante:
Stella lucente, foss’io come te costante – / Ma non in solitario splendore sospesa sull’altura / Della notte a osservare, con le tue eterne luci accese, / Quasi paziente, insonne eremita della natura, / Le acque mobili nel loro scaro dovere / Di pure abluzioni per le spiagge umane, / O a contemplare le nuove, dolcemente scese, maschere / Di neve sulle montagne e sulle brughiere – / No – costante sempre, mai mutevole, vorrei risiedere / Sempre sul guanciale del seno dell’amore / Mio, per sentirlo sempre pulsare cedevole, / Per sempre sveglio in dolce inquietudine, / Per sempre, sempre udire il suo respiro tenue / E così vivere in eterno – o venir meno nella morte.[53]
L’amore che possiede fino a torturare, lo spavento della passione, la suprema impronta della morte, la meraviglia, la poesia che sanguina, come «se il verbo “esistere” non lasciasse, nella sua intransitività, transitare altro che verso se stesso, l’azione dell’esistere pare consistere appunto in un essere che non ha la possibilità del “sortire”»[54] e chiede la vivezza più pura del battito alla danza amorosa, immersa in Aprile o nel gigliato Giugno, prima dell’invasione violenta. Il suo inseguimento desolato conserva una sede santa e un fiore intoccato prima che il reale prorompi nella sua esile rottura, nel trauma mortifero, e nell’ultimo inchino della poesia (A Fanny). Scrive Mario Praz:
L’«io lirico» troverà piena espressione nelle Odi. In esse più intensamente, attraverso il presentimento della morte, il poeta sente la Bellezza, che immortale, impassibile, assiste al travaglioso vanire delle vicende umane intorno: generazioni e generazioni d’uomini s’inebriano per un ‘istante del canto eterno dell’usignolo, dell’armonioso lineamento dell’Urna eterna, e salutano morituri la perenne Imperatrice. In questa sua accettazione e dedizione a una Bellezza che placa l’ansia dell’anima dinanzi al mistero del mondo, si esalta il motivo dominante della vita del Keats. Le sensazioni che il poeta chiede all’amore – come ci attesta l’epistolario con Fanny Brawne – sono sensazioni di narcosi; desidera che la lettera della fidanzata sia come una pozione d’oppio.[55]
Anche l’anagrammatica[56] e onirica bellezza infernale del poema di Keats combina l’illuminazione della veglia alla mutazione invisibile della coincidenza di una relazione con una dama dagli occhi selvaggi, figlia di una fata e senza pietà, in cui il poeta-cavaliere si imbatte, che «è la Circe eterna, è la dominazione e la degradazione dell’amante sotto l’effetto dei filtri della maga»[57].
Il tono meraviglioso accompagna la narcosi e l’allucinazione in una traslazione di realtà che recano timore e tremore. Sopravanza al cuore il filtro di indocile appartenenza che questa figura reca all’amante, come una mappa di pendii gelidi e di attese solitarie e pallide, e immaginare significa trovare «l’immagine che tramuta in visioni ed eventi simbolici gli stati spirituali interiori: in questo senso il poeta è il “trasformato”[…] e in quanto tale escluso dall’esperienza ordinaria»[58].
Tale incompiutezza pervasiva accoglie la purezza di un annullamento, in cui il poeta sembra vivere la sua esistenza postuma e la sua mediazione di strumento poetico che libera, attraverso il memoriale di una descrizione ignota e di un’esperienza al di là del pensiero.
Lo straniamento, l’indolenza incendiaria, la solitudine e la sospensione attesa, i confini delle filtrate iridi, la disposizione dei soliloqui condensano la svanita percezione delle cose impassibili e l’architettura segreta della sensualità ellenica, dove la descrizione liminare e sub-lime accompagna il mistero oltre-tempo dell’ornato artistico dell’Urna, indicibile meraviglia[59]. Scrive Cortázar:
Se per Shelley – o, ai giorni nostri, per Valéry – la mitologia rappresentava questo comodo sistema di riferimenti mentali le cui personificazioni si spogliano da ogni convenienza temporale per conservare le proprie motivazioni primarie a mo’ di trasparente simbolo, Keats accoglie questa mitologia – meravigliosamente appresa nell’inopia di dizionari ed epitomi – senza altro fine che quello di celebrala liricamente, come se fosse suo diritto. La accoglie dall’interno, intera e viva, a volte come tema, a volte come concitazione poetica attorno a un tema. Non usa la mitologia; non l’ha eletta come strumento, come intermediaria. […] La sua poesia è l’esplorazione del mondo attraverso le sue forme attraverso le sue forme, il compiacimento di uno spettacolo. […] Preferire l’immagine di un poema all’immagine che la suscita – pur conservando in essa l’identificazione vitale con il suo supporto sensibile – costituisce una chiave della poesia di Keats. […] John sembra dirci che qualsiasi riuscita poetica è in sé catarsi sufficiente in cui il lusso sensuale e l’ilozoismo romantico possono raggiungere la somma bellezza senza spogliarsi dei loro più puri attributi.[60]
È, infatti, l’istante eterno, il battito esteso del respiro della forma che crea l’icastica stanza interiore della sua grecità[61], accostando
il senso dinamico, temporale del romanticismo con il desiderio classico di atemporalità, accordando alla poesia (terra di nessuno dove le categorie cedono e vengono sostituite da altre dimensioni) una fissità che non è un’interruzione, una forma magica in cui la vita e il movimento concepiti nel loro istante più bello si ripetono eternamente senza decadenza né eccesso.[62]
La persistenza della plasticità delle forme è l’indizio di una durata che si protrae nell’Eternità, dove si deposita il fulcro del gesto creativo, attraverso l’atemporalità che l’Urna porge[63]. Essa contiene il trascendimento di ogni avvenimento, ripetendo la sua fissità senza fine e incorruttibile. Ogni scena, ogni fregio avvengono nel loro apicale splendore di primavera infinita. L’accesso sacrale all’eternità delle piccole strade e dei piccoli paesi palpita nel suo rapito avvolgimento di domanda invocata e segreto compendio. La nostalgia di Keats è una rabdomante transitorietà che cerca il mistero inviolato e irraggiungibile per compiersi, l’atomo immune dell’urna che dilata il piacere verso l’infinito come grazia preservata e pura:
Oh, forma attica! Posa leggiadra! con un ricamo / D’uomini e fanciulle nel marmo, / Coi rami della foresta e le erbe calpestate – / Tu, forma silenziosa, come l’eternità / Tormenti e spezzi la nostra ragione. Fredda pastorale! / Quando l’età avrà devastato questa generazione, / Ancora tu ci sarai, eterna, tra nuovi dolori / Non più nostri, amica all’uomo, cui dirai / “Bellezza è verità, verità bellezza, ” – questo solo / Sulla terra sapete, ed è quanto basta (Ode su un’urna greca, vv. 40-50).
Prosegue Cortázar:
Le figure dell’Urna non acquisirebbero eternità senza essere inumane, non potrebbero mostrare perfezione senza accusare al contempo il loro assoluto isolamento atemporale. Infondere loro bellezza senza innalzarle troppo al di sopra delle nostre dimensioni era possibile solo tramite la fusione tra i piani, attraverso un avvicinamento che permettesse di distinguere meglio la lontananza. Keats inizia la poesia con un risoluto fluire di domande, quasi cedendo – e facendoci cedere – al fiume temporale.
Lì accade tutto e il poeta si meraviglia di questa vertigine successiva a cui il suo sguardo è sottoposto percorrendo il fregio. […] Dal tempo all’atemporalità, dall’umano al divino. Ma non al divino inumano, bensì al valore “divinità” com’era inteso nell’immaginario greco. Questi pastori e officianti sono alquanto più vicini a noi di quanto la loro marmorea eternità sembrerebbe suggerire. […] Ed è qui che il genio di Keats raggiunge vette poetiche inarrivabili: nell’emanazione, proveniente dalle immagini dell’urna, di una fine, dolce, quasi desiderabile malinconia […] che sfuma con un valore sottile il suo piacere altrimenti monotono, chissà.[64]
L’unione tra Eros e Psiche condensa la dilatazione del rapporto tra piacere e realtà, il verso dissonante strappato dal ricordo, l’estasi incendiata re cultuale di un’unione che crea l’argilla poetica, e ne incarna i barlumi divini attraverso la svanita gerarchia olimpica, la doppia dea irrisolta a cui la mente porge il suo saluto altissimo e la sua meditazione immanente e a cui tributare l’ardore sognante di una sparizione metafisica (Ode a Psiche).
Anche attraverso l’indolenza, un crampo di estenuata soglia senza luogo, come ne reca traccia la stessa Ode, Keats sperimenta «la prossimità all’estasi: esposizione fuori dall’essere», scrive Nadia Fusini, passando, quindi,
dal mondo esteriore, il mondo del visibile, al mondo interiore, […] perché è nell’indolenza, in quel punto di assoluta negazione di ogni attività, nella sospensione immobile che viene raggiunta quando tutte le cure si affollano insieme, sì che si tengono le une con le altre in equilibrio – che il poeta fa esperienza del reale. Il reale è per Keats precisamente ciò che c’è ancora, quando non c’è che questo nulla. [65]
I tre Fantasmi (Amore, Ambizione) incarnano lo spirito ozioso di un’Ombra lunga che dipana la sua scura presenza. La domanda del poeta tocca la scomparsa e l’apparizione fantasmatica come diluita proiezione:
Svanirono, e, davvero, ali io desideravo: / Pazzo! Cos’è l’Amore, dov’è? / E la povera Ambizione – nata. / Dalla breve febbre del cuore piccolo d’un uomo! – / E la Poesia – no, che una gioia non possiede / Dolce, almeno per me, come i meriggi di sonno, / O quelle sere imbevute in un’indolenza di miele; / Si, un tempo vorrei io, così al riparo dalla noia / Da non accorgermi del mutare della Luna. / E non sentire più la voce del laborioso buon senso (Strofa IV, vv. 31-35).
L’esito è il riflesso empireo di una realtà dilatata che si trasporta in un divenire d’altrove, presentificato e immaginato su cui sospendere il giudizio. Le larvali figure sfumano in un abbandonato dileguo di denso scampanio:
Addio, dunque tetre larve addio. Il mio capo / Non alzerete dal fresco letto dell’erba fiorita; / Non voglio mica nutrirmi di lodi, io, / Come un agnello d’una farsa sentimentale. / Svanite dai miei occhi, e ancora una volta siate / Figure in maschera sull’urna del sogno; / Addio, altre visioni ho per la notte, / E per il giorno di tenue visioni ne ho sin troppe; / Svanite pure, voi, fantasmi del mio spirito ozioso, / Via, tra le nuvole. E non tornate mai più (Strofa VI, vv. 51-60).
L’esplorazione del negativo si afferma anche nel capovolgimento della Bellezza e dell’oblio. La non-dimensionalità della prospettiva keatsiana si arresta nell’agone tra disperazione ed energia. La sommersione della «vigile angoscia dell’anima» è nell’ansia di trasformazione della malinconia accettata da stasi cinerea e discesa d’oblio a lucidità di movimento di un rifugio visionario. La pienezza dell’estasi visionaria:
Non immergerti in Lete, no, e non spremere / il vino avvelenato dell’aconito / dalle salde radici, né dovrai / sulla pallida fronte / soffrire i baci della belladonna, / grappolo di rubino di Proserpina, / né fare il tuo rosario / con le bacche del tasso, / né divenga per te lo scarabeo / o la cupa falena la tua Psiche luttuosa, / né sia compagno al tuo segreto duolo / villoso gufo; / perché l’ombra / sull’ombra troppo assonna / e la vigile angoscia / dell’anima sommerge (Strofa I, vv. 1-10).
L’immersione malinconica, allora, è la sua accettazione, e il risveglio dell’anima, assunto nel dolore, diviene principio generatore, dove la Bellezza si compie nella Malinconia, in un coesistenza inscindibile di piacere e fugacità, uniti nel santuario che rovescia i contrari, e la poesia a cui egli ha avuto accesso «non è qualcosa legato al fare dell’Io, né è soddisfazione o gioia dell’Io, ma uno spazio nel quale l’Io stesso si dissolve nella inconciliabile contemplazione degli opposti, nella celebrazione dell’origine, colta nel momento in cui la si vede perduta»[66]:
Ella dimora insieme alla Bellezza – / La Bellezza che deve morire; / e con la Gioia, la cui mano è sempre sulle labbra pel bacio dell’addio; / e vicina al Piacere doloroso, / che si muta in veleno mentre la bocca quasi ape lo sugge; / si, nello stesso tempio del Diletto, / Malinconia velata ha il suo santuario / sovrano, non veduta da nessuno / se non da chi contro il palato fine / con ostinata lingua sa schiacciare / i grappoli di Gioia. La tristezza / della potenza tua, Malinconia, / gusterà la sua anima / fra i tuoi trofei nubilosi sospesa (Strofa III, vv. 21-30).
La cronologia serena dell’Ode all’Autunno raccoglie l’aria casta del paesaggio e del linguaggio keatsiano, nel quale si risolve la coscienza dell’Io nel taglio e nella oggettività della visione, nella chiarità abbondante delle nebbie fertili e del divenire del sole che matura la terra, che propaga il suo ricordo delle venature della stagione matura, nella ampliata spazialità dell’autunno come approdo a una stagione della mente[67]:
Stagione di nebbie e morbida abbondanza, / Tu, intima amica del sole al suo culmine, / Che con lui cospiri per far grevi e benedette d’uva / Le viti appese alle gronde di paglia dei tetti, / Tu che fai piegare sotto le mele gli alberi muscosi del casolare, / E colmi di maturità fino al torsolo ogni frutto; / Tu che gonfi la zucca e arrotondi con un dolce seme / I gusci di nòcciola e ancora fai sbocciare / Fiori tardivi per le api, illudendole / Che i giorni del caldo non finiranno mai / Perché l’estate ha colmato le loro celle viscose (Strofa I, vv. 1-11)
La presenza mitica e immortale della Natura, celebrata nei soprassalti figurativi, diventa il personaggio dell’ode e
se il passaggio dal preminentemente “tattile” al “visivo” che si attua qui continua il tema del fluire del tempo nell’ode, d’un fluire sospeso in immagini che non si situa mai in un “dopo” ma in un “anche” secondo quel processo di spazializzazione cui già abbiamo accennato, occorre anche sottolineare come di nuovo il negativo sia tutto presentato in maniera implicita, ricompreso, per così dire, all’interno degli stessi gesti che denotano “ricchezza”. L’attività di questo Autunno-Cerere, colta, denota, ancora con paradossale esemplarità, solo nei suoi momenti di stasi, è infatti orientata verso polarità opposte: la ricchezza dei granai è anche spoliazione dei campi, e la falce, bloccata momentaneamente dal sonno, impende come la morte sul «fascio vicino coi suoi fiori intrecciati». Creatrice e distruttrice insieme del paesaggio che incarna e che lei stessa, nel suo accoppiamento col sole ha creato, questa divinità è pure lei sottomessa alla morte. [68]
L’esclusione e la coesistenza, in Keats, divengono fusione di vita e morte, finendo per riconciliarsi nella memoria trattenuta, nell’assenza, nella metamorfosi metaforica della sintassi sospesa come ultimo sogno:
E i canti di primavera? Dove sono? / Non pensarci, tu, che una tua musica ce l’hai – / Nubi striate fioriscono il giorno che dolcemente muore, / E toccano con rosea tinta le pianure di stoppia: / Allora i moscerini in coro lamentoso, in alto sollevati / Dal vento lieve, o giù lasciati cadere, / Piangono tra i salici del fiume, / E agnelli già adulti belano forte dal baluardo dei colli, / Le cavallette cantano, e con dolci acuti / Il pettirosso zufola dal chiuso del suo giardino: / Si raccolgono le rondini, trillando nei cieli. (Strofa III, vv. 23-32).
Bibliografia
A.A.VV. , Omaggio a Keats e Leopardi. Atti del Simposio internazionale in occasione del bicentenario della nascita di John Keats (dall’1 al 4 giugno 1995), Ist. Editoriali e Poligrafici, Macerata 1997.
Abrahams M.H., The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and Critical Tradition, Oxford University Press 1946.
Aske M., Keats and Hellenism, Cambridge University Press, Cambridge 1985.
Bari S., Keats and Philosophy: The Life of Sensations, Routledge, New York 2012.
Bate W. J. (a cura di), Keats. A Collection of Critical Essay, New Jersey 1964.
Bate W. J., The stylistic Development of Keats, Modern Language Association of America, New York 1945.
Battaglini I., Badlands: Bruce Springsteen suono e poetica. Frontiera di Pagine magazine on line. In stampa.
Battaglini I., Il corpo–sudario. Psicologia della transizione dalla tela alla performance nell’arte contemporanea. Aracne, Roma 2015.
Beccone S., La fenomenologia del tempo in Endymion di John Keats: tempo-durata, tempo-eternità e tempo psiche, Edizioni ETS, Pisa 2005.
Blackstone B., The consecrated Urn, Longmans, London 1959.
Bloom H., The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry, Cornell University Press, New York 1971.
Buffoni F., Keats e Leopardi i-ii https: //www. nazioneindiana. com/2011/02/06/keats-e-leopardi-i-parte/ http: //www. nazioneindiana. com/2011/02/13/keats-e-leopardi-ii-parte/
Camaiora Conti L., Themes and Images in the sonnets of John Keats, EduCatt Università Cattolica, Milano 2010.
Cortázar J., A passeggio con John Keats, Fazi, Roma 2014.
Fazi E., Bright Star. La vita autentica di John Keats, Fazi Editore, Roma 2010.
Finney C. L. The Evolution of Keats’s Poetry. Cambridge, Massachussets 1926, 2 voll.
Fiocco A., Il canto dell’usignolo: un conflitto tra realtà e immaginazione, CDL Tecnologia e didattica delle lingue (http: //webstreamer. altervista. org/download/Il_canto_dell_usignolo. pdf).
Ford N. F., The prefigurative Imagination of John Keats: A Study of the Beauty-Truth Identification and its Implication, Hamden, Connecticut 1966.
Frye N., A Study for English Romanticism, Random House, New York 1968.
G.B. Gorell R., John Keats: The Principle of Beauty, Haskell House Publishers, New York 1948.
Garrod H. W., Keats, The Clarendon Press, Oxford 1926.
Gittings R., John Keats, Little, Brown and Company, Boston-Toronto 1968.
Hill J. S., (a cura di), The Romantic Imagination, Macmillan, London 1977.
Hough G., The Romantic Poets, Hutchinson, London 1976.
Keats J., Endimione, a cura di Viola Papetti, Bur Rizzoli, Milano 1988.
Keats J., Leggiadra stella. Lettere a Fanny Browne, prefazione di Nadia Fusini, Archinto, Milano 2010.
Keats J., Lettere sulla poesia, Oscar Mondadori, Milano 2005.
Keats J., Poesie, Mondadori, Milano 2004.
Keats J., The Letters of John Keats: 1814-1821, a cura di H. E. Rollins, II, Cambridge University Press, Cambridge, Massachussets, 1958.
Mayhead R., John Keats, Cambridge University Press, Cambridge 1967.
Miur K. (a cura di), John Keats: a Reassessment, Liverpool University Press, Liverpool 1959.
Ou Li, Keats and the negative capability, Continuum International Publishing Group, London 2009.
Owen F. M., John Keats, AMS Press, London 1976.
Perkins D., The Quest for Permanence: the Symbolism of Wordsworth, Shelley and Keats, Harvard University Press, Cambridge (Mass. ), 1959.
Pettet E.C., On the Poetry of Keats, Cambridge University Press, Cambridge, Massachussets 1970.
Praz M., La letteratura inglese dai romantici al Novecento, Ed. Accademia, Milano 1968.
Rollins h. e., The Keats Circle: Letters and Papers, 1816-1878, Harvard University Press, Boston 1948.
Ryan R. & Sharp R., The Persistence of Poetry: Bicentennial Essays on Keats, The University of Massachusetts Press, Amherst 1998.
Sasso G., Il segreto di Keats. Il fantasma della Belle dame sans merci, Pendragon, Bologna 2006.
Stillinger J., Twentieth century interpretations of Keats’s Odes, Prentice-Hall International, London 1968.
Wasserman E. R., The finer tone, Praeger, Baltimore 1967.
Watkins D., Keats’s Poetry and the Politics of the Imagination, Associated University Presses, London 1989.
Westling D., The dialectical Criticism of Poetry. An Istance from Keats, Mosaic, V, 2, 1972.
Note
[1] Cortázar J., A passeggio con John Keats, Fazi, Roma 2014, p. 65.
[2] Keats J., Poesie, Mondadori, Milano 2004, p. 55.
[3] Sabbadini S., Introduzione, in Keats J., Poesie, Mondadori, Milano 2004, pp. xx-xxi.
[4] Cfr. Owen F. M., John Keats, AMS Press, London 1976.
[5] Beccone S., La fenomenologia del tempo in Endymion di John Keats: tempo-durata, tempo-ternità e tempo psiche, Edizioni ETS, Pisa 2005.
[6] Id., cit., pp. 16-17.
[7] Cortázar J., cit., p. 46.
[8] The Letters of John Keats: 1814-1821, a cura di H. E. Rollins, II, Cambridge Uiniversity Press, Cambridge, Massachussets, 1958, p. 101.
[9] Beccone S., cit., p. 26.
[10] Cfr. Perkins D., The Quest for Permanence: the Symbolism of Wordsworth, Shelley and Keats, Harvard University Press, Cambridge (Mass. ), 1959.
[11] Miur K. (a cura di), John Keats: a Reassessment, Liverpool University Press, Liverpool 1959.
[12] Keats J., Endimione, a cura di V. Papetti, Bur Rizzoli, Milano 1988, p. 125.
[13] Cfr. Battaglini, I. Il Corpo-Sudario. Psicologia della transizione dalla tela alla performance nell’arte contemporanea. Aracne, Roma 2015, pp. 109-110. «È in Myth of analysis del 1972 che James Hillman traccia le linee di una radicale revisione delle principali scuole di pensiero della Psicologia Dinamica, discutendo sia il pensiero di Jung che quello di Freud. Non si limita ad utilizzare il mito o ad analizzarlo, ma si chiede: qual è il mito che sta dietro all’analisi e la determina nel profondo? Un mito di dominio (e implicitamente di persecuzione), che risale ad Apollo e alla sua terribile ambiguità di guaritore e distruttore. Un mito trascurato dagli analisti, e da cui discende secondo Hillman tutta la pratica clinica positivistica, compreso la psicoanalisi».
[14] Ibidem.
[16] Keats J., Lettera a J. Hamilton Reynolds del 03. 05. 1818, in Id., Lettere sulla poesia, Oscar Mondadori, Milano 2005, p. 91.
[17] Battaglini I., Badlands: Bruce Springsteen, suono e poetica. Frontiera di Pagine magazine on line. In stampa
[18] Beccone S., cit., p. 41.
[19] Fusini N., Il libro dell’interrogazione poetica, in Keats J., Lettere sulla poesia, Oscar Mondadori, Milano 2005, p. xvi.
[20] Bloom H., The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry, Cornell University Press, New York 1971, p. 369.
[21] Keats J., Lettera sulla poesia, cit., Lettera a George e Tom Keats del 21. 12. 1817, p. 38.
[22] Ou Li, Keats and the negative capability, Continuum International Publishing Group, London 2009.
[23] Cervera A., John Keats e la Negative Capability. Come essere un educatore, insegnando inglese, cit.
[24] Keats J., Lettere sulla poesia, cit., p. 60.
[25] Frye N., A Study for English Romanticism, Random House, New York 1968, p. 131.
[26] Beccone S., cit., p. 51.
[27]Ford N. F., The prefigurative Imagination of John Keats: A Study of the Beauty-Truth Identification and its Implication, Hamden, Connecticut 1966, pp. 84-86.
[28] Blackstone B., The Consecrated Urn, Greenwood Pub Group, Santa Barbara (California), 1959, p. 117.
[29] Keats J., Lettere sulla Poesia, cit., p. 6.
[30] Beccone S., cit., pp. 132-133.
[31] Cfr. Bate W. J., The stylistic Development of Keats, Modern Language Association of America, New York 1945.
[32] Beccone S., cit., p. 137.
[33] Keats J., Endimione, cit., pp. 344-345.
[34] Cortázar J., cit., p. 161.
[35] Fusini N., cit., pp. xxv-xxvi.
[36] Cfr. Fiocco A., Il canto dell’usignolo: un conflitto tra realtà e immaginazione, CDL Tecnologia e didattica delle lingue (http: //webstreamer. altervista. org/download/Il_canto_dell_usignolo. pdf).
[37] Cfr. Garrod H. W., Keats, The Clarendon Press, Oxford 1926.
[38] Cfr. Hough G., The Romantic Poets, Hutchinson, London 1976, p. 174; Wasserman E. R., The finer tone, Praeger, Baltimore 1967.
[39] Secondo Gittings in questa destituzione cromatica si può rinvenire la morte del fratello George, morto precocemente di tubercolosi. Cfr. Gittings R., John Keats, Little, Brown and Company, Boston-Toronto 1968, p. 317.
[40] Mayhead R., John Keats, Cambridge University Press, Cambridge 1967, p. 72.
[41] Bari S., Keats and Philosophy: The Life of Sensations, Routledge, New York 2012.
[42] Cfr. Bate W. J. (a cura di), Keats. A Collection of Critical Essay, New Jersey 1964, p. 506.
[43] Fiocco A., cit., p. 27.
[44] Wasserman E. R., cit., p. 211.
[45] Fusini N., cit., pp. xxxi-xxxii.
[46] Keats J, Lettera a Benjamin Bailey, 8 ottobre 1817, in Id., Lettere sulla poesia, cit., p. 30.
[47] Cortázar J., cit., p. 238.
[48] Sabbadini S., cit., p. xxvi.
[49] Id., cit.
[50] Keats J., Lettera a George e Georgiana Keats. Domenica mattina 14 febbraio – lunedì 3 maggio 1819, in Id., Lettere sulla Poesia, cit., pp. 162-163.
[51] Fusini N., cit., p. xviii.
[52] Keats J., Leggiadra stella. Lettere a Fanny Browne, prefazione di N. Fusini, Archinto, Milano 2010, pp. 39-40.
[53] Id., Poesie, cit., p. 303.
[54] Fusini N., cit., p. xlvii.
[55] Cfr. Praz M, La letteratura inglese dai romantici al Novecento, Ed. Accademia, Milano 1968.
[56] Cfr. Sasso G., Il segreto di Keats. Il fantasma della Belle dame sans merci, Pendragon, Bologna 2006, pp. 27-30.
[57] Cortázar J., cit., p. 244.
[58] Fusini N., cit., p. xlii.
[59] Bowra M., The Romantic Imagination, Oxford University Press, Oxford 1950.
[60] Cortázar J., cit., pp. 275-277.
[61] Cfr. Aske M., Keats and Hellenism, Cambridge University Press, Cambridge 1985.
[62] Id., cit., pp. 278-279.
[63] Cfr. Stillinger J., Twentieth century interpretations of Keats’s Odes, Prentice-Hall International, London 1968.
[64] Cortázar J., cit., pp. 281-282.
[65] Fusini N., cit., p. xxxviii.
[66] Sabbadini S., cit., p. xxxi.
[67] Id., cit., p. xl.
[68] Id., cit., p. xli.

 Anime inquiete[1] di Isabella Cesarini, edito da Auditorium, è una ferita di abissi lucenti. Non soltanto per la molteplice galleria creaturale di voci che ne compone l’atto e la sfida, quanto piuttosto per lo splendore lacerato e umbratile che ordina il mosaico, in cui la mano è attraversata da una voragine e da una sospensione, e, allo stesso tempo, da una mediata testimonianza che si lascia restituire, che si porge, non ostenta, lasciando un sospiro e un grido di esistenze plurime[2].
Anime inquiete[1] di Isabella Cesarini, edito da Auditorium, è una ferita di abissi lucenti. Non soltanto per la molteplice galleria creaturale di voci che ne compone l’atto e la sfida, quanto piuttosto per lo splendore lacerato e umbratile che ordina il mosaico, in cui la mano è attraversata da una voragine e da una sospensione, e, allo stesso tempo, da una mediata testimonianza che si lascia restituire, che si porge, non ostenta, lasciando un sospiro e un grido di esistenze plurime[2]. Cesarini I., Anime inquiete. 23 storie per mancare la vittoria, Edizioni Auditorium Haze, Milano 2018, pp. 156, Euro 14.
Cesarini I., Anime inquiete. 23 storie per mancare la vittoria, Edizioni Auditorium Haze, Milano 2018, pp. 156, Euro 14.