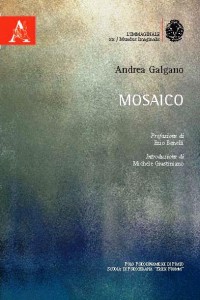di Andrea Galgano 26 febbraio 2014
letteratura moderna La lotta di Herman Melville
Il prezioso equilibrio tra allegoria e simbologia e tra esperienza vitale e magma narrativo trova in Herman Melville (1819-1891), l’indizio di uno scandaglio universale.
Il dettaglio minuzioso che scopre l’approdo di vita vissuta su terre sconosciute, che non teme l’arcaica promessa di un incanto selvaggio, come testimoniano Typee (1846) e Omoo (1847), si unisce alla pervicace sapienza analitica che compone cromature inaspettate e si appropria della minuzia dell’anima «che tutto il pensiero profondo e serio non sia che lo sforzo intrepido dell’anima per mantenere l’aperta indipendenza del mare».
Ecco cosa scrive Melville all’editore Murray, il 25 marzo 1848: «la ripetuta accusa di essere un romanziere travestito mi ha indotto finalmente alla decisione di mostrare […] che un vero romanzo mio non è né Typee né Omoo ed è fatto di materia totalmente diversa […]. Procedendo nella mia narrazione di fatti ho cominciato a provare per essi un inguaribile disgusto; e un desiderio di spiegare le mie ali in volo; e a sentirmi infastidito, ostacolato e inceppato dal dover arrancare con banali luoghi comuni».
La rivista inglese John Bull commentò così il prodigioso Moby Dick uscito nel 1851: «Fra tutti i libri straordinari usciti dalla penna di Herman Melville questo è di gran lunga il più straordinario. Chi sarebbe andato mai in cerca di filosofia tra le balene e di poesia nel grasso di balena? Eppure pochi, tra i libri che trattano professionalmente di metafisica o reclamano una parentela con le muse, contengono vera filosofia e genuina poesia come la storia del viaggio a balene del “Pequod”».
Del resto lo stesso Melville scrisse della sua lotta con i propri fantasmi: «Alcuni anni fa – non importa quanti esattamente – avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di particolare che mi interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. È un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. […] Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto filosofico Catone si getta sulla spada: io cheto cheto mi getto in mare».
Nel 1951 Cesare Pavese, traduttore e colui che per primo ha introdotto in Italia questo testo, un secolo dopo l’uscita di Moby Dick, parlando della perfetta fusione di Melville con Poe e Hawthorne, annota: «[…] In altre opere, come Typee, Omoo e White jacket, vediamo Melville ispirarsi maggiormente alle proprie esperienze autobiografiche. Moby Dick, invece, possiede una qualità stilistica molto alta spesso paragonata al linguaggio biblico. […] Si legga quest’opera tenendo a mente la Bibbia e si vedrà come quello che potrebbe anche parere un curioso romanzo d’avventure, un poco lungo a dire il vero e un poco oscuro, si svelerà invece per un vero e proprio poema sacro cui non sono mancati né il cielo né la terra a por mano. Dal primo estratto di citazione «E Dio creò grandi balene» fino all’epilogo, di Giobbe «E io sono solo scampato a raccontarvela» è tutta un’atmosfera di solennità e severità da Vecchio Testamento, di orgogli umani che si rintuzzano dinanzi a Dio, di terrori naturali che sono la diretta manifestazione di Lui».
La straordinarietà dell’opera congiunge un doppio movimento: l’epopea eroica, innervata nella luce, nel buio e nella lotta contro il male e la poesia metafisica di una tensione netta e distinta, in un continuo alone e in una affermata processione di condizione.
«Melville», scrive Paolo Gulisano, «realizzò l’epica della giovane America dell’Ottocento che aveva conquistato con la forza l’indipendenza, distaccandosi dalle sue radici britanniche ed europee, lanciandosi alla conquista di nuove frontiere. È l’epica di una nazione ma anche di un tempo, l’Ottocento positivista e scientista, che vuole sfidare le leggi della natura e di Dio, che con la tecnica decide prometeicamente di scalare i cieli».
Il romanzo narra infatti le avventure marinare, predestinate e fatali, del capitano Achab, assetato di vendetta nei confronti dell’eburnea (una sensazione di morte, di vuoto, di nulla) balena Moby Dick («se il suo petto fosse stato un cannone, gli avrebbe sparato il cuore»), colpevole di avergli mozzato una gamba.
«Chiamatemi Ismaele» è il celebre incipit (come il nome nel libro della Genesi di uno dei figli di Abramo) che raffigura l’inizio di una autobiografia spirituale, l’incendio di una lotta e di un archetipo, mantenuti su un livello evidente e costante di realtà, simbolo e esperienza universale: «Ma per quale motivo io, dopo aver ripetutamente fiutato l’odore del mare in qualità di marinaio mercantile, mi fossi messo in testa di andar per balene; a questa domanda l’invisibile poliziotto delle Parche, che costantemente mi sorveglia, e segretamente mi pedina, e in modo inesplicabile m’influenza, potrà rispondere meglio di qualunque altro. E, senza dubbio, il fatto che io intraprendessi il mio viaggio a balene faceva parte di quel grandioso programma della Provvidenza che fu tracciato tanto tempo fa».
Il realismo di Melville si carica della profezia che contiene moltitudini e l’influenza biblica non si afferma solo nella scelta nominale, nelle citazioni trasparenti, ma nella forma “impura” che avvicina mondi e specchia temi sparsi: «Dove infatti, se non nella Bibbia, una coinvolgente epopea popolare viene improvvisamente raffreddata da capitoli di precettistica, una scelta di battaglia bilanciata da un trattato architettonico, una storia passionale contrapposta a elenchi genealogici, un racconto delle origini seguito da istruzioni rituali che comprendono persino la macellazione animale? Da quando l’umanità ha cominciato a scrivere non è mai apparso un testo altrettanto “impuro”, ovvero altrettanto impastato nelle vicende quotidiane degli uomini» (Paolo Pegoraro).
«C’è in ogni uomo che si eleva al di sopra della mediocrità un qualcosa che, per lo più, si percepisce d’istinto […]», scrive Melville, «Io amo tutti gli uomini che si tuffano. Qualunque pesce sa nuotare vicino alla superficie, ma ci vuole una grossa balena per scendere a ottomila metri o più, e se questa non ce la fa a toccare il fondo, beh, tutto il piombo di Galena non basta a forgiare lo scandaglio in grado di farlo. Sto parlando dell’intero corpo dei “palombari del pensiero” che si sono immersi nel fondo per ritornare a galla con gli occhi iniettati di sangue da che è cominciato il mondo».
Il giovane newyorchese, annoiato dalla vita, proietta lo specchio di Melville e, nella sua risorsa vitale, è attratto, in una sorta di brivido mistico, dall’oceano misterioso e immenso: la sua acqua, purificatrice, simbolica, originaria, cosmica.
Due episodi segnano la sua partenza, da una parte l’incontro con Queequeg, giovane tatuato pagano idolatra, appartenente a una tribù di cannibali della Polinesia e il sermone di padre Mapple sul racconto biblico di Giona.
È questa doppia marcatura che segna, dilata, il pernottamento nella Locanda del Baleniere. Egli si affida a Dio e inizia a compiere una scoperta incredibile: «Quantunque egli fosse un selvaggio, e orribilmente sfregiato in faccia, pure, a gusto mio almeno, aveva nell’espressione qualcosa che non era per niente spiacevole. Non si può nascondere l’anima. Nonostante quei tatuaggi pazzeschi, mi pareva di scorgere le tracce di un cuore semplice e onesto; e negli occhi grandi e profondi, fieramente cupi e arditi, si leggeva un coraggio da sfidare mille diavoli. E oltre tutto questo, il portamento di quel pagano aveva in sé una certa dignità che neppure la sua rozzezza poteva del tutto avvilire».
Il ramponiere Queequeg desta la simpatia e l’ammirazione di Ismaele ed accende la sua prossimità, e la spiritualità che questo incontro afferma, in una vertigine di accoglienza e mistero. Entrambi si dirigono verso l’isola di Nantucket, l’ultimo avamposto di iniziazione, l’angolo naufrago e il frammento di croce. La visita di Ismaele alla cappella del baleniere, prima del viaggio, è un incendio di anima, dove «il Dio dei venti favorevoli o contrari viene per la prima volta invocato perché mandi brezze benigne. Sì, il mondo è una nave su cui si compie una traversata e non un viaggio di andata e ritorno; e il pulpito è la sua prora».
Trovano imbarco sulla baleniera Pequod, popolata di gente di ogni sorta, tra cui Starbuck, primo ufficiale, concreto uomo prudente e antitesi di Achab, descritto come una sorta di antico cavaliere, Stubb, uomo tranquillo e allegro e Flask, il tozzo uomo di bordo.
Capitano della nave è Achab, Vecchio Tuono, come il nome nel primo Libro dei Re: «Sembrava un uomo strappato al rogo quando il fuoco gli abbia già trascorso e devastato le membra senza distruggerle né portar via nemmeno un briciolo della loro compatta e annosa robustezza. Tutta la sua alta e vasta figura sembrava fatta di solido bronzo, e forgiata in uno stampo inalterabile, come il Perseo fuso dal Cellini».
Quell’uomo è marchiato nella sua cabina, eroso dall’odio per la Balena Bianca, con la sua mutilazione, figlia di un destino avverso e di un rimpianto. Vuole schiacciare quel mostro, vendicarsi, ucciderlo. La sua cicatrice è il volto infernale della balena, il gemito di una lotta primaria con gli elementi, la furia che gela l’esistenza: «Ciò che ho osato, l’ho voluto; e ciò che ho voluto, lo farò! Mi credono pazzo… Starbuck per esempio; ma io sono un ossesso, sono la pazzia impazzita! Quella pazzia furiosa che è calma solo per comprendere se stessa! La profezia diceva che sarei stato smembrato e io… sì! Io ho perduto questa gamba. Faccio la profezia, ora, di smembrare chi mi ha smembrato. Siamo, dunque, ora, profeta ed esecutore la stessa persona. Questo vuol dire essere più di quanto voi, grandi dèi, siate stati mai. Vi derido e vi urlo dietro. […] La strada del mio fermo proposito è percorsa da rotaie di ferro, per andar sulle quali è scanalata l’anima mia. Su precipizi senza fondo, attraverso il cuore rigato delle montagne, sotto i letti dei torrenti io mi precipito infallibile! Niente è d’ostacolo, niente piega questa strada di ferro».
Scrive Ferdinando Castelli: «Achab è il prototipo tragico che richiama alla memoria prometeo della letteratura classica e romantica; ricorda anche il Capaneo del XIV canto dell’Inferno dantesco: pur sotto il martirio del fuoco, sembra sfidare la potenza divina».
Se, come commenta Paolo Gulisano: «Achab presenta tutte le caratteristiche peculiari dell’eroe tragico; faustianamente egli trascende la propria condizione deciso a perseguire il suo scopo fino all’estremo, condannando se stesso e i suoi marinai all’annichilimento della ragione e della morte», la sua è una lotta di demoni, dove l’accanimento si specchia nel corpo straziato e nell’anima ferita e persino nell’incuria, dove il viaggio persegue la sua specola di tappa e il suo dramma.
Guidato da Achab, il Pequod si inoltrerà nella vastità dei mari, ad oriente, doppiando Capo di Buona Speranza, giungendo nell’Oceano Indiano percorrerà il mare di Giava, fino all’isola di Borneo e nelle Filippine e toccherà l’Oceano Pacifico: «Questo Pacifico misterioso e divino cinge tutta la massa del mondo: fa di tutte le coste una sua baia; sembra il cuore della terra pulsante di maree. Sollevati da quegli ondeggiamenti eterni, vi è giocoforza riconoscere il seducente iddio, e chinare il capo dinanzi a Pan».
Poco dopo la baleniera punta a sud e raggiunge l’Equatore. Qui Achab è convinto che si trovi la Balena Bianca, il mostro che lo ha reso «balordo e incavigliato» e che ha dato origine alla sua cerca, all’opposizione verso un tempo sconosciuto e reale che si accanisce.
Vuole possedere quella creatura che, come scrive Pavese, «assomma in sé la quintessenza misteriosa dell’orrore e del male dell’universo».
La tensione verso questa ombra sfuggente, calante e inseparabile, tocca l’imperscrutabilità di un odio: «Quella cosa imperscrutabile è l’oggetto primo del mio odio; la balena bianca può esserne l’agente, la balena bianca può esserne il mandante: io quest’odio lo sfogherò su di lei. Non parlarmi di empietà amico: colpirei il sole, se mi offendesse. Perché se il sole fosse capace di questo, io dovrei essere capace di quello; c’è sempre una certa lealtà nel giuoco, poiché la rivalità presiede a tutte le cose create. Ma nemmeno quel giuoco leale, amico mio, può farla da padrone con me. Chi c’è sopra di me? La verità non ha confine».
È nello scontro con qualcosa di misterioso e leviatanico, forse ubiquo e immortale, che ha origine la sua sfida senza tempo, in una vigilia di vita insonne.
Alla vigilia dell’ultimo combattimento, il capitano Achab sale in coperta e si affaccia sul mare, accanto a lui c’è Starbuck: «Oh, Starbuck, è un vento dolce, e un cielo dall’aspetto dolcissimo. In un giorno simile, di altrettanta dolcezza, ho colpito la mia prima balena: ramponiere a diciott’anni! Quaranta, quaranta, quaranta anni fa! Quarant’anni di caccia continua. Quarant’anni di privazioni e di pericoli e di tempeste! Quarant’anni sul mare spietato! Per quarant’anni Achab ha abbandonato la terra tranquilla, per quarant’anni ha combattuto sugli orrori dell’abisso! Proprio così Starbuck; di questi quarant’anni non ne ho passati a terra tre. Quando penso a questa vita che ho fatto, alla desolazione di solitudine che è stata, all’isolamento da città murata di un capitano, che non ammette che ben poche delle simpatie della verde campagna esterna… quando penso a tutto questo, sinora soltanto sospettato, non mai veduto così chiaro, e come per quarant’anni non ho mangiato che cibo secco salato, giusto emblema dell’asciutto nutrimento della mia anima! Mentre il più povero uomo di terra ha avuto frutta fresca quotidiana e ha spezzato il pane fresco del mondo, invece delle mie croste muffose… lontano, lontano oceani interi da quella mia moglie bambina che ho sposato dopo i cinquanta, mettendo la vela il giorno dopo al Capo Horn e non lasciando nel cuscino nuziale che un’ infossatura… Moglie? Moglie? Vedova piuttosto, col marito ancor vivo. Sì, quando ho sposato quella povera ragazza io l’ho resa vedova, Starbuck. E poi, la pazzia, il delirio,l il sangue in fiamme e la fronte bollente, con cui in migliaia di discese il vecchio Achab ha dato la caccia furiosa, schiumosa, alla preda, da demonio più che da uomo.. Mi sento stracco a morte, piegato ricurvo come fossi Adamo, barcollante dal tempo del Paradiso sotto il cumulo dei secoli. Stammi accanto, Starbuck; fammi guardare un occhio umano; è meglio che guardare nel mare o nel cielo; è meglio che guardare in Dio».
Paolo Gulisano afferma che «Il mito di Moby Dick ci parla anche del problema del dolore: il male oscuro che tormenta Achab, il dolore acuto del capitano Gardiner, che incrocia il Pequod, e che ha il proprio figlio disperso in mare, un dolore al quale il sofferente Achab rimane totalmente indifferente, troppo preso dal proprio inseguimento della Balena Bianca per perdere tempo ad aiutare chi ha bisogno. […] Achab è l’icon dell’uomo della modernità, deluso dall’arroganza dell’antropocentrismo da un lato e disilluso nei confronti di Dio».
Ecco l’uomo abbandonato alla fioca esilità della miseria e alla nostalgia esiliata, tremenda di luce e felicità, come un re ferito e mutilato che scrive la sua mappa afflitta. E allora Starbuck tenta di distoglierlo e lo invita a ritornare a Nantucket e ai suoi dolci colori azzurri: «Che cosa è mai, quella cosa senza nome, imperscrutabile e ultraterrena è mai; quale signore e padrone nascosto e ingannatore, quale tiranno spietato mi comanda, perché contro tutti gli affetti e i desideri umani, io debba continuare a sospingere, ad agitarmi, a menare gomitate senza posa, accingendomi temerario a ciò che nel mio cuore vero, naturale, non ho mai osato nemmeno di osare? È Achab, Achab? Sono io, Signore, che sollevo questo braccio, o chi è? Ma se il sole immenso non si muove da sé, e non è che un fattorino del cielo; se nemmeno una stella può ruotare se non per un potere invisibile, come può dunque questo piccolo cuore battere, e questo piccolo cervello pensare, se non è Dio che dà quel battito, che pensa quei pensieri, che vive quella vita,e non io?». Così Achab è di fonte al suo esodo di solitudine, davanti al mare e al dramma della sua libertà che sfida un dio minore, un diavolo bianco che fa vittime e corrode il destino.
Il dramma inizia ad avere compimento. La baleniera, dopo ripetuti contatti, si perde nell’abisso assieme a tutto l’equipaggio e Achab lancia il suo ultimo e spaventoso grido: «Io volterò la schiena al sole. […] mi è tolto anche l’ultimo caro orgoglio del più meschino capitano naufrago? Oh, una morte solitaria dopo una vita solitaria! Ora sento che la mia maggiore grandezza sta nel mio maggior dolore. Olà, olà!. Dai più lontani confini rovesciatevi ora quaggiù, flutti audaci di tutta la mia vita trascorsa, e ammucchiatevi in questo grande cavallone della mia morte! A te vengo, balena che tutto distruggi ma non vinci, fino all’ultimo lotto con te; dal cuore dell’inferno ti trafiggo; in nome dell’odio, vomito a te l’ultimo mio respiro».
Il suo ultimo arpione come il suo ultimo respiro trascinato. Si salva solo Ismaele, aggrappato alla bara che Queequeg aveva costruito per il suo corpo. Verrà raccolto da un veliero, la “Rachele” che raccoglie orfani e salva dal naufragio.
L’uomo di Melville è in bilico su un disastro. Incalzato, spintonato dai mari dell’essere e della vita, afflitto dalle sue lotte, piene di lampi, contro miserie, tradimenti e lacerazioni.
Scrive un libro malvagio e si sente immacolato come un agnello, come egli stesso afferma in una lettera del 1851, sosta nell’ombra per dipanare una luce fioca, confusa e predestinata, quasi di esclusione.
Nell’esclusione e nella ribellione, la carità suprema attracca nel suo porto celeste e immolato, un disegno che accetta, un’ombra che si muove.
Melville H., Moby Dick, Rizzoli BUR, Milano 2012.
Id., Opere scelte, Mondadori, Milano 1972-1975.
Id., Viaggi e balene. Scritti inediti, Clichy, Firenze 2013.
Amoruso V., Alla ricerca di Ismaele. La narrativa di Herman Melville, Graphis, Bari 2005.
Bacigalupo M. (a cura di), Rotte di lettura intorno a «Moby Dick», Marietti, Genova 1992.
Baird J., Ishmael, Harper, New York 1960.
Bianchi R.., Invito alla lettura di Melville, Mursia, Milano 1997.
Castelli F., Herman Melville: «Moby Dick», in «La Civiltà Cattolica», IV, 2012.
Gulisano P., Fino all’abisso. Il mito moderno di Moby Dick, àncora, Milano 2013.
Storia letteraria degli Stati Uniti, vol.2, il Saggiatore, Milano 1963.
Pavese C., La letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi 1951.
Pegoraro P., Moby Dick ovvero l’importanza della forma, «www.zenit.org», 5 aprile 2011.
Weaver R.M., Herman Melville: Mariner and Mystic, Doran, New York 1921.