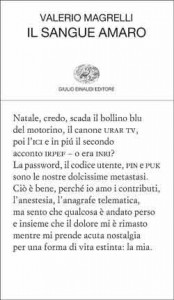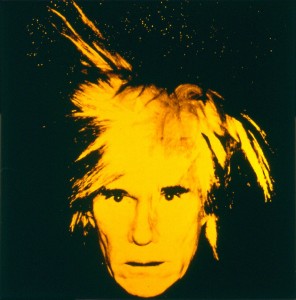di Andrea Galgano 4 giugno 2014*
Ex insegnante e bibliotecario, passato alla narrativa dopo tre raccolte di poesia e dopo aver ricevuto il Premio Islandese per la Letteratura, Jón Kalman Stefánsson conosce la terra e l’identità, il valore profondo e alto della parola, non solo suono e punto di fuga, ma nome di esperienza per chi la vive: «Bene è, senza dubbio, la parola più importante in islandese, in un attimo ha la capacità di creare un legame tra due persone sconosciute».
In Luce d’estate ed è subito notte[1] il ritratto di un villaggio islandese di quattrocento abitanti interseca la storia abitando le stelle, disigilla i precipizi, scorge il bagliore dalle labbra.
C’è la Cooperativa, il Deposito, la Latteria, i Macelli, il benzinaio nel chiosco, una realtà in dissolvenza e carnale della comunità che si spia e crea tessuto: «L’essere umano non si mantiene bene come il titanio, e la sua storia potrebbe essere riassunta così: quello che ha nel cuore, quello che ha nelle ossa, nel sangue, e poi il movimento di una mano una sera d’ottobre».
Il firmamento che colora gli astri e inanella la terra, sfocia nel cuore che chiede la vita prodiga di luce e tenta di fermarla nella sua luce tenera e dura, per comprenderla:
Nelle storie antiche si dice che l’uomo non possa guardare Dio, equivarrebbe alla morte, e senza dubbio vale lo stesso per quello che cerchiamo — la ricerca che ci insegna le parole per descrivere lo splendore delle stelle, il silenzio dei pesci, il sorriso e lo sconforto, la fine del mondo e la luce d’estate. Abbiamo un compito, a parte baciare labbra; sai per caso come si dice “ti desidero” in latino? E come si dice in islandese?.
Il territorio prediletto di Stefánsson è la polifonia siderale, l’attimo in cui il singolo appartiene a un movimento più grande, laddove il presente si unisce e si forma sul passato, come la bellezza e la sventura che disarcionano.
È la passione per l’umano a solcare la scena: dai capelli rossi di Solrún che si immerge nella baia, dove è «tutto un altro mondo, è come andare al fondo dei propri sogni», e lascia sospiri agli uomini, al velluto nudo di Elisabet che sbriciola il tempo o la coltre di Kristín, fino al direttore del Maglificio, che dopo aver sognato in un imprecisato latino («Tu igitur nihil vidis?»), abbandona il suo mestiere per studiare le stelle, grazie all’attrazione per Galileo e al Somnium di Keplero, in cui si narra la spedizione verso la luna dalle rive islandesi.
Il teatro umano dei fiordi sporge il suo indaco, ritrova fantasmi che non hanno pace dove la vita, in quel momento, consuma il suo spazio, come scrive Silvia Cosimini:
E così conosciamo la vita, le passioni, le bassezze, l’amore, la quotidianità delle persone del paese, scopriamo i loro pensieri e i loro desideri, le speranze, le aspettative, la paura, l’amore, il sesso, la rabbia, l’indignazione […] è un mondo minimalista, partecipe e sentito, per accorgersi una volta di più che tutti abbiamo lo stesso cuore, che siamo tutti ugualmente nudi e impreparati di fronte all’amore, al dolore, alla morte.
La stessa vita che tocca la morte, come una brezza sulle sponde, diviene la pienezza di un segno nascosto che traluce «mentre fuori il tempo turbina», che non disdegna l’ironia, che prolunga le sue linee, salvate dall’oblio, grazie alla lingua e all’esperienza della letteratura.
Insegue, così, la «voluttà che tiene insieme i giorni e le notti» e trae «la propria forza dalle profondità dell’universo, dai giorni che vanno e vengono, dal canto degli uccelli e dall’attimo estremo», per finire «sull’aia di una campagna del nord», dove si legano felicità, solitudine, dignità, incoerenza e sogni, rivolti al cielo.
L’Islanda è terra selvaggia e spopolata («briciolo di terra sotto il cielo che si spalanca infinito»), altura lunare e lavica, come un paesaggio proteso al silenzio delle maree, all’epica del sogno, alla a–temporalità del paradiso.
Marta Morazzoni, in un articolo su “Il sole24 ore” del 18 maggio 2014 scrive:
«Nell’isola dei ghiacci e delle saghe, protagonista è l’uomo, frantumato in mille sfaccettature e caratteri, osservato da tanti angoli visuale, e simboleggiato nella figura centrale del ragazzo che non ha un nome, quasi fosse una sorta di Jederman che attraversa la vita […] La sua elegiaca, virgiliana meditazione sulla morte nasce dallo stupore; quel subitaneo passare dall’essere al non essere più lo convince di avere solo un compito ancora nella vita, mettersi in cammino per restituire il poema di Milton al capitano che l’aveva prestato a Barthur e quindi morire a sua volta, per raggiungere l’amico nella nebbia del mondo dei non vivi, in cui gli sembra di sentirlo soffrire di una fredda solitudine».
La tristezza degli angeli[2] fonde il suo orizzonte di terra lieve, il crepaccio del cielo che si impone.
Il ragazzo che accompagna il grosso e taciturno postino Jens, cerca il sentiero della sua esistenza, beve alla sorgente dei libri e cerca le parole che dispiegano il tempo, perché «sono una delle poche cose di cui disponiamo davvero, quando tutto sembra prendersi gioco di noi».
Il viaggio degli uomini scava la loro immagine, tentano transiti e passaggi verso la scoperta di sé e verso la stoffa del proprio essere, in una carta di stupore e dignità.
Sono nevi eterne come un deserto bianco, battiti e inquietudini estreme di donne che scandiscono la voce della loro vita, conoscono le promesse e «sanno destare il fuoco dal sonno e lo fanno ogni mattina da molte centinaia di anni».
In questa estremità il fiato tra i denti si sporge sull’urlo del mare, dove le cadute e i rialzi, in mano al vento, tolgono il respiro ma non la vita che richiama, la parola che incendia e sta dietro al mondo, con una delicatezza feroce, come camminare su una chiesa di neve:
Adesso sarebbe bello dormire finché i sogni non diventano cielo, un cielo sereno e senza vento, qualche piuma d’angelo che scende volteggiando a terra, per il resto nient’altro che la beatitudine di chi vive ignorando se stesso. Ma il sonno fugge i defunti. Quando chiudiamo i nostri occhi fissi, sono i ricordi ad aggredirci, non il sonno. Prima arrivano isolati, e perfino piacevoli e argentei, poi però non tardano a mutarsi in una nevicata scura e soffocante, e così è da oltre settant’anni. Il tempo passa, la gente muore, il corpo sprofonda nella terra e altro non sappiamo. Del resto qui c’è poco cielo, le montagne ce lo rubano, e le tempeste, amplificate da quelle stesse cime, sono nere come la fine del mondo. Ma a volte quando il cielo si schiarisce dopo una tormenta, ci sembra di vedere la bianca scia degli angeli, lontano, al di sopra delle nubi e dei monti, sopra gli errori e i baci degli uomini, una scia bianca come la promessa di un’immensa beatitudine. La promessa ci riempie di una gioia infantile e risveglia un ottimismo datempo sopito, ma acuisce anche lo sconforto e la disperazione. È così, una luce intensa genera anche ombre profonde, una grande gioia cela in sé, da qualche parte, una grande malinconia, e la felicità umana sembra destinata a tenersi sul filo di una lama. La vita è piuttosto semplice ma l’uomo non lo è, quelli che definiamo gli enigmi dell’esistenza non sono che le nostre complicazioni e le nostre selve oscure. […] Abbiamo percorso una lunga strada, più lunga di chiunque altro, i nostri occhi sono come gocce di pioggia, pieni di cielo, di aria tersa e di nulla. […] Da qualche parte nel profondo delle regioni dello spirito, di questa coscienza che rende l’umanità sublime e maledetta, si nasconde comunque una luce che tremola e rifiuta di estinguersi, rifiuta di cedere il passo al peso delle tenebre e alla morte che soffoca. Quella luce ci nutre e ci tortura, ci costringe ad andare avanti […] I nostri movimenti sono senza dubbio incerti, esitanti, ma il loro fine è chiaro — salvare il mondo. Salvare te e noi stessi con queste storie, questi brandelli di versi e di sogni che da tempo sono precipitati nell’oblio. Siamo a bordo di una barca che fa acqua, e con le reti marce vogliamo pescare le stelle.
Paradiso e inferno[3], pubblicato da Iperborea nella traduzione di Silvia Cosimini, è un libro maestoso, ambientato in un imprecisato periodo del tardo Ottocento «negli anni in cui di sicuro eravamo in vita».
Nella prima parte si narra la vicenda di Bárthur, giovane pescatore innamorato di Sigridur e lettore appassionato, a tal punto da rimanere avvinto dal Paradiso perduto di Milton, nella versione islandese del reverendo Thorlàksson e dimenticarsi la cerata prima di uscire in mare. Morirà assiderato.
Suo amico è un ragazzo senza nome e orfano. Assieme cercano di guadagnarsi da vivere con la pesca del merluzzo, viaggiano nella freschezza profonda dell’essere, per toccare l’avamposto del paradiso e «scoprire se c’è un’essenza».
Nella seconda parte, il ragazzo è in viaggio verso il fiordo di Plássio –«il nostro inizio e la nostra fine, il centro del mondo»– dove vive Kolbeinn, il capitano cieco di una sorta di trinità che governa la locanda del villaggio, con i numi femminili, Helga e Gerithruour, che custodisce una biblioteca di quattrocento libri dalla quale proviene il volume di Milton.
Ma in questo piccolo villaggio vi sono regole incomprensibili, un linguaggio strano per cui la parola sembra contraddirsi, fino all’apparizione, quasi amletica, dell’amico al ragazzo che afferma un dolore racchiuso, che nessuna parola vera riesce a sbrogliare.
Un poema sull’amore e sull’origine della totalità dell’essere: il destino e il compimento dell’esistenza. La forza della letteratura non risiede nello straniamento, ma nell’accensione di un tumulto acceso sull’esistenza, sul risveglio della luce che lucida la realtà che si rivela e in essa pronuncia il destarsi del desiderio, l’appartenenza, la parola.
È nel nome di un’esperienza che il bagliore numinoso dell’essere uomini si fa luce di taglio: «Or scende la sera / a deporre il manto / greve d’ombre / su ciascuna cosa, / la scorta il silenzio».
Afferma Marta Morazzoni:
«Su una tonalità in particolare si estende, mi sembra, la voce di Stefànsson, sulla compassione che coinvolge uomini e animali, e lo strumento privilegiato, cui dedica parte della sua cura è appunto quell’elegia in cui si rifugia anche nel pieno dell’epos prosastico, a volte con indulgenza sentimentale. Così l’Islanda feroce della sua narrazione è ingentilita, custodita dalla vena di una malinconica fiducia».
La ragione ultima di buio e luce, sugli squarci d’inverno, diviene un’attesa di compimento. «Nulla mi delizia tranne te». La promessa della realtà, raccolta in un mare infinito di chiarore e ghiaccio di terra, sembra non mantenersi quando un amico muore, quando il tempo è inerte e l’inferno si impadronisce del vuoto. Quel paradiso perduto racconta la luce degli occhi chiusi.
Il lessico dell’anima è assoluto e stringe, per raccontare e calmare, il buio dell’universo: «Ci sono parole che hanno il potere di cambiare il mondo capaci di consolarci e di asciugare le nostre lacrime. Parole che sono palle di fucile, come altre sono note di violino. Ci sono parole che possono sciogliere il ghiaccio che stringe il cuore, e poi si possono anche inviare in aiuto come squadre di soccorso quando i giorni sono avversi e noi forse non siamo né vivi né morti», e ancora:
Le parole possono avere il potere dei troll e possono abbattere gli dei, possono salvare la vita e annientarla. Le Parole sono frecce, proiettili, uccelli leggendari all’inseguimento degli dei, le parole sono pesci preistorici che scoprono un segreto terrificante nel profondo degli abissi, sono reti sufficientemente grandi per catturare il mondo e abbracciare i cieli, ma a volte le parole non sono niente, sono stracci usati dove il freddo penetra, sono fortezze in disuso che la morte e la sventura varcano con facilità.
Scrive Emanuele Trevi: «La geografia di Stefánsson è sobria e autorevole come una carta geografica, una mappa disegnata su una pergamena: un mare infido e gelido, sterminate pianure innevate, catene inviolabili di antichi vulcani che sovrastano i fiordi e forniscono alle barche in cerca di merluzzo gli unici punti di riferimento, come un’immensa bussola di pietra e lava».
Nel sublime di Stefánsson, la vita si arresta sull’uscio di un ventaglio identico di spazio e tempo e, attraverso la polifonia della voce, conosce la migrazione della metafisica e l’epica dell’esistere.
Il ragazzo e l’eroe della storia sono la coltre di un movimento luminoso e oscuro, assaporano entrambi le sponde dell’essere, le linee di confine delle nostre tenebre e della nostra lucentezza di stelle.
Dopo la morte dell’amico, il ragazzo voleva uccidersi, ma una volta che il libro viene riconsegnato, due donne nordiche compiono definitivamente la sua quest, impedendogli di commettere il gesto estremo, tranne quello di una iniziazione al mistero profondo dell’esistenza, alle sue viscere, al suo bisogno di domanda. Il sublime, pertanto, diviene l’avamposto di una umanità in lotta, la rotta d’Eterno che tocca la vertigine del mare e delle stagioni, per domandare salvezza e resurrezione, dinanzi alla caduta e al proscenio della morte: «La gioia, la felicità, l’amore appassionato sono la triade che fa di noi degli uomini, che giustifica l’esistenza e la rende più grande della morte, eppure non offre riparo contro il vento del polo. Il mio amore per una cerata, la mia felicità e la mia gioia per un altro maglione. […] La felicità è poter mangiare qualcosa, averla scampata nella tempesta, aver scavalcato gli imponenti marosi che mugghiano sulla costa…».
La solitudine arcaica de Il cuore dell’uomo[4] (2014) è destinata a una finalità amorosa: « L’uomo è nato per amare, ecco quant’è semplice il fondamento dell’esistenza. Per questo il cuore batte, questa strana bussola, grazie a lui ci orientiamo tra le nebbie più fitte, a causa sua ci smarriamo e moriamo in pieno sole».
Il risveglio del ragazzo nella sperdutezza di un fiordo affronta la perdita e la ferita del suo amico, la veglia sulle soglie della morte, il destino della sopravvivenza.
Ma è ancora l’amore concreto di Álfheiður a toccarlo, nel suo concreto stupore, a destare la sua «ferita aperta nell’esistenza», come sottile estate, come opzione dinanzi alla morte e al nulla: «Hai deciso se vuoi vivere o morire? gli chiede la donna. […] Non lo so, risponde, non sono sicuro di sapere la differenza, e non sono nemmeno sicuro che ci sia, una differenza».
C’è il cuore che insegue il suo desiderio immenso che inizia alla vita e declina il suo amore in tutta la sua sostanza (Ragnheiður, Rakel).
A tal proposito, scrive, infatti, Luigi Giussani:
«Tutte le esperienze della mia umanità e della mia personalità passano al vaglio di una «esperienza originale», primordiale, che costituisce il volto nel mio raffronto con tutto. In che cosa consiste questa esperienza originale, elementare? Si tratta di un complesso di esigenze e di evidenze con cui l’uomo è proiettato dentro il confronto con tutto ciò che esiste. […] A esse potrebbero essere dati molti nomi; esse possono essere riassunte con diverse espressioni (come: esigenza di felicità, esigenza di verità, esigenza di giustizia, ecc…). Sono comunque come una scintilla che mette in azione il motore umano; prima di esse non si dà alcun movimento, alcuna umana dinamica. Qualunque affermazione della persona, dalla più banale e quotidiana alla più ponderata e carica di conseguenze, può avvenire solo in base a questo nucleo di evidenze ed esigenze originali”»[5].
In un articolo su “La Repubblica” del 4 maggio 2014, Andrea Bajani commenta:
«È in mezzo a questa solitudine — che in pochi oggi sanno raccontare con la stessa malinconica tensione di Stefánsson — che l’uomo non può fare altro che cercare delle parole. Per questo il ragazzo aspetta le lettere, per questo ne scrive. Sa che non contano niente, nel salvare la vita ad un uomo, ma sa anche che sono l’unica fune che un uomo può lanciare a un altro uomo nella tempesta. Sa che le parole sono la sua condanna, perché sono proprio loro a fargli credere per un attimo che quel niente si possa domare: «Sono state le parole a recidere le radici tra l’uomo e la natura». Ma sa anche che è tutto quello che può fare. Le parole passano da un essere umano a un altro come un sollievo e un’intesa, due luci accese dentro una stessa notte infinita. «Perché la sensibilità è il nocciolo dell’essere umano», e le parole sono le uniche corde su cui può tentare di cercare una qualche armonia: «Presto qualcuno verrà a girare il carillon e forse sentiremo le fievoli note dell’eternità».
La morte rivela la sostanza dell’ampio gesto della vita. C’è un immenso respiro in queste pagine, come il mare che, pur toccando i sipari duri del tempo, offre una dilatazione di senso alla minuzia che si fa domanda, al Paradiso che è tale perché il transito nell’inferno colpisce la natura dell’essere uomini in attesa e bisognosi di qualcosa che salvi e faccia vivere e dove il rapporto con l’infinito è la comune patria degli uomini, che confronta e apre alla vita «per vivere come le stelle»: «Il ragazzo indietreggia involontariamente dalla finestra, la chiude, la stanza si è raffreddata in fretta, più che altro avrebbe voglia di infilarsi di nuovo a letto, coprirsi la testa con la trapunta per il resto della vita, perché che cosa gli riserva il futuro a parte respirare, mangiare, andare regolarmente in bagno, leggere libri, rispondere a chi gli rivolge la parola? Per cosa si vive?».
leggi in word IL PARADISO E L’INFERNO DI STEFANSSON
[1] Id., Luce d’estate ed è subito notte, Iperborea, Milano 2013.
[2] Id., La tristezza degli angeli, Iperborea, Milano 2012.
[3] J.K. Stefánsson, Paradiso e inferno, Iperborea, Milano 2012.
[4]Id., La tristezza degli angeli, Iperborea, Milano 2014.
[5]Cfr. L.GIUSSANI, Il senso religioso, Rizzoli, Milano 1997.