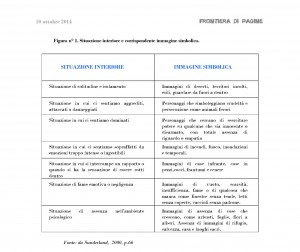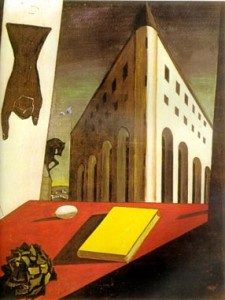di Andrea Galgano 7 luglio 2014
*intervento alla Prima Conferenza Internazionale di Psicologia Dinamica, Cenacolo di sant’Apollonia, Firenze, 27-28 ottobre 2012
leggi in word La rilevanza della letteratura nella formazione dello psicologo
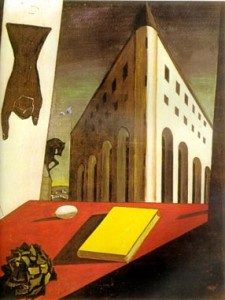
Un buon libro lascia al lettore l’impressione di leggere qualcosa della propria esperienza personale. Quando la letteratura è al suo apice ci sembra che d’improvviso ricordiamo qualcosa d’importante che sapevamo ma abbiamo scordato.
O.Lagercrantz, da L’arte di leggere e scrivere
In un breve scritto dal titolo Poesia, filosofia, psicoanalisi Umberto Saba afferma che una persona «guarita dalla psicoanalisi non scriverebbe più poesie, neanche qualora avesse sortito dalla nascita il felice ingegno di Dante»[1]. Secondo Saba, e Rilke più tardi, l’attenuazione del narcisismo, la cancellazione dei demoni, perseguita dalla psicoanalisi, attenuerebbe anche la fecondità e la fertilità poetica.
Ma se ogni poesia, come direbbe Wittgenstein, può assurgere a gioco linguistico e una moltiplicazione delle regole del linguaggio, ecco che determina un «arrest of disorder», ossia una sospensione del disordine, come si rinviene nelle affermazioni del grande poeta americano Robert Frost, in un’intervista con John Ciardi (1959). Altrove, in un altro passaggio, Frost si rivolge al legame che nasce tra autore-poeta e poesia, che prende forma durante il processo figurativo:
Se è una melodia selvatica, allora è poesia. Il nostro problema quindi, come moderni astrattisti, è di raggiungere la selvaticità pura; essere selvaggi con nulla, essere selvaggi verso qualcosa. Ci solleviamo come aberrazionisti, cedendo ad associazioni indirette e facendoci scalciare in ogni direzione dalla possibilità di un’associazione all’altra, come una cavalletta in un caldo pomeriggio. È solo il tema che può mantenerci fermi. Così come il primo dei misteri è il modo in cui una poesia può avere una melodia dentro la piattezza della metrica, così il secondo è come una poesia può essere selvatica e, al tempo stesso, avere un soggetto da soddisfare. Sarà il piacere che ci dà una poesia a dirci come questo sia possibile. La figura che una poesia crea.
E ancora:
Comincia in gioia, si inclina verso l’impulso, con il primo verso assume direzione, percorre un tragitto di eventi fortunati e finisce in una chiarificazione della vita – non necessariamente una grande chiarificazione, come se ne trovano nelle sette e nei culti, ma in un momentaneo riparo dalla confusione. […] È solo una poesia truccata, una poesia che non è tale, se la parte migliore è stata pensata prima e serbata per la fine. (Frost, 1939, p. 440)[2].
È l’indizio di una sospensione del disordine, non un’illuminazione che tutto chiarifica e che tutto rende ampio. I neuroscienziati e gli psicologi cognitivi che studiano le relazioni tra cervello e linguaggio, considerano la poesia uno degli eventi del cervello, che, per così dire, costruisce la realtà in cui viviamo. Hans Magnus Ezensberger, in Omaggio a Gödel, , scrive:
«Teorema di Münchhausen, cavallo, palude codino/ è una delizia, ma non dimenticare: / Münchhausen era un bugiardo. / Il teorema di Gödel a prima vista appare / poco appariscente, ma rifletti: Gödel ha ragione. / «In ogni sistema sufficientemente complesso si possono formulare frasi / che all’interno del sistema / non sono né dimostrabili né confutabili, / a meno che il sistema/ non sia di per sé inconsistente». / Puoi descrivere la tua lingua/ nella tua propria lingua: ma non del tutto./ Puoi analizzare il tuo cervello/ col tuo stesso cervello: ma non del tutto. Ecc. / Per giustificarsi / ogni sistema pensabile / deve trascendersi, / ossia distruggersi. / «Sufficientemente complesso» o no: / la libertà di contraddire / è un fenomeno di carenza / o una contraddizione. (Certezza = inconsistenza). / Ogni pensabile uomo a cavallo, / quindi anche Münchhausen, / quindi anche tu, è un sub sistema / di una palude piuttosto ricca di sostanze. / E un sottosistema di questo sottosistema / è il proprio codino, / questa specie di leva / per riformisti e bugiardi. / In ogni sistema piuttosto ricco di sostanze / quindi anche in questa palude, / si possono formulare frasi / che all’interno del sistema / non sono né dimostrabili né confutabili. / Prendile in mano, queste frasi, / e tira!»[3].
Nella loro attività la poesia e la letteratura condividono la funzione terapeutica del linguaggio, la sua forza, il suo orientamento, la sospensione del disordine, appunto, per cui, come scriverà Paul Celan, nel suo «cristallo di respiro», luogo cercato, forma racchiusa di una testimonianza mai rinnegata e irrefutabile: «In fondo / al crepaccio dei tempi, / presso il favo di ghiaccio/ attende, cristallo di respiro, / la tua irrefutabile / testimonianza»[4].
La poesia nasce in un segno fragile e solenne e nella perfezione del cristallo dà forma al silenzio, toglie fiato e parola, ma, allo stesso tempo, offre il suo itinerario umano, la sua tensione. Avere un ritmo nella lingua, che ostinatamente, si muove alla ricerca del punto fermo del mondo, sollecita maggiormente l’interesse e l’impulso del clinico, per il contatto con i sogni, la memoria, i ricordi e la conoscenza, in quel che James Hillman chiamava la «base poetica della mente»[5].
Nello spettacolo del reale, per accedere al simbolico, il poeta deve saper trasformare, separando con la sua attitudine povera e ricca allo stesso tempo, il reale dal fantastico. È nel preconscio che avviene questo lavoro di commutazione.
La parola diviene la traccia di un’apertura, che attraverso la scrittura, transita nel confine tra dicibile e non detto, rivelazione e ignoto. Perché il poeta, con le sue ossa spezzate in segreto, prima di rivelarsi in pubblico (Baudelaire), è, per usare le parole di Josif Brodskij «qualcuno per cui ogni parola non è la fine ma l’inizio di un pensiero».
Per indagare il mondo e i suoi oggetti, e salvare il «volto comune di ciascuno individuo», egli usa il linguaggio, le sue vaste campiture e le sue potenzialità. La parola rappresenta uno degli spazi di salvezza del bene della individualità e della personalità.
Nel frammento noto come Il primo programma sistematico dell’Idealismo tedesco, del 1795-96, Hölderlin, Hegel e Schelling attribuiscono alla poesia la missione di preparare il regno della libertà, con i suoi dispiegamenti individuali, i destini che trasformano e incarnano la loro precipua singolarità, i loro demoni. Parlano di religione del sensibile, caratterizzata da ciò che Giorgio Antonelli chiama «monoteismo della ragione e del cuore e politeismo dell’immaginazione dell’arte».[6]
Il farsi della poesia e dell’analisi conduce l’epifania degli dei a manifestarsi, a rivelare la loro intima natura, in ciò che Coleridge chiama co-adunaton, come l’immaginazione che si presentifica, offrendo la sua sponda silente. La teo-epifania di Rilke, Yeats, Pound è esibizione materica di una lunga e inevitabile arsi interiore.
Scrive Angelo Maria Ripellino nella sua nota a Sulla Poesia di Osip Mandel’ŝtam
Come il Pasternak del Salvacondotto, anche Mandel’ŝtam punta tutto sulla metafora, accostando in misture inattese opposti campi semantici, rendendo tangibili con virtuosistici intarsi di abbaglianti similitudini e suoni, gli odori, le «meraviglie» dei versi altrui, dei paesaggi, di eventi lontani e dell’ambiente giudaico della sua infanzia. Per cogliere l’identità delle cose distanti, egli tende la vista «come un guanto di pelle di daino» (e riesce così a percepire e ad immettere nella densissima sigla d’una metafora tutto quello che sta fuori campo, attorno al punto focale, il contiguo), quasi il suo sguardo, asimmetrico come gli occhi di certi pesci, potesse simultaneamente imbricare differenti assi ottici.[7]
Gli fa eco il grande poeta francese Yves Bonnefoy, citato da Armando Massarenti, in un interessante articolo de “Il sole24 ore” del 16 luglio 2011:
A ogni istante due vie s’aprono nel cuore della parola; e la poesia si decide a questo bivio: essa deve lasciare la grande biblioteca, andare sino allo sprone che s’inoltra tra cielo e terra, e continuare ancora, più lontano, declinando verso appuntamenti dello sguardo ove s’accoglie ancora il calore appena mitigato della notte d’estate.[8]
L’intensità della parola poetica costruisce i circuiti neuronali più solidi, sostanziali e profondi, e ci parla del carattere sempiterno dell’espressione poetica, che, nella sua concretezza e ricchezza, come testimoniato anche da un recente saggio in tedesco del neuropsicologo Arthur Jacobs e del poeta Raoul Schrott[9], può offrire un valido strumento di analisi e indagine nelle strutture interne del paziente. La lettura di sostantivi, verbi e aggettivi (guerra, nazismo, torturare, distruggere, morto) e positivi (amore, libertà, ridere, baciare, grandioso) provocano la modificazione opposta delle pupille, della frequenza del polso e del colorito della pelle, mentre parole ad alto tasso emotivo possono rallentare la lettura.
Leggere e ascoltare permette di trasmettere ai centri cerebrali, segnali visivi e acustici che arrivano alla coscienza con un significato, un ritmo, un senso, un’immagine. Una poesia può esprimere l’intensità di ciò che altrimenti sarebbe impossibile dire, un romanzo o una novella e persino un racconto (si pensi allo sguardo sulla nevrosi americana di John Cheever) possono entrare nel magma vitale più di qualunque testimonianza. L’intensità dei centri dell’affettività sollecitati ne è fervida conferma. Scrive il poeta americano Mark Strand in un suo elzeviro:
È una cosa curiosa: la vita che conduciamo ci consente solo di rado di fermarci a riflettere su ciò che abita nel nostro corpo e, di conseguenza, possiamo diventare così estraniati da noi stessi da aver poi bisogno della poesia per ricordarci che cosa si prova a esser vivi. La nostra abitudine a pensarci in relazione agli altri e a giudicarci in base a come agiamo in un contesto sociale ci rende più vicini allo spirito della narrativa: il comportamento esteriore è più facile da osservare, può essere percepito immediatamente, ed è quindi più semplice giudicarlo. (…) Una poesia, tuttavia, avrà necessariamente un’esistenza nel tempo, se non altro per il modo in cui si relaziona alle opere precedenti, assieme alle quali viene a formare un lungo specchio ininterrotto che, nel fluire dei secoli, ritrae la soggettività umana. È curioso notare come i sentimenti, pur accompagnandoci sempre, siano così difficili da cogliere da sembrare qualcosa di effimero. In genere vi prestiamo attenzione quando si fanno avanti con impellenza, nei momenti critici, quando è più forte l’esperienza della perdita: durante una separazione, per esempio, o in seguito alla morte di una persona cara. È allora che ci rivolgiamo alla poesia perché ci dica quali sono i nostri sentimenti, per mettere in parole ciò che supera la nostra capacità di articolazione. Inoltre, la poesia ha la capacità di conservare il senso di urgenza di tali momenti, permettendoci di riviverli più e più volte: anche quando una poesia è incentrata sulla perdita, il suo scopo è quello di conservare, di trattenere. Vogliamo serbare ciò che sentiamo nel profondo ma in un modo tale da trasformarlo in piacere.[10]
La letteratura, esperienza di lingua accesa, spesso ai margini della formazione e della professione psicologica, crea uno spazio di incontro in cui le individualità si sentono e in cui si sperimentano le gradazioni affettive dell’uomo, esplorate precipuamente da Dostoevskij ad esempio, nelle cui opere emerge il mistero insondabile dell’uomo, il suo essere una creatura in perenne confine tra bene e male, paradiso e inferno.[11]
Ne Il Sosia egli, ad esempio, descrive l’inizio di una psicosi, il senso di una alienazione, mai altrimenti visibile, afferrato da un nuovo sistema sconosciuto e ignoto.
Dostoevskijj parla dell’uomo all’uomo, affascina e reca timore e tremore, poichè raggiunge, anche nel buio e nelle tenebre, la positività ultima del reale, il suo disegno umano e divino e la sua grazia potente.[12]
L’esperienza poetica consente il ristabilimento di un rapporto con la realtà. Tale attività risulta, pertanto, decisiva, come scrive T.S.Eliot, a portare in superficie le reazioni della nostra personalità dinanzi al visibile e toccabile, verso un’alterità, misteriosa e infinita, che esprime il punto di fuga della nostra esperienza avventurosa.
L’esperienza della poesia si dà innanzitutto come incontro. Qualcosa di nuovo, di sconosciuto e forse di insolito entra a contatto con la nostra vita. Anzi qualcuno, una persona nel momento in cui esprime una sua urgenza. Può tratatrsi di qualcuno che non conosco affatto, o solo per nome (come certi autori ‘famosi’), o di cui ho già letto qualcosa. Potrebbe essere addirittura un vecchio amico, che, però, fermandomi in quel modo lungo il corso, di fatto chiede di essere reincontrato di nuovo. Ogni incontro, ogni testo letto per la prima o la millesima volta è, di fatto, un avvenimento nuovo nell’ambito di ciò che ha costituito fino a quel momento il retroterra e l’orizzonte della mia conoscenza e della mia esperienza.[13]
L’esperienza della poesia è legata allo stupore di fronte alla presenza dell’esistenza, uno stupore che si attesta sul riconoscimento di qualcosa d’altro che, per così dire, compie il reale, fino al suo punto infinitesimo che è l’io. Leopardi in un appunto dello Zibaldone dell’agosto 1823, descrive la coscienza di un’attitudine poetica autentica
Niuna cosa maggiormente dimostra la grandezza e la potenza dell’umano intelletto, né l’altezza e nobiltà dell’uomo, che il poter l’uomo conoscere e interamente comprendere e fortemente sentire la sua piccolezza. Quando egli considerando la pluralità de’ mondi, si sente essere infinitesima parte di un globo ch’é minima parte d’uno degli infiniti sistemi che compongono il mondo, e in questa considerazione stupisce della sua piccolezza, e profondamente sentendola e intentamente riguardandola, si confonde quasi col nulla, e perde quasi se stesso nel pensiero della immensità delle cose, e si trova come smarrito nella vastità incomprensibile dell’esistenza; allora con questo atto e con questo pensiero egli dà la maggior prova possibile della sua nobiltà, della forza e della immensa capacità della sua mente, la quale rinchiusa in sí piccolo e menomo essere, è potuta pervenire a conoscere[14]
Ecco il movimento della poesia, come segno di non contraddizione, come gesto ineliminabile dell’uomo, nel riconoscersi «quasi nulla» prediletto dall’essere, che gli ha dato la possibilità di abbracciare tutto con stupore vero.
Il suo avvenimento aiuta a giudicare in modo più umano la vita, riconoscendo l’adeguatezza del suo rilievo. L’incontro con questa materia viva permette una com-prensione, salva la possibilità di un’esperienza adeguata del mondo, introduce a un altro avvenimento e permette, infine, il giudizio che la realtà esprime su di sé.
A poco più di vent’anni nel 1938, Mario Luzi e poco prima T.S.Eliot, notavano come il presupposto della poesia moderna fosse una sorta di disincanto deluso verso l’esperienza del visibile. Far emergere in superficie le reazioni della nostra personalità dinanzi a ciò che è visibile e toccabile è il suo dono, il suo crinale più vero.
Lo scopo della poesia e della letteratura, in senso lato, è esprimere la realtà della vita e suggerirne la conoscenza in modo non pregiudicato. Una tensione che spinge a trovare il legame di forme e parole più adeguate alla realtà che si intende comunicare, per mettere a fuoco il mistero della verità che ci tocca e ci rende vivi, suscitando, da un lato una risonanza personale, dall’altro una rievocazione intertestuale. La memoria viene sollecitata, come una sorta di esperienza primordiale, come scrive J.S. Bruner, secondo il quale i generi letterari «sono espressioni convenzionali di rappresentare le vicende umane, ma sono anche modi di raccontare che ci predispongono a usare la nostra mente e la nostra sensibilità in un senso particolare»[15]
L’intuizione di Vygotskij (1930 circa – 1978) sulla natura culturale e sociale delle «funzioni psicologiche superiori» e del carattere “mediatore” di strumenti e segni, per cui le funzioni cognitive “superiori” tendono a svilupparsi attraverso attività compiute come il linguaggio, la scrittura, ad esempio, divengono strumenti cognitivi che forniscono un meccanismo formale, per padroneggiare i processi psicologici, ha trovato eco nelle rielaborazioni di Bruner (1965) sugli strumenti intesi come “amplificatori culturali” o al modello dell’intelligenza adattiva di Olson (1976), fino a Michael Cole.
Cole (1994, 1995, 1996), riprende la configurazione triangolare tra individuo e ambiente di Vygotskij, per applicarla al processo di lettura, ridefinendone la relazione fra mente e cultura e il carattere intersoggettivo e contestuale della cognizione, poiché
«gli esseri umani si distinguano dalle altre creature per il fatto che essi vivono in un ambiente trasformato dai prodotti (artefacts) delle generazioni precedenti, sin dagli inizi della specie […], la cui funzione fondamentale è quella di coordinare gli esseri umani con l’ambiente e fra di loro».[16]
In uno studio del 1994 di R.W.Gibbs[17] è emerso che la mente umana è modellata non solo da processi poetici o figurati, ma le stesse figure retoriche, scheletro di ogni componimento, costituiscono gli schemi attraverso cui gli uomini concettualizzano la loro esperienza quotidiana e “il mondo esterno”. L’amore, ad esempio, come scrive in un interessantissimo articolo Laura Messina[18]
sembra che nella cultura occidentale sia concettualizzato attraverso un limitato numero di metafore, tra cui, più frequenti, “amore è una forza naturale”, “amore è un’unità”, “amore è una risorsa preziosa”, “amore è insania”, “amore è calore” Da queste metafore può derivare un numero pressoché infinito di espressioni che è possibile rendere in modi più o meno creativi. Ciò che solitamente viene inteso come un’espressione creativa di una certa idea in una poesia, (…) è spesso solo una sorprendente instanziazione di specifiche strutture metaforiche, che derivano da un limitato set di metafore concettuali condivise da molti individui all’interno di una cultura. Alcune di queste instanziazioni sono il prodotto di un pensiero altamente divergente, flessibile, ma la loro esistenza è determinata da “soggiacenti schemi di pensiero che limitano, o addirittura definiscono, i modi in cui pensiamo, ragioniamo, immaginiamo”.
Il gesto poetico, non solo contribuisce a una accensione a una tensione infinite, ma sono l’indizio di una esperienza e di un nome alle cose e alla pienezza del reale.
Eugenio Montale descrive il rapporto di associazione di vita-arte-vita come un «pellegrinaggio attraverso la coscienza e la memoria degli uomini, il suo totale riflusso alla vita donde l’arte stessa ha tratto il suo primo alimento»[19]
La creazione delle immagini, che portano scritto «più in là», rappresentano la traiettoria di una domanda e di una visione dei propri desideri costitutivi, l’intuizione dei modi con cui si educa a vedere la realtà come segno. Pur in ogni variabilità individuale, guardare la realtà come segno, ci porta a sostare, riflettere, trattare le persone con prospettiva umana e a non smettere mai di indagare, con cura e stima, il «misterio eterno dell’esser nostro».
L’arte risulta allora una lente particolare in grado non solo di osservare la realtà, ma di analizzarla e di elaborarla, definendone le prerogative e i limiti e realizzando una vera e propria Weltanschauung.
L’opera d’arte rappresenta, quindi, l’esito di un processo inconscio che acquista senso plastico e bellezza nelle immagini e nei simboli, e scaturendo da profondità, diversamente, insondabili.
Sklovskij, infatti, afferma che l’arte esiste «per risuscitare la nostra percezione dell’esistenza, per rendere sensibili le cose, per fare della pietra una pietra. Il fine dell’arte è di darci la sensazione delle cose così come esse vengono percepite, non così come vengono conosciute. La tecnica dell’arte consiste nel rendere gli oggetti strani, complicare le forme, accrescere la difficoltà e la durata della percezione, perché il processo della percezione ha un fine estetico in sé e per sé e deve essere protratto (1917)»[20].
Analogamente, la riflessione di Jung[21] penetra sì la personalità creativa dell’artista, portatore di un disagio e di una peculiarità non comune, ma lo riconosce capace di attingere dalle risorse primordiali e originarie dell’umanità e di offrire la possibilità di un superamento della dimensione della sofferenza psichica.
La forza delle immagini primordiali, si pensi a tal proposito alle delicate e vitali immagini della fanciullezza leopardiana, germinano l’opera d’arte, come una sorta di “complesso autonomo” che esprime la sua forza di espressione, imponendosi alla coscienza.
Nell’introduzione del suo saggio, qui preso in esame, Jung assegna alla psicologia i compiti di chiarire «la struttura psicologica dell’opera d’arte» e le «condizioni psicologiche che creano un’artista».
L’intuizione poetica permette di cogliere la strada verso l’ignoto, le lande occulte, il notturno dei voli e dei volti, risale alle figure mitologiche, la primigenìa di un enigma e la pienezza delle sue visioni: «In opere d’arte di questo tipo (che non si debbono mai confondere con la persona dell’artista) è indubbio che la visione è un’autentica esperienza primordiale, checché ne pensino i razionalisti. Non è cosa derivata, secondaria, sintomatica, ma simbolo vero, cioè espressione di un’essenza sconosciuta».[22]
Secondo Jung è possibile rintracciare tali visioni in un nutrito elenco di opere, tra cui Hoffman, Dante, Blake, Goethe. Tutte culminano in un confine quasi epocale, in quanto espressioni larghe del genio profetico e del suo disvelamento:
Perciò il Faust tocca una corda presente nell’anima di ogni tedesco […], perciò la gloria di Dante è immortale e il Pastore di Erma è diventato quasi un libro canonico. Ogni epoca ha le sue unilateralità, i suoi pregiudizi e il suo malessere psichico. Un’epoca è come la psiche del singolo, ha la sua limitata specifica situazione cosciente e ha perciò bisogno di una compensazione; questa le è fornita dall’inconscio collettivo; di modo che un poeta o un veggente esprime l’inesprimibile della sua epoca e dà vita, nell’immagine o nell’azione, a ciò che tutti attendevano, nel bene o nel male, per la salvezza di quell’epoca o per la sua rovina[23].
La formazione intellettuale di Jung inizia con la lettura della Bibbia di Lutero; poi continua con i testi di teologia, ma trova nel Faust di Goethe, un orizzonte possibile di richiamo e di domanda
La sua lettura fu per la mia anima come un balsamo miracoloso “Ecco finalmente” pensai “qualcuno che prende sul serio il diavolo, e conclude persino un patto di sangue con lui – con l’avversario che ha il potere di frustare il proposito di Dio di fare un mondo perfetto” […] Finalmente avevo trovato conferma che vi erano, o vi erano stati, uomini che vedevano il male e il suo potere universale, e – cosa più importante – il compito misterioso che esso ha nel liberare l’uomo dalla sofferenza e dalle tenebre. Pertanto Goethe diventò, ai miei occhi, un profeta.[24]
«In qualche luogo c’era una volta un Fiore, una Pietra, un Cristallo, una Regina, un Re, un Palazzo, un Amante e la sua Amata, e questo accadeva molto tempo fa, in un’isola nell’oceano cinque mila anni fa… Questo è l’Amore, il Fiore Mistico dell’Anima. Questo è il Centro, Il Sé…”.
Jung parlava come se fosse in trance.
“nessuno comprende ciò che voglio dire; soltanto un poeta potrebbe iniziare a comprendere…”.
“Lei è un poeta”, dissi, spinto da quello che avevo udito»[25]
Lo studio della psichiatria rappresenta, pertanto, il trait d’union fra la scienze naturali e quelle umanistiche. Si pone l’obiettivo di conoscere l’uomo e le sue relazioni, deviazioni[26] e tensioni.
Una psicologia che non si riduca a psicofisiologia deve attenersi a «ciò che significa esser uomo»[27], alla sua presenza nell’originario essere-nel-mondo.
Anche l’aspetto psicoanalitico che ha interessato le caratteristiche precipue della psicologia della letteratura[28], da Petrarca, a Borges, fino al teatro quale psicodramma e al «ruolo modulare dell’immaginazione», sta piano piano facendo emergere una sintesi attenta di alcune dinamiche di studio, che qui brevemente abbiamo enunciato.
Gli artisti sembrano precedere gli psicologi nei territori profondi della psiche. In alcune pagine di uno dei romanzi più intensi, sebbene incompiuto, di Hugo von Hoffmansthal Andrea o i ricongiunti[29], nel quale si sviluppa una sorta di immaginario che si spinge fino a frequentare il linguaggio dell’invisibile e nell’ignoto che appare, o ne I quaderni di Malte Laurids Brigge[30], come nelle rabdomantiche e oscure Elegie Duinesi[31] di R.M.Rilke, è possibile rintracciare dense strutture di significato, altrimenti difficilmente distinguibili dalle esperienze psicotiche in senso stretto.
Karl Jaspers in un suo famoso saggio Psicopatologia generale[32] ha affermato che non esistono né psicologie né psichiatrie degne di questo nome, che non cerchino confronti e correlazioni in modo permanente con analisi, ricerche, letteratura, narrativa, poesia e creazioni, che abbiano la capacità di rendere meno drammatico il solco interrotto e, per così dire, bruciato, che separi l’anima, la conoscenza della vita affettiva e la disperazione degli altri.
L’esperienza letteraria, come si evince dagli ultimi acutissimi studi di Eugenio Borgna[33], può permettere l’uscita dalle separazioni delle discipline e una prova di indagine incisiva e profonda tra noi e coloro che ci chiedono aiuto.
I testi letterari riescono a farci comprendere come gli enigmi dell’esistenza possano trovare un varco segreto e un trasloco, attraverso la frequentazione assidua e piena di soste della coltre poetica.
L’apertura umanistica nei confronti del paziente, della sua “mitologia” personale e del suo romanzo autobiografico, trova negli strumenti letterari e poetici il riflesso, non solo di grandi stati d’animo e di grandi angosce, ma soprattutto di altezze estreme, anche perchè, come scriveva la grande scrittrice americana Flannery O’Connor: «Se la vita ci soddisfacesse, fare letteratura non avrebbe senso».
La ribellione e la fiamma contro ogni cosificazione di studio e prassi, permette a tutti coloro che si accingono a rapportarsi all’altro, di sostenerne la fragilità, la debolezza radente e coglierne i particolari singolari.
Occorre, infatti, ciò che Simone Weil chiamava l’ «educazione all’intuizione», affinchè ogni terapia possa permearsi di una conoscenza profonda e maggiormente incisiva.
Il rapporto con il testo non tende a una “psicoanalisi” dell’autore, non cerca di sollevarsi dal perimetro ampio e vasto della sua narratività, ma grazie al solco vivido di una lingua accesa, consente un ulteriore contributo, talvolta decisivo, alla comprensione del paziente, alla sua peculiare esperienza esistenziale e comportamentale e alle sue istanze originarie. L’incontro costituisce l’inizio di tutto:
L’avventura incomincia quando la persona è destata dall’incontro […]. E l’avventura è lo sviluppo drammatico del rapporto tra la persona risvegliata e la realtà intera da cui essa è circondata e in cui vive[34]
perché
Quanto più uno ama la perfezione nella realtà delle cose, quanto più ama le persone per cui fa le cose, quanto più ama la società per cui fa la sua impresa, di qualunque genere, tanto più è per lui desiderabile essere perfezionato dalla correzione. È questa la povertà del nostro possedere le cose, che in ogni lavoro, in ogni impresa rende l’uomo attore, artefice, protagonista. Ma libertà vuol dire anche, oltre che coscienza del proprio limite, impeto creatore. Se è rapporto con l’Infinito, essa mutua dall’Infinito questa inesausta volontà di creare. […] Tutto è correggibile e tutto deve essere creabile. Questo istinto creatore è ciò che qualifica la libertà in un modo più positivo e sperimentalmente affascinante.[35]
L’immagine poetica, nella sua funzione prima espressiva (ossia le immagini mentali e le forme del pensiero e del linguaggio) e poi elaborativa (ossia il generare immagini impresse), esprime il valore conoscitivo del logos, che non si situa nell’astratto, ma vive della concretezza del reale, recuperata grazie al mondo delle «belle apparenze»[36].
Tolstoj, nella sua splendida epopea russa che è Guerra e Pace, coglie con semplicità estrema la divaricazione tra essere e apparire, tra comprensione d’abisso ed esperienza di angoscia:
Oggi mi hanno portato al consiglio di governatorato per farmi esaminare, e i pareri sono stati discordi, hanno discusso e hanno deciso che non sono pazzo, ma lo hanno deciso solo perché durante l’esame mi sono trattenuto dall’esprimere ciò che penso, e non ho espresso ciò che penso perché ho paura del manicomio, ho paura che lì mi impedirebbero di compiere il mio pazzo compito. Hanno dichiarato che sono predisposto all’emotività o qualcos’altro del genere, ma sano di mente. Questo è quello che hanno dichiarato, ma io so che sono pazzo, il dottore mi ha prescritto una cura assicurandomi che se seguirò scrupolosamente le prescrizioni allora tutto ciò che mi agita passerà, cosa non darei perché passasse. È un tormento troppo grande. (…) Tutto il giorno avevo lottato contro la mia angoscia e l’avevo vinta, ma nell’anima c’era una terribile sensazione come se mi fosse successa una qualche disgrazia e io potessi dimenticarla solo temporaneamente, ma era essa lì nel fondo dell’anima e mi dominava[37].
A tal proposito lo studio dell’opera di Elsa Morante si riconnette in modo preciso alle incursioni nel romanzo dell’inconscio, che nella comunicatività e raffinatezza del suo linguaggio, si spingono verso una densa attività onirica, collegata in maniera tumultuosa e angosciosa con la veglia notturna e le crisi nervose. Ida è il personaggio del romanzo La storia, molto vicino alla scrittrice, solita prendere appunti dei suoi sogni.
Era un mondo ricco, contorto e intriso di angoscia, rivissuto attraverso una vivida tensione[38].
Forse, fu anche l’interruzione della cura a provocare una simultanea trasformazione della chimica del suo sonno. Difatti, è incominciata da allora la crescita rigogliosa dei suoi sogni notturni, che doveva accoppiarsi alla sua vita diurna, fra interruzioni e riprese, fino alla fine, attorcigliandosi alle sue giornate più da parassita o da sbirra che da compagna[39].
«Amare la verità che giace al fondo», pertanto, come scriveva Umberto Saba, è un richiamo a sorprendere quell’azione dell’aria, a notarla, a farne memoria e lasciarsi stupire, come spalancamento più largo possibile ai fattori del reale e dell’esistenza.
Diceva Hannah Arendt che purtroppo l’uomo moderno ha sostituito lo stupore che gli antichi ponevano alla base di ogni conoscenza con la dubitosità (e George Steiner aggiungerebbe: con lo scetticismo nemico dell’arte). L’uomo dubitoso e scettico mette in crisi ogni rapporto perché non crede ai suoi occhi, mette in dubbio la forma e quindi vive l’arte come una illusione, e non come quella «magia vera» di cui parlava Giuseppe Verdi. Non ha più visione, ma una sensibilità labirintica, come richiamava Flannery O’Connor. Invece nella poesia che amo tutto procede dallo stupore verso l’alterità presente, misteriosa e infinita, che costituisce il punto di fuga nella nostra avventurosa esperienza. Così che tra percezione elementare e visione non c’è più differenza.[40]
Bibliografia:
Antonelli G., Origini del fare analisi, Liguori, Napoli 2003.
Bernabò G., La fiaba estrema. Elsa Morante tra vita e scrittura, Roma, Carocci 2012.
Binswanger I., Sogno ed esistenza in Per un’antropologia fenomenologica, Feltrinelli Milano 1984.
Borgna E., L’attesa e la speranza, Feltrinelli, Milano 2005.
Id., Come in uno specchio oscuramente, Feltrinelli, Milano 2007.
Id., La solitudine dell’anima, Milano, Feltrinelli, 2011.
Id., Di armonia risuona e di follia, Milano, Feltrinelli, 2012.
Bromberg P. M., L’ombra dello tsunami. La crescita della mente relazionale., edizione italiana a cura di Vittorio Lingiardi e Francesco de Bei, Raffaello Cortina editore, Milano 1998.
Bruner J.S., La costruzione narrativa della “realtà”, in Ammaniti e Stern (1991).
Celan P., Poesie, a cura di Giuseppe Bevilacqua, Mondadori, Milano 1998.
Cole M., Culture and cognitive development: From cross-cultural research to creating systems of cultural mediation, Culture & Psychology, 1, 1995, pp.25-54.
Ezensberger H.M., Gli elisir della scienza. Sguardi trasversali in poesia e in prosa, Einaudi, Torino 2004.
Gibbs R.W., The poetics of mind: Figurative thought, language, and understanding, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
Giussani L., L’io rinasce in un incontro (1986-1987), Bur Rizzoli, Milano 2010.
Id., L’io, il potere, le opere, Marietti, Genova 2000.
Hoffmanstahl v.H., Andrea o i ricongiunti, a cura di Giovanna Bemporad, Adelphi, Milano 1970.
Hillman J., Scritti sull’Umanesimo, a cura di Paola Donfrancesco, Moretti & Vitali, Bergamo 2011.
Jaspers K., Psicopatologia generale, Il Pensiero scientifico, Roma 2000.
Jung C.V., Psicologia e poesia, in Opere vol.10-I, Civiltà in transizione: Il periodo fra le due guerre, Bollati e Boringhieri, Torino 1985.
Id., Ricordi, sogni, riflessioni di C.G. Jung. Raccolti ed editi da Aniela Jaffé, edizione riveduta e accresciuta, Rizzoli, Milano 1978.
Id., Dal paradiso all’inferno. I confini dell’umano in Dostoevskij, a cura di Elena Mazzola, Itaca, Castel Bolognese 2012.
Id., Dostoevskij. Il sacro nel profano, Bur Rizzoli, Milano 2012.
Mandel’ŝtam O., Sulla poesia, con due scritti di Angelo Maria Ripellino e una nota di Fausto Malcovati, Bompiani, Milano 2003.
Massarenti A., Bonnefoy, «A Silvia» e le neuroscienze, Il Sole24 ore, 16 luglio 2011.
Messina L., Psicologia della letteratura: alcuni aspetti educativi, Università virtuale – Spazio editoriale: i quaderni della SSIS – Università Ca’ Foscari di Venezia, pp.1-22.
Montale E., Auto da fè, Milano, Il Saggiatore, 1966.
Morante E., La storia, Einaudi, Torino 2005.
Rilke R.M., Elegie duinesi, a cura di M.Ranchetti, Feltrinelli, Milano 2006.
Id., I quaderni di Malte Laurids Brigge, a cura di F. Jesi, Garzanti, Milano 2002.
Rondoni D., La parola accesa, una mappa di letture, Edizioni di Pagina, Bari 2006.
Id., Non una vita soltanto Scritti da un’esperienza di poesia, Marietti, Genova 2002.
Saba U., Poesia, filosofia, psicoanalisi, in Tutte le prose, a cura di Arrigo Stara, Meridiani Mondadori, Milano 2001.
Schrott R.- Jacobs A., Gehirn und Gedicht Wie wir unsere Wirklichkeit konstruieren (Cervello e poesia. Come costruiamo la nostra realtà), Hanser Verlag, Monaco di Baviera 2011.
Serrano M., Il cerchio ermetico. Carl Gustav Jung e Hermann Hesse, Astrolabio, Roma 1976.
Sklovskij V., Una teoria della prosa. L’arte come artificio. La costruzione del racconto e del romanzo, De Donato, Bari 1966.
Strand M., Ritrovarsi sull’isola dei poeti, “Il Sole24 ore”, 3 luglio 2011.
Tolstoj L., Guerra e Pace, Garzanti, Milano 2007.
Tomassoni R., Psicologia e letteratura alle soglie del terzo millennio, Edizioni Franco Angeli, Roma 1998.
Zambrano M., Filosofia e poesia, a cura di P. De Luca, traduzione di L. Sessa, Pendragon, Bologna 2002.
[1] Saba U., Poesia, filosofia, psicoanalisi, in Tutte le prose, a cura di Arrigo Stara, Meridiani Mondadori, Milano 2001.
[2] Bromberg P.M., L’ombra dello tsunami. La crescita della mente relazionale., edizione italiana a cura di Vittorio Lingiardi e Francesco de Bei, Raffaello Cortina editore, Milano 1998, pp. 5-6.
[3] Ezensberger H M., Gli elisir della scienza. Sguardi trasversali in poesia e in prosa, Einaudi, Torino 2004.
[4] Celan P., Poesie, a cura di Giuseppe Bevilacqua, Mondadori, Milano 1998, pp.551.
[5] Hillman J., Scritti sull’Umanesimo, a cura di Paola Donfrancesco, Moretti & Vitali, Bergamo 2001, p.29.
[6] Antonelli G., Origini del fare analisi, Napoli, Liguori 2003.
[7] Mandel’ŝtam O., Sulla poesia, con due scritti di Angelo Maria Ripellino e una nota di Fausto Malcovati, Bompiani, Milano 2003, p.8.
[8] Massarenti A., Bonnefoy, «A Silvia» e le neuroscienze, “Il Sole24 ore”, 16 luglio 2011.
[9] schrott R.- jacobs a., Gehirn und Gedicht Wie wir unsere Wirklichkeit konstruieren (Cervello e poesia. Come costruiamo la nostra realtà), Hanser Verlag, Monaco di Baviera 2011.
[10] Strand M., Ritrovarsi sull’isola dei poeti, “Il Sole24 ore”, 3 luglio 2011.
[11] Kasatkina T., Dal paradiso all’inferno. I confini dell’umano in Dostoevskij, a cura di Elena Mazzola, Itaca, Castel Bolognese 2012.
[12] Id., Dostoevskij. Il sacro nel profano, Bur Rizzoli, Milano 2012.
[13] Rondoni D., La parola accesa, una mappa di letture, Bari, Edizioni di Pagina, 2006, p.7.
[14] Leopardi G., Zibaldone, 12. VIII 1823
[15]Bruner J. S., La costruzione narrativa della “realtà”, in Ammaniti e Stern (1991), p.31.
[16]Cole M., Culture and cognitive development: From cross-cultural research to creating systems of cultural mediation, Culture & Psychology, 1, 1995, pp.25-54.
[17]Gibbs R.W., The poetics of mind: Figurative thought, language, and understanding, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
[18] Messina L., Psicologia della letteratura: alcuni aspetti educativi, Università virtuale – Spazio editoriale: i quaderni della SSIS – Università Ca’ Foscari di Venezia, pp.1-22.
[19] Montale E., Auto da fè, Il Saggiatore, Milano 1966, p. 135.
[20] Sklovskij V., Una teoria della prosa. L’arte come artificio. La costruzione del racconto e del romanzo, De Donato, Bari 1966.
[21] Jung C.G., Psicologia e poesia, in Opere vol. 10-I, Civiltà in transizione: Il periodo fra le due guerre, Bollati e Boringhieri, Torino 1985.
[24] Ricordi, sogni, riflessioni di C.G. Jung. Raccolti ed editi da Aniela Jaffé, edizione riveduta e accresciuta, Rizzoli, Milano 1978, pp. 90-91.
[25] Serrano M., Il cerchio ermetico. Carl Gustav Jung e Hermann Hesse, Astrolabio, Roma, 1976, p.60.
[26] Borgna E., Di armonia risuona e di follia, Feltrinelli, Milano 2012.
[27] Binswanger L., Sogno ed esistenza in Per un’antropologia fenomenologica, Feltrinelli, Milano 1984, p.67.
[28] Tomassoni R., Psicologia e letteratura alle soglie del terzo millennio, Edizioni Franco Angeli, Roma 1998.
[29] Hoffmannsthal Von H, Andrea o i ricongiunti, a cura di Giovanna Bemporad, Adelphi, Milano1970.
[30] Rilke R.M., I quaderni di Malte Laurids Brigge, a cura di F. Jesi, Garzanti, Milano 2002.
[31] Id, Elegie duinesi, a cura di M. Ranchetti, Feltrinelli, Milano 2006.
[32] Jaspers K., Psicopatologia generale, Il Pensiero scientifico, Roma 2000.
[33]borgna E., L’attesa e la speranza, Feltrinelli, Milano 2005. Id., Come in uno specchio oscuramente, Feltrinelli, Milano 2007. id., La solitudine dell’anima, Feltrinelli, Milano 2011.
[34] Giussani L., L’io rinasce in un incontro (1986-1987), Bur, Milano 2010, pp.206-207.
[35] Id., L’io, il potere, le opere, Marietti, Genova 2000, p. 117.
[36] Zambrano M., Filosofia e poesia, a cura di P. De Luca, Pendragon, Bologna 2002.
[37] tolstoj L., Guerra e Pace, Garzanti, Milano 2007.
[38] Bernabò G., La fiaba estrema. Elsa Morante tra vita e scrittura, Carocci, Roma 2012, pp. 212-215.
[39] Morante E., La storia, Einaudi, Torino 2005, p. 291.
[40] Rondoni D., Non una vita soltanto Scritti da un’esperienza di poesia, Marietti,Genova 2002, pp.19-20.