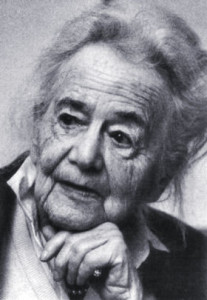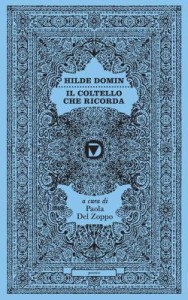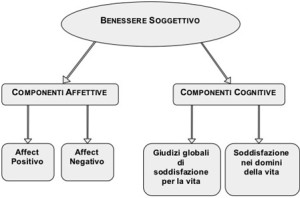di Volfango Lusetti 11 maggio 2016
leggi in pdf La pericolosità del malato di mente
*articolo apparso anche su “Etica & Politica” diretto dal filosofo Pier Marrone, Trieste
 Al concetto di pericolosità del malato di mente non si fa più cenno, nella legislazione psichiatrica italiana, e più in generale nelle leggi sanitarie del nostro paese, a partire dalla legge n. 180 del 1978, poi recepita dalla legge 833 dello stesso anno: ovvero, da quella legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale e che è tuttora in vigore.
Al concetto di pericolosità del malato di mente non si fa più cenno, nella legislazione psichiatrica italiana, e più in generale nelle leggi sanitarie del nostro paese, a partire dalla legge n. 180 del 1978, poi recepita dalla legge 833 dello stesso anno: ovvero, da quella legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale e che è tuttora in vigore.
Occorre a tale proposito sottolineare un fatto curioso: neppure la recente legge 9 del 2012 (la cosiddetta “legge Marino”) e la susseguente legge attuativa (Decreto Legge 52 del 2014, convertito in legge il 24 4 2014), che pure ambivano a completare la riforma psichiatrica del 1978 (proponendosi il fine ultimo di superare gli unici Ospedali psichiatrici ancora rimasti in attività, ovvero gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, e di investire così in pieno il tema del trattamento dei malati di mente pericolosi), hanno osato toccare la pericolosità del malato di mente in quanto “nodo concettuale”, o tanto meno abolire il principio della pericolosità sociale in sé: questi provvedimenti hanno semplicemente stabilito che non potrà più esservi cura del malato di mente autore di reati in strutture che non siano “sanitarizzate” e nelle quali la sorveglianza della forza pubblica non sia al massimo “peri-muraria”, confermando così la pluri-decennale vocazione di tutti i riformatori della Psichiatria italiana a concentrarsi sui “luoghi” anziché sui problemi (il primo dei quali è, per quanto riguarda la pericolosità dei pazienti degli O. P. G., la sua più puntuale definizione, e soprattutto il frequente prolungarsi della degenza dei pazienti pericolosi oltre i limiti stabiliti dalle sentenze, a causa del reiterarsi d’una “valutazione di pericolosità” che può nei fatti fare durare la degenza stessa all’infinito).
Ancora una volta dopo il 1978, dunque, sembra che i Manicomi, agli occhi di molti, siano dei luoghi magici popolati da una sorta di “genius loci” della violenza e dell’arbitrio: un “genius loci” il quale, in caso d’una loro chiusura, si rifiuterebbe di abbandonarli, per cui il “chiudere i Manicomi”, pur senza minimamente preoccuparsi di preparare questo evento con forme di sperimentazione alternativa, e/o del modo in cui i loro ex degenti verranno trattati altrove (giuridicamente o dal punto di vista sanitario), equivarrebbe in ogni caso ad “avviare il problema a soluzione”.
La “pericolosità del malato di mente”, dunque, continua a tutt’oggi, a dispetto della cosiddetta “riforma Marino” e della successiva legge del 2014, ad essere menzionata solo nel diritto penale. Essa del resto, almeno fino a pochi anni fa, era trattata pochissimo anche nell’ambito della Psichiatria clinica, con l’ovvia eccezione della Psichiatria Forense.
In definitiva il tema della “pericolosità del malato di mente”, in parte a causa del suo carattere scottante sul piano dei principi, ed anche in ragione dell’enorme complessità delle problematiche pratiche che solleva, dopo ben trentacinque anni dalla legge 180, pur rimanendo ancora intatto davanti a noi, lo è alla stregua d’una montagna semi-sommersa ed in buona parte invisibile: una sorta di “iceberg” il quale, come appunto avviene con queste montagne di ghiaccio galleggianti, presenta una parte minima “emersa” (che poi corrisponde alla pericolosità del malato di mente autore di reati ed alla sua valutazione, ancora oggi possibile), e la parte maggiore sommersa (che corrisponde al problema della valutabilità della pericolosità del malato di mente non autore di reati, tuttora, trentotto anni dopo la promulgazione della legge 180, del tutto impossibile).
1
La rimozione della pericolosità del malato di mente
In base a quanto sopra, possiamo senz’altro dire che la questione della valutazione psichiatrica della pericolosità del malato di mente è stata per almeno trentacinque anni, e continua ad essere anche oggi, il grande rimosso della Psichiatria italiana.
Come tutti gli altri rimossi, però, essa tende a comportarsi come un “perturbante”, e ed a farlo precisamente nel senso freudiano del termine; infatti la pericolosità è un concetto del quale, in Psichiatria, nessuno parla nella sfera della teoria, ma a cui tutti pensano costantemente nella propria pratica professionale quotidiana, per lo più in maniera inconscia e comunque sempre inconfessata. Ciò avviene ovviamente con importanti conseguenze negative, che ciascuno può facilmente immaginare.
Ma perché mai si è creata, proprio in Italia, questa situazione?
La rimozione della violenza collegata alla malattia mentale avvenuta soprattutto nel nostro paese, è dovuta ad un duplice ordine di fattori.
- Un primo ordine di fattori è di tipo ideologico, e consiste nella forte manipolazione, per l’appunto di natura ideologica, che sul tema della violenza del malato di mente è stata esercitata (in particolare ad opera del pensiero positivistico italiano) per circa un secolo: questa manipolazione è iniziata all’incirca nella seconda metà dell’Ottocento ed è durata, in varie forme, fino agli ultimi anni del Novecento, giungendo praticamente fino a noi.
Essa si è realizzata in due forme contrapposte, articolatesi in due distinti momenti: un primo momento è stato caratterizzato da un’enfatizzazione estrema del nesso esistente fra malattia mentale e violenza. Bisogna qui chiarire che ove si intenda correttamente la “violenza del malato di mente” nel suo duplice risvolto, ossia da un lato come auto-diretta e dall’altro rivolta verso gli altri, proprio a quest’ultima, benché nella realtà clinica essa sia di gran lunga la meno frequente, è stato dato maggior risalto dai “mass media” e dagli intellettuali, di fronte ad un’opinione pubblica per lo più incerta e smarrita; all’inverso, alla violenza auto-diretta, molto più frequente e quasi “tipica” di certi disturbi psichici, è stato dato molto minor spazio agli occhi dei non addetti ai lavori, lasciandola, rispetto alla prima, quasi in ombra. Una tale enfatizzazione della violenza etero-diretta collegata alla malattia mentale, è poi sfociata nell’abuso più sfacciato (operato non solo a livello popolare, ma anche scientifico) dello stereotipo del malato di mente violento; il malato di mente è stato infatti visto come un soggetto, prima ancora che aggressivo, sempre e comunque carente d’ogni capacità di controllo sui propri impulsi d’ogni genere, quindi per definizione “pericoloso a sé ed agli altri”, e ciò in palese contraddizione con la realtà clinica.
In un secondo momento, in particolare a partire dagli anni Settanta del Novecento si è poi passati, come già accennato, ad uno stereotipo opposto: quello di dare per scontata l’assoluta equivalenza fra malati di mente e popolazione generale quanto a frequenza di comportamenti violenti.
Quest’ultimo stereotipo, anch’esso di matrice ideologica, si è alla fine tradotto, al contrario del primo, in una vera e propria negazione del problema della violenza nei malati psichiatrici (un problema che purtroppo talora esiste).
Quest’insieme di manipolazioni ideologiche di segno opposto sul tema della violenza del malato di mente, ha comunque gettato per lungo tempo discredito sull’argomento; si è allora ingenerato in relazione ad esso, almeno negli addetti ai lavori più sensibili all’esigenza d’un approccio scientifico alla malattia mentale, un forte senso di saturazione e di fastidio, ed un sentore di “stile giornalistico”, ovvero di “non serietà”, in relazione all’intera materia.
Tutto questo non ha certo facilitato l’approfondimento del problema, ed ha probabilmente favorito, fra molti degli operatori psichiatrici, una più o meno consapevole volontà di accantonarlo e non occuparsene più.
- Il secondo ordine di fattori di rimozione del tema della violenza nel malato psichiatrico è per l’appunto di tipo psicologico: esso risiede anzitutto nelle fortissime risonanze emotive che l’argomento-violenza genera, da sempre, negli operatori della Psichiatria. Tuttavia, l’influenza di tali risonanze sugli psichiatri, nel nostro paese è stata potenziata, come accennato nel primo punto, dalla perdita graduale (dovuta alle suddette ragioni storico-ideologiche) d’ogni dimestichezza e motivazione a ragionare in termini di pericolosità.
Queste risonanze emotive hanno poi facilitato l’adozione della difesa più facile ed a buon mercato: quella costituita, per l’appunto, dalla rimozione.
Ma qual è, di preciso, la sostanza psicologica del problema?
Agli psichiatri, agli psicoterapeuti ed agli “addetti alla Salute Mentale” in genere:
- a) non piace l’idea di essere in qualche modo corresponsabili delle eventuali violenze che i propri pazienti potrebbero commettere, sia su sé stessi che su altri, in ragione delle ovvie conseguenze giuridiche che potrebbero ricaderne in capo agli psichiatri medesimi.
- b) non piace neppure, per molte ed intuibili ragioni, l’idea di potere essere con relativa facilità fatti oggetto essi stessi di violenza da parte dei propri pazienti.
Essi fanno molta fatica ad accettare, per comprensibili ragioni, sia l’una che l’altra idea, e perciò le rimuovono; ma ciò avviene, per lo meno in Italia, in misura assai maggiore di quanto sarebbe logico aspettarsi in uomini di scienza, ed in forme talora sconcertanti, nonché spesso a dispetto dell’evidenza.
Infatti:
- a) In primo luogo il riconoscimento della potenziale pericolosità del malato di mente implica una grave ferita ai vissuti d’onnipotenza degli operatori psichiatrici, al loro narcisismo, alla loro sicurezza in sé stessi (sentimenti, questi, che sono cospicuamente presenti in tali operatori, e talora paradossalmente lo sono, in misura assai più rilevante che in altre categorie professionali, proprio in quelli a più alto tasso di specializzazione). Gli psichiatri e gli psicoterapeuti, molto più d’ogni altro operatore sanitario, si sentono infatti assai spesso investiti d’un compito e d’una “saggezza” particolari, e di conseguenza ritengono, per lo più a torto, di essere latori di un qualche “messaggio di verità” nei confronti della società nel suo insieme.
- b) In aggiunta a ciò, la violenza mette in luce impietosamente problemi personali irrisolti, paure profonde, psico-dinamiche interiori di tipo patologico e insicurezze di vario tipo, aggressività latente e quant’altro, che appartengono alla dimensione soggettiva di tutti gli individui, ma che negli operatori psichiatrici sono spesso, sfortunatamente, assai più rappresentati che nella popolazione media. In ragione di ciò, la facile identificazione degli psichiatri con i loro pazienti, o al contrario con le loro potenziali vittime, innesca un gioco di proiezioni reciproche che ostacola gravemente il rapporto terapeutico, e la rimozione appare spesso un “facile rimedio” a tutto questo.
- c) Infine, ultimo ma non ultimo elemento, la violenza del paziente psichiatrico, in particolare se esercitata proprio su quelle figure professionali che dovrebbero “curarlo”, sembra fatta apposta per insinuare in esse un forte sospetto circa l’utilità stessa del loro agire terapeutico.
Per queste ragioni la violenza del paziente psichiatrico costituisce l’oggetto ideale per ogni possibile “rimozione”.
La violenza del malato di mente, in buona sostanza, ripropone nei fatti, a tutti i professionisti operanti nel settore della Psichiatria, siano essi di impostazione psico-terapeutica oppure psico-farmacologica, una certa visione custodialistica dei rapporti terapeutici (in sé avvilente sul piano personale, snaturante e dequalificante sul piano professionale, nonché inquietante sul piano culturale ed antropologico) che la maggioranza di loro sperava fosse stata da tempo superata dai progressi della Psichiatria (sia farmacologica che riabilitativa).
Non bisogna dimenticare infatti che, oltre ai progressi della Psichiatria scientifica che lo ha loro permesso, una delle principali motivazioni che hanno portato gli psichiatri ad operare attivamente per il superamento del Manicomio, è provenuta proprio dal vissuto psicologico di frustrazione e d’impotenza terapeutica, nonché di dequalificazione professionale, che l’idea custodialistica e violenta della Psichiatria aveva da gran tempo generato in loro.
Una conferma indiretta di ciò si è avuta nella legislatura 2001-2006, quando la Società Italiana di Psichiatria (S.I.P.) è scesa in campo, in tutte le sue componenti e tendenze tecnico-scientifiche (tra le quali sono cospicuamente rappresentate la Psichiatria Biologica e la Psico-Farmacologia), contro le proposte di modifica in senso regressivo e custodialistico della legge 180 avanzate da alcuni parlamentari dell’allora maggioranza di centro-destra.
Queste modifiche andavano per l’appunto nel senso del ripristino dell’idea d’una “pericolosità” perennemente connaturata al paziente psichiatrico, insieme con quella, ad essa necessariamente conseguente, della necessità d’una custodia coattiva per tempi medio-lunghi del malato di mente, preso in quanto tale ed a prescindere dai suoi comportamenti violenti e/o dalla commissione di reati, in strutture per cronici ad alto o altissimo indice di protezione.
Tuttavia, malgrado un tale complesso sistema di distorsioni, di negazioni e di rimozioni che nel corso del tempo è stato eretto e dispiegato attorno al tema della violenza del paziente psichiatrico, ultimamente esso è sembrato riemergere dal contesto strettamente penale nel quale la legge 180 lo aveva confinato.
La potenziale violenza del malato di mente, dunque, è finalmente tornata ad essere, anche in Italia, un argomento di riflessione clinica su cui si può ragionare con un minimo d’oggettività, restando almeno parzialmente al di fuori del clima d’esasperata emotività conferito a questo argomento dai due opposti schieramenti politico-ideologici che hanno monopolizzato il dibattito su di esso nel recente passato.
Ciò è stato facilitato anche dal fatto che un po’ in tutto il mondo, da gran tempo e già a partire dagli anni Settanta, è in svolgimento un grandioso processo di superamento del Manicomio nonché delle sue basi scientifiche e concettuali, le quali si basavano proprio sul concetto della “pericolosità sociale presunta” del malato di mente.
2
Le ragioni storiche del ridimensionamento in Occidente del concetto della pericolosità del malato di mente
Circa il ridimensionamento da un lato delle prassi inerenti la psichiatria custodialistica e dall’altro dell’apparato ideologico riguardante il concetto della pericolosità sociale presunta del malato di mente (due ambiti strettamente interconnessi), occorre però fare una distinzione fra l’Italia e ciò che è avvenuto nel resto del mondo, poiché si tratta di due ordini di fenomeni non del tutto coincidenti.
In questo paragrafo prenderemo in esame le tendenze internazionali in materia, nel prossimo ciò che di più peculiare è avvenuto in Italia.
Le ragioni di fondo per le quali dagli anni Settanta fino ad oggi, un po’ in tutto il mondo occidentale (ed anche oltre, come ad esempio in paesi emergenti quali il Brasile), si è andati verso un ridimensionamento del concetto di pericolosità del malato di mente, ed anche verso il superamento della psichiatria custodialistica (e con essa, dell’Istituzione Manicomiale), sono di quadruplice ordine:
- si tratta in primo luogo di ragioni economiche: Ronald Reagan, negli anni Settanta Governatore dello Stato della California, chiuse rapidamente gli Ospedali Psichiatrici essenzialmente per ragioni di risparmio sul pubblico erario, e le conseguenze sui malati d’una tale motivazione (la quale a sua volta determinò delle linee di condotta abbastanza avventuristiche) furono spesso tragiche. Ma ciò che accadde in California alcuni decenni fa rappresenta solo l’estremizzazione d’una tendenza di fondo che da allora in poi pervase un numero sempre maggiore di paesi di tutto il mondo, e che non fu estranea neppure alle ragioni, ben più nobili ed articolate, che portarono alla promulgazione della “180” in Italia o alla promozione, in Francia, della cosiddetta “Politica di Settore”, imperniata sulla proiezione dei reparti dell’Ospedale Psichiatrico su “fette di territorio”. Nel corso delle esperienze italiane volte al superamento del Manicomio prima della legge 180, ad esempio, uno degli argomenti più ricorrenti che venivano usati allo scopo di dividere il “fronte conservatore”, era proprio quello che un’assistenza psichiatrica imperniata sul territorio, oltre che più “umana” ed “efficace”, sarebbe stata immancabilmente più “efficiente”, consentendo di risparmiare denaro. In realtà ciò non è stato mai dimostrato, anche a causa della difficoltà di comparare costi relativamente centralizzati e facilmente calcolabili quali quelli inerenti la gestione degli Ospedali Psichiatrici (sia pubblici che privati), con le infinite voci di costo che riguardano la Salute Mentale riformata, comprese le attività “indotte” private ma sovvenzionate dallo Stato (Cliniche private convenzionate, Comunità Alloggio, Case Famiglia, Comunità Terapeutiche, Centri Diurni, Ambulatori, sussidi e pensioni a carico degli Enti Locali e dello Stato, ecc. ecc.). Però è significativo che l’argomento sia stato uno dei “cavalli di battaglia” del fronte riformatore, in Italia, per lungo tempo.
- In secondo luogo, si tratta di ragioni giuridiche: lo stabilire che dei cittadini di uno stato di diritto, in virtù di loro presunte e più o meno permanenti caratteristiche biologiche e senza che abbiano commesso dei reati, siano affetti da una condizione cronica che li rende sempre e comunque “socialmente pericolosi”, ed il rinchiuderli a tempo indefinito, per puri fini di prevenzione sociale, in una struttura di custodia a carattere permanente sotto la risibile parvenza della “cura psichiatrica”, è apparso a molti osservatori, secondo noi pienamente a ragione, una gravissima lesione del principio, ormai invalso in tutto il mondo civile, dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge a prescindere dal loro sesso, razza, religione, lingua, credo politico e stato di salute, ed anche una gravissima violazione del principio dell’inviolabilità dei diritti della persona.
- In terzo luogo, si tratta di ragioni terapeutiche, legate alla sempre maggiore efficacia degli psico-farmaci sul controllo del comportamento alterato ed anche violento dei malati di mente, efficacia che, non si può negarlo, ha avuto un peso determinante per il superamento dei Manicomi. Un’efficacia pari alla Psico-farmacologia, poi, hanno dimostrato fin dai tempi di Conolly le Terapie Riabilitative e Comunitarie basate su metodi non coercitivi e non violenti.
- In quarto luogo, si tratta di ragioni scientifiche e di natura teorica, ed in particolare, della serrata critica che dell’idea di “pericolosità del malato di mente” si è iniziato a fare, sin dagli anni Settanta, in tutto l’Occidente. Già a quell’epoca, infatti, gli studi di Hafner e Boker avevano fatto presente l’incidenza nei malati di mente violenti degli stessi fattori di rischio generico (età giovanile, sesso maschile, bassa scolarità, assunzione di sostanze stupefacenti e d’alcool, appartenenza a famiglie di bassa estrazione sociale) che giocavano un ruolo nel comportamento violento dei soggetti normali, sfatando il mito d’una “fatale” correlazione fra malattia di mente e violenza.
Gli studi sulla violenza nei malati di mente cominciarono ad essere effettuati, come accennato, negli anni Settanta; questi studi, però, detti anche “di prima generazione”, erano abbastanza rozzi ed imprecisi sul piano scientifico, ed infatti sono stati molto criticati, sul piano del metodo, per motivi più che validi.
Un primo motivo era rappresentato dal fatto che prendevano in esame solo campioni pre-selezionati di popolazione, spesso con una spiccata preferenza per popolazioni istituzionalizzate quali quelle carcerarie (di per sé, presumibilmente, molto più violente della popolazione generale, ed anche di quella psichiatrica).
Un secondo motivo è che questi studi, nell’insieme, fornivano risultati molto contraddittori: alcuni di essi andavano nel senso di una sostanziale equivalenza, quanto a comportamenti violenti, fra malati di mente e popolazione generale; altri andavano invece nel senso opposto, ossia rilevavano un’attitudine al comportamento violento nel malato di mente superiore a quella della popolazione generale. Queste discrepanze, peraltro, li rendevano nel loro insieme molto dubbi.
Gli studi cosiddetti di seconda generazione, ed in particolare quelli di J. W. Swanson, di B. Link e di A. Stueve, risalenti agli anni Novanta e Duemila, sono stati invece condotti con maggiore rigore metodologico, poiché hanno iniziato a prendere in esame popolazioni naturali e non campioni pre-selezionati, anche se nel loro complesso hanno continuato a manifestare forti discrepanze gli uni con gli altri.
Occorre dire, peraltro, che tutti gli studi sulla “pericolosità dei malati di mente rapportata a quella della popolazione generale” sono difficilissimi da condurre (quindi in genere poco attendibili), in ragione di due elementi:
- La mancanza in moltissimi paesi, anche per ragioni inerenti la “privacy”, di banche dati sufficienti a raccogliere e confrontare i dati epidemiolologici psichiatrici con quelli provenienti dalla polizia, dalle carceri e dai Ministeri della Giustizia (la Svezia è una delle poche eccezioni a questa regola).
- Il fatto, in sé ovvio ma spesso dimenticato, che la maggior parte degli ammalati di mente, dai primi anni 50 del Novecento in poi, a causa dell’introduzione del trattamento psico-farmacologico, non è più “drug free”, né può essere ricondotta a tale condizione a scopo di studio per ovvie ragioni etiche; perciò quello che in questi studi si esamina (la “pericolosità” d’un campione di malati di mente che si tenta di confrontare con quella d’un campione omogeneo di popolazione generale), non corrisponde più da moltissimo tempo all’effettiva condizione di pericolosità del malato di mente. I riferimenti più attendibili a quest’ultima condizione, dunque, provengono ormai quasi esclusivamente da dati aneddotici (alcuni dei quali in verità impressionanti, anche se potenzialmente attribuibili alla condizione di coercizione cronica) estrapolati dalle cartelle cliniche manicomiali d’epoca pre-psicofarmacologica. D’altra parte, qualora si adottasse un’altra strategia di ricerca e si focalizzasse l’attenzione proprio su quegli ammalati di mente che sfuggono al trattamento farmacologico, si andrebbe incontro ad un altro, non meno potente, fattore di distorsione: la possibile maggiore “pericolosità primaria” propria di quei malati che già in partenza rifiutano il trattamento o lo sfuggono. D’altra parte, che il problema dell’artefatto proveniente dal trattamento psico-farmacologico sia reale è dimostrato dal dato clinico che la maggior parte degli “incidenti” derivanti dalla pericolosità del malato di mente, si verificano in occasione del mancato rispetto delle prescrizioni terapeutiche e/o del mutamento o della sospensione della terapia.
Fatte salve tutte queste cautele, anche gli studi di “seconda generazione” in tema di pericolosità hanno finora fornito dei dati alquanto contraddittori: alcuni non rilevano differenze significative fra malati di mente e popolazione generale, altri invece le rilevano, suggerendo una sensibile maggior pericolosità dei “malati di mente”.
Però si è anche visto che anche in quest’ultimo caso il dato della “maggior pericolosità”, pur apparendo statisticamente significativo, cessa d’esser tale ove disaggregato in base alle differenze di diagnosi: per tali motivi, alla maggior parte dei ricercatori esso, comprensibilmente, non è sembrato in grado di giustificare l’adozione di misure preventive circa una presunta e generalizzata pericolosità sociale dei “malati di mente” (misure che fra l’altro hanno quasi sempre una conseguenza devastante sui principi giuridici liberali che sono propri d’uno Stato di Diritto).
Insomma, la “maggior pericolosità” dei malati di mente rilevabile secondo alcuni studi, riguarda un dato inerente l’insieme dei “malati di mente” che preso in sé non solo non significa nulla, ma conduce ad una visione fortemente distorta del problema.
Andando ancor più in particolare, si è visto che la pericolosità è sensibilmente più alta nei “disturbi antisociali di personalità” e “paranoidei”, oppure in alcune forme di psicosi schizofrenica paranoide o bipolare, che non in altre categorie diagnostiche.
Questa esperienza, insieme ad un maggior rigore metodologico degli studi più recenti, ha portato ad una conseguenza pratica rilevante: oggi, a livello di letteratura scientifica e di orientamenti giuridici internazionali, viene messa fortemente in dubbio la possibilità di trarre, dai dati di epidemiologia psichiatrica oggi disponibili, conseguenze d’ordine organizzativo e gestionale in ordine alla pericolosità.
In sintesi, contrariamente a quanto un tempo affermato dalla tradizione positivistica italiana (e particolarmente lombrosiana), oggi, a livello di letteratura internazionale, vengono messe fortemente in dubbio:
- a) la possibilità di prevedere scientificamente la pericolosità sociale d’un malato di mente, nel “lungo periodo” e semplicemente in quanto malato di mente.
- b) la possibilità di prevedere la pericolosità d’un malato in quanto esponente d’una categoria diagnostica psichiatrica particolare, quindi a prescindere dalla sua anamnesi individuale e dalle sue personali caratteristiche cliniche.
A questo proposito, è stato fatto autorevolmente osservare che gli autori di comportamenti violenti costituiscono un gruppo quanto mai eterogeneo (K. Tardiff), e che il comportamento violento costituisce per sua natura, più che il risultato d’un singolo fattore, un evento multi-fattoriale; in esso dunque il numero delle variabili (sia d’ordine clinico e psichiatrico, sia d’ordine relazionale, sia d’ordine ambientale) è elevatissimo, e comunque molto più elevato che in qualunque altro settore della Psichiatria. Perciò il confronto fra macro-popolazioni di “malati” e la popolazione generale può essere falsato da fattori di distorsione talmente numerosi da risultare, alla fine, scarsamente attendibile.
In definitiva, sull’interesse a confrontare statisticamente, con quelli della popolazione generale, i comportamenti violenti dei malati psichiatrici presi nel loro insieme (ossia in quanto generica ed onnicomprensiva categoria biologica dei “malati di mente”), o anche quelli di particolari categorie diagnostiche, specie al fine di trarne conclusioni rispetto ad una possibile prevenzione della violenza nel lungo periodo, oggi prevale un altro tipo d’interesse: quello ad effettuare una ricerca polarizzata sullo studio analitico della dinamica dell’atto violento preso in sé stesso, e sull’individuazione di fattori predittivi di pericolosità immediata che siano operativi nel singolo individuo, quindi anche nel singolo malato di mente, caso per caso.
Sulla base di queste considerazioni ormai si ricerca, più che l’evidenza scientifica di una generica “maggiore pericolosità media” del malato di mente rispetto alla popolazione generale, l’elaborazione di indicatori che permettano di effettuare, sul caso singolo, una previsione di pericolosità nel breve periodo; quest’ultima infatti è la più utile sul piano pratico e la più eticamente accettabile, ed inoltre presenta, sul piano dell’analisi dei dati, un numero di variabili molto più ridotto.
Questa impostazione di tipo completamente nuovo ha perciò conferito una rinnovata dignità scientifica da un lato alla pato-biografia, ossia allo studio approfondito del singolo caso clinico (una disciplina che, significativamente, in Italia, ancora oggi viene coltivata soprattutto dagli psichiatri forensi), dall’altro ad una Psicopatologia “basata sulla narrazione”, la quale affianchi ed integri quella “basata sulle evidenze” (cfr. ad es. A. Carlino, 2013). Essa infine ha conferito importanza allo studio dei fattori predittivi di pericolosità, la cui problematica individuazione nel lungo periodo aveva gettato discredito un po’ su tutto l’argomento (J. Monahan).
Tale orientamento si è riflesso, come vedremo in seguito, anche sulla legislazione americana concernente il ricovero coatto.
3
La situazione in Italia
Quanto ai motivi più particolari che hanno portato al ridimensionamento del concetto di pericolosità del malato di mente in Italia, occorre fare un passo indietro di trentacinque anni e riportarci per un attimo alla situazione della Psichiatria Italiana al momento della promulgazione della legge 180.
In Italia, negli anni precedenti il 1978 (anno del varo della riforma), non erano certo mancate, “a latere” d’un sistema manicomiale fra i più arretrati e repressivi d’Europa, esperienze avanzate di trasformazione/superamento del Manicomio, condotte sia all’interno dello stesso Manicomio (che ci si sforzava di trasformare in una cosiddetta “Comunità Terapeutica”), sia sul territorio, attraverso la creazione di Servizi di Salute Mentale fortemente innovativi e concorrenziali con l’istituzione manicomiale stessa: in particolare, furono significative le esperienze di Franco Basaglia (Gorizia e Trieste), di Giovanni Jervis (Reggio Emilia), di Carlo Manuali (Perugia), di Agostino Pirella (Arezzo), di Sergio Piro (Napoli), di Antonio Slavich (Ferrara), e diverse altre.
Queste esperienze furono però fortemente avversate, all’inizio, dal feroce spirito conservatore (o addirittura retrivo) che pervadeva in quell’epoca il resto della Psichiatria italiana; inoltre suscitarono, anche in virtù d’un certo radicalismo elitario ed iper-politicizzato che pervadeva alcune di esse e le rendeva relativamente isolate, dei seri interrogativi sulla loro reale capacità di fare “breccia” nel sistema, nonché di fungere davvero da “traino” per l’insieme dell’assistenza psichiatrica.
In questa situazione, profondamente contraddittoria ed in lentissima e faticosa evoluzione, sopravvenne tuttavia all’improvviso un evento il quale spinse tutti i suoi protagonisti in avanti e li costrinse a scelte drastiche, ma soprattutto rapidissime: la promozione da parte del Partito Radicale d’un referendum abrogativo della legge 36 del 1904 (la cosiddetta “legge manicomiale” d’ispirazione lombrosiana).
Il motivo ispiratore dell’iniziativa radicale, occorre chiarirlo in via preliminare, era assolutamente sacrosanto: occorreva sanare il gravissimo “vulnus” che la legge 36 del 1904 infliggeva al principio costituzionale dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nel suo distinguere dagli altri cittadini quelli che, in virtù di loro supposte caratteristiche biologiche (la malattia di mente) che li rendevano presuntivamente “pericolosi per sé e per gli altri”, oppure “di pubblico scandalo”, dovevano essere reclusi in luoghi di detenzione travestiti da luoghi di cura (i Manicomi), e deprivati praticamente per sempre d’ogni diritto civile e politico, peraltro senza aver mai commesso alcun reato.
Ebbene, proprio il combinarsi delle due componenti rappresentate a) dal già citato radicalismo delle esperienze di lotta al Manicomio, in particolare di quelle di Trieste ed Arezzo (un radicalismo promosso soprattutto dalla fortissima personalità di Franco Basaglia, il quale tendeva a “mettere tra parentesi” la malattia mentale e la sua cura “medica” per dedicarsi invece, in via prioritaria, alle tematiche sociali e politiche della lotta all’esclusione) e, b) dalla minaccia dell’iniziativa referendaria (in caso di abrogazione della legge del 1904 si sarebbe avuta una “vacatio legis” che andava assolutamente prevenuta), fu ciò che produsse la legge n. 180 del 1978, poi impropriamente denominata “legge Basaglia” (Basaglia, in realtà, ne fu al massimo l’ispiratore ed il consulente, non l’autore materiale).
Insomma, questa legge nacque non già nel segno d’un meditato intento di profonda ed organica riforma della Psichiatria italiana (o tanto meno, sulla scorta della progressiva sperimentazione di soluzioni alternative al Manicomio, come stava già avvenendo nel resto del mondo civile ed in parte anche in Italia), bensì come rimedio urgente ad una situazione d’emergenza, preso anzitutto con criteri politici: un “rimedio” che, nella mente di alcuni dei parlamentari suoi autori, avrebbe potuto e dovuto essere successivamente completato da una riforma più organica e complessiva (cosa che come si sa non avvenne, o avvenne in misura assolutamente insufficiente).
In ragione di ciò, le norme attuative della legge n. 180 del 1978 (in particolare, quelle che dovevano istituire e finanziare le strutture terapeutico-riabilitative ambulatoriali e residenziali alternative al Manicomio), non furono varate contestualmente alla legge medesima, bensì rimandate a futuri Piani Sanitari Regionali che avrebbero dovuto definirle nel dettaglio, e che promanavano dalla più generale legge 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (anch’essa del 1978 ed allora in stato d’avanzata preparazione).
In base a tutto ciò, i due elementi del “problema psichiatrico” che gli estensori della legge 180 si trovarono di fronte nell’immediato, furono i seguenti:
- Occorreva creare quanto prima, affinché la nuova assistenza non ricalcasse le caratteristiche negative (di tipo custodialistico e liberticida) che i promotori del referendum contestavano, un modello d’assistenza non manicomiale, ossia basato non già su grandi strutture residenziali coattive e “di lungo periodo” (il Manicomio appunto), bensì su piccole ed agili strutture di ricovero (coatto e non) le quali fossero finalizzate al breve periodo e limitate all’urgenza (i S. P. D. C., o “Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura”), nonché su un modello di lavoro territoriale imperniato sull’assistenza domiciliare: un lavoro, quest’ultimo, che per i motivi sopra indicati andava svolto essenzialmente a partire dalle strutture già esistenti (i cosiddetti “Centri di Igiene Mentale”, o C. I. M., istituiti già nel 1968 dalla “legge Mariotti”, poi denominati “Centri di Salute Mentale” o C. S. M.).
- Occorreva poi garantire gli psichiatri, stante l’improvvisa forte carenza di strutture di ricovero e di cura coattiva determinata dalla chiusura delle accettazioni degli Ospedali Psichiatrici, rispetto ad una minaccia molto concreta che avrebbe potuto presto abbattersi su di loro a causa dell’impossibilità, che questa situazione aveva creato, di dar luogo ad una “custodia di lungo periodo” della pericolosità: ora, questa “garanzia” venne dall’avere la legge n. 180 abolito ogni precedente riferimento al tema, appunto, della “pericolosità del malato di mente”, sostituendolo con quello, assai più sfumato, ambiguo e nella sostanza inafferrabile, ad una “comprovata necessità ed urgenza delle cure”, accompagnata dal “rifiuto” delle stesse da parte del malato e dall’”impossibilità di effettuarle in sede extra-ospedaliera”.
A proposito di quanto sopra, chi ha vissuto quegli anni dall’interno delle prassi psichiatriche all’epoca vigenti, in specie se, come lo scrivente, lo ha fatto in giovane età e da posizioni innovative, ricorda certamente un fatto prodigioso ed abbastanza sorprendente: le pervicaci e talora feroci resistenze ad ogni ipotesi d’assistenza psichiatrica non manicomiale, le quali provenivano dalla stragrande maggioranza della Psichiatria Italiana (accademica e non), sparirono quasi d’incanto con la promulgazione della legge n. 180: all’improvviso, si vide un gran numero psichiatri ultra-conservatori o addirittura reazionari divenire fervidi fautori della nuova legge, o quanto meno rinunciare ad ogni aperto ostracismo contro di essa e chiudersi in un benevolo silenzio e/o in una fattiva collaborazione.
Il motivo di ciò, oggi è del tutto chiaro, e secondo noi va ben oltre il ben noto trasformismo e “codismo” degli intellettuali italiani: la caduta della presunzione di pericolosità del malato di mente non solo sembrava proteggere gli psichiatri italiani da ogni possibile negativa conseguenza giuridica dell’affermarsi d’una psichiatria non manicomiale, ma appariva porli addirittura in una posizione professionalmente più comoda di quella dell’era manicomiale; infatti faceva cadere a priori (o almeno, così ci si illuse che fosse!) ogni possibilità di attribuire loro una colpa professionale grave, o addirittura un’omissione di atti di ufficio, qualora non avessero tempestivamente provveduto al ricovero d’un paziente, dal momento che la nuova normativa prevedeva che le competenze dello psichiatra, lungi dal dovere valutare la “pericolosità del malato” (un compito in cui era facilissimo inchiodarlo alle sue presunte inadempienze), si limitassero ormai ad una semplice “valutazione tecnico-professionale sulla necessità ed improrogabilità d’un ricovero”, elemento quest’ultimo difficilissimo da contro-valutare dal punto di vista legale, specie in assenza della pericolosità (le malattie mentali, a differenza di quelle mediche, non mettono a repentaglio la salute fisica e/o la vita se non in caso di suicidio, ed il suicidio non rientrava più neppur esso, già all’epoca del varo della legge 180, nella dizione di “pericolosità”, per cui ormai non era per niente facile contestare allo psichiatra il mancato adempimento ai suoi obblighi di valutazione tecnico-professionale sulla necessità d’un ricovero, ed il suo giudizio diveniva di fatto insindacabile).
Vedremo nei successivi paragrafi come l’altalena delle sentenze “per colpa professionale” a carico degli psichiatri, negli ultimi anni, abbia in gran parte vanificato queste illusioni: tuttavia l’aspettativa di essere maggiormente protetti dalla legge che non in passato, era sul momento in gran parte fondata: la nuova normativa, effettivamente, almeno per alcuni decenni rispose bene al suo scopo.
Come vedremo e come in parte abbiamo già anticipato, tuttavia, gli anni più recenti hanno ormai rivelato come il “paracadute giuridico” dell’abolizione della valutazione di pericolosità abbia cominciato a non aprirsi più con la tempestività e la sicurezza del passato: ciò al punto da insinuare in alcuni il dubbio se per caso, anche da un semplice punto di vista opportunistico, non sarebbe più saggio che gli psichiatri italiani cominciassero a rivedere l’intera questione, e ad esaminare la possibilità di riappropriarsi (come avviene nel resto del mondo!) della valutazione di pericolosità in quanto loro imprescindibile competenza tecnico-professionale.
4
La “pericolosità sociale presunta” propria della vecchia normativa, ed il “rifiuto delle cure” proprio della nuova
Il codice penale Rocco del 1930 contiene al proprio interno alcuni principi di chiara derivazione positivista e lombrosiana: infatti è, fra i principali codici europei, uno di quelli che introducono in forma più netta il principio giuridico lombrosiano della “pericolosità sociale presunta” di soggetti autori di reati.
Questo codice, peraltro, è a tutt’oggi quasi integralmente in vigore, anche se la sua parte psichiatrica è stata in gran parte stralciata dal codice stesso ed eliminata ad opera della legge 180 del 1978, impropriamente detta “legge Basaglia”.
Al “Codice Rocco” peraltro, il quale ha regolamentato essenzialmente la pericolosità del malato di mente autore di reati e giudicato “non imputabile”, come sappiamo si era a lungo affiancata, fino al 1978, una “legge psichiatrica”, la legge manicomiale n. 36 del 1904, anch’essa d’ispirazione lombrosiana, la quale concerneva la “pericolosità sociale presunta” e di lungo periodo dei malati di mente non autori di reato: essa era dunque antecedente al codice Rocco, ma ancora più di quest’ultimo era ispirata alle idee di Lombroso.
In quest’ultima legge, sulla base del principio della “responsabilità collettiva”, veniva prevista una precisa forma di prevenzione della “pericolosità sociale presunta” dei malati di mente in quanto tali, ossia a prescindere dall’avere essi commesso o no dei reati (pericolosità che derivava dalla supposta predisposizione biologica del folle a quella “violenza atavica” che era stata postulata proprio da Lombroso): a tali soggetti dunque, considerati atavici e “degenerati” solo perché definiti, sulla base d’un certificato medico, come “pericolosi a sé ed agli altri” oppure “di pubblico scandalo”, veniva comminato, con semplice provvedimento di polizia, l’internamento coatto (che previo assenso del Direttore, dopo un periodo d’osservazione di 30 gg diveniva il più delle volte definitivo) in un Ospedale Psichiatrico Provinciale.
Come già accennato all’inizio, malgrado due leggi di riforma psichiatrica, la legge 180 del 1978 che aboliva gli Ospedali Psichiatrici Provinciali e la legge n. 9 del 2012 che ha sancito l’inizio del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, dal 1930 (anno dell’introduzione del codice Rocco) fino ad oggi, ben poco è cambiato per quella parte del diritto penale che riguarda la pericolosità del malato di mente autore di reati: sono tuttora in vigore le concezioni lombrosiane sulla pericolosità sociale dei malati autori di reato, poi integralmente recepite nel codice Rocco, le quali riguardano essenzialmente il tema della pericolosità sociale psichiatrica (pericolosità riferita agli autori di reato riconosciuti come “non imputabili” in quanto malati di mente).
L’unica cosa che è cambiata (ma ben prima della legge n. 9 del 2012 e per merito esclusivo della Corte Costituzionale!) è la caduta del carattere “presunto” della pericolosità dei malati di mente autori di reato, in quanto “l’accertamento della pericolosità” deve ora avvenire in sede peritale prima dell’avviamento del soggetto alle misure di sicurezza (sentenze della Corte Costituzionale del 27 Luglio 1982, n. 139, e del 28 Luglio 1983, n. 249, poi codificate in legge con la 663 del 10/10/1986).
Invece, come sappiamo, quasi tutto è cambiato nell’ordinamento legislativo psichiatrico ordinario: ciò in particolare dal 1978, anno della “legge 180”, in poi.
Nella legislazione psichiatrica riguardante i malati di mente non autori di reati, infatti, l’idea lombrosiana della necessità di prevenire un’ipotetica “pericolosità sociale presunta” del malato di mente in quanto tale, internandolo coattivamente in Ospedale Psichiatrico, è stata completamente superata dalla legge n. 180 la quale, come già accennato, non fa più alcun cenno al tema della pericolosità come motivo di ricovero psichiatrico: non vi fa cenno né come “pericolosità sociale presunta di lungo periodo”, né come valutazione psichiatrica della “pericolosità clinica attuale”.
Questa clamorosa discrepanza fra legislazione penale e legislazione psichiatrica ha poi portato ad alcune, non meno clamorose, incongruenze: in particolare, quella fra la perdurante presenza nel codice penale dell’idea della pericolosità sociale del malato di mente (in particolare, riguardo ai malati di mente autori di reato), e la scomparsa di tale concetto dalla legislazione psichiatrica ordinaria riguardante gli ammalati di mente non autori di reato, per cui uno stesso soggetto psichiatrico, un minuto prima di aver commesso un fatto delittuoso non è valutabile quanto alla sua pericolosità futura, ed un minuto dopo lo è.
Ora, è ovvio che se la pericolosità del malato di mente esiste in ambito giuridico come “pericolosità sociale”, deve esistere anche su quel piano clinico che sarebbe alla base del suo comportamento criminale; viceversa, se non esiste in ambito clinico, non dovrebbe a rigore esistere neppure in ambito giuridico (il presupporre una propensione “patologica” a commettere nuovamente crimini nel malato di mente che li ha già commessi, non può non basarsi su dei dati clinici precisi, altrimenti non dovrebbe esistere per lui alcuna “pericolosità sociale” appositamente regolamentata).
Ora, il motivo d’una tale discrepanza fra pericolosità clinica e pericolosità sociale, che non esisteva affatto prima dell’approvazione della legge 180 del 1978, è molto semplice: la “legge manicomiale” del 1904 ed il Codice Penale Rocco del 1930 formavano, a prescindere dal loro discutibile contenuto, un insieme relativamente razionale e coerente, e questa coerenza si è spezzata proprio con la legge 180.
La legge manicomiale n. 36 del 14/2/1904 ed il relativo regolamento d’attuazione n. 615 del 16/8/1909, conferivano infatti la caratteristica d’una “pericolosità sociale presunta” (e imponevano il ricovero in O.P.), a tutti i malati di mente connotati come:
- “pericolosi a sé ed agli altri”
- “di pubblico scandalo”.
La sussistenza anche di una sola di queste due condizioni giustificava e rendeva d’obbligo il ricovero coatto in un Ospedale Psichiatrico Provinciale.
L’espressione, riferita al folle, di soggetto “pericoloso a sé ed agli altri”, anche se è rimasta fortemente impressa nell’immaginario collettivo (fino a venire erroneamente usata, ancora oggi, persino da alcuni Medici ed Assistenti Sociali), fu abolita con la riforma psichiatrica del 1978, unitamente all’abolizione degli Ospedali Psichiatrici.
Con la legge 180, come motivo per un ricovero coatto si è sostituito, al concetto della “pericolosità”, quello del “rifiuto delle cure”, cure però delle quali esista una “comprovata necessità ed urgenza”.
Ora, al fine di comprovare la necessità ed urgenza delle cure, occorre attualmente la proposta d’un medico (non necessariamente d’uno Psichiatra), convalidata da quella d’un altro medico (questo, però, appartenente almeno ad una struttura pubblica).
Il provvedimento, della durata d’una settimana e rinnovabile anche più d’una volta (però sempre per periodi di soli 7 giorni), è emanato dal Sindaco e notificato al Giudice Tutelare, e viene attuato nei SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura).
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in regime di degenza ospedaliera deve comunque essere motivato, oltre che dalla “necessità ed urgenza delle cure” e dal “rifiuto dell’interessato”, anche dall’”impossibilità ad effettuare le cure in regime di trattamento extra-ospedaliero” (una condizione, quest’ultima, alquanto ambigua nel suo significato e la cui sussistenza effettiva non viene quasi mai verificata, ma che serve a meglio giustificare quei mancati ricoveri nei quali “il paz. accetti le cure”).
Come è noto, anche la legge 833 del 1978 attualmente in vigore, che ha integralmente recepito la 180 e che disciplina il TSO in regime di degenza ospedaliera, subordina la sua effettuazione esattamente a queste stesse tre condizioni:
- la necessità improrogabile di cura
- il rifiuto delle cure da parte del soggetto
- l’impossibilità ad effettuare il trattamento in condizioni di degenza extra-ospedaliera.
Queste condizioni poi, è da notare, devono essere presenti tutte e tre per dar luogo alla possibilità legale di procedere al ricovero coatto (ovvero in TSO) del paziente.
E’ evidente che la “pericolosità”, la quale non appare fra queste nessuna di queste tre condizioni, non può e non deve in alcun modo rappresentare un motivo di ricovero obbligatorio.
La differenza concettuale tra la vecchia e la nuova normativa per il ricovero, come si vede, è davvero notevole.
In primo luogo, la “pericolosità” cui faceva riferimento la legge del 1904, essendo intesa lombrosianamente come una condizione avente una base medica e biologica ed antropologica, s’intendeva essere connaturata alla malattia, ed in quanto tale, essere “persistente” almeno per un po’ nel tempo.
Invece il “rifiuto delle cure” di cui parla la legge 180 non è indissolubilmente connesso alla “natura della malattia”, quindi almeno in teoria può anche recedere immediatamente a seguito di un’opera di convincimento, o d’un semplice cambiamento d’idea da parte del paziente.
In secondo luogo, la pericolosità (almeno se intesa come pericolosità verso gli altri) non è una condizione che scaturisca dal rifiuto delle cure, né vi è implicita; essa, nell’attuale legge psichiatrica italiana, non viene considerata in alcun modo, neppure come eventualità clinica collegata al rifiuto stesso.
Lo psichiatra dunque, nel valutare un quadro clinico, deve “mettere tra parentesi” la potenziale pericolosità insita in esso, anzi non deve neppure nominarla; oppure, se decide di prenderla in considerazione, deve considerarla surrettiziamente, ovvero mascherarla dietro la sottolineatura esclusiva della “necessità” e della “improrogabilità” delle cure, nonché del “rifiuto” persistente del paziente alle cure stesse e dell’impossibilità, nella situazione data, di mettere in atto provvedimenti di d’idonea risposta terapeutica in regime di trattamento extraospedaliero.
Nel compiere tale operazione, tuttavia, egli deve guardarsi da due opposti errori, sanzionati entrambi con estrema severità dal codice penale attuale:
- L’errore per eccesso d’intervento, che può portarlo, in caso di TSO indebito o non sufficientemente motivato in base a quanto sopra, a soggiacere all’accusa di sequestro di persona (art. 650 del C.P., che prevede una pena da uno a dieci anni per il pubblico ufficiale il quale nell’esercizio delle sue funzioni compia tale reato mediante abuso delle proprie prerogative).
- L’errore per difetto d’intervento, il quale può configurare sia la colpa professionale (che è sanzionata in dettaglio, sia sul piano civile che penale, nelle figure dell’”imperizia”, della “negligenza” e dell’”imprudenza”), sia il reato penale d’omissione di soccorso e quello d’abbandono d’incapace (l’art. 691 del C.P. definisce “abbandono d’incapace” qualunque azione o omissione che contrasti con l’obbligo della cura e della custodia, ove sussista uno stato di potenziale pericolo per l’incolumità della persona incapace)
5
Le responsabilità dello psichiatra
Il tema della responsabilità giuridica dello psichiatra per i comportamenti auto ed etero-aggressivi dei propri pazienti, nel contesto della legislazione attuale, ruota oggi, in definitiva, attorno a tre aspetti:
- l’esistenza o meno d’una posizione di garanzia in capo al medico psichiatra, la quale fondi una sua responsabilità in relazione all’ex art. 40 del C.P. Esso recita che “il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
- La configurabilità d’una colpa professionale posta in essere da un eventuale comportamento omissivo dello psichiatra.
- La prevedibilità e l’evitabilità, ai fini della valutazione dei due primi aspetti, dell’evento dannoso posto in essere dall’infermo di mente.
A questo proposito, un precedente giudiziario significativo è quello costituito dal procedimento a carico d’uno psichiatra aretino il cui paziente, da lui non ricoverato malgrado la ripetuta richiesta d’aiuto dei genitori, accoltellò a morte la madre.
Nei tre gradi di processo svoltisi dal 1983 al 1987, lo psichiatra fu dapprima assolto in Primo Grado, poi condannato in Appello, ed infine definitivamente assolto in Cassazione.
La motivazione dell’assoluzione finale fu la seguente:
- lo psichiatra non era venuto meno ad un obbligo specifico di ricovero (incorrendo in un’”omissione di soccorso”, o in un “abbandono d’incapace”), in quanto non esisteva alcuna norma di legge che lo obbligasse a ricoverare chicchessia per una sua “presunta pericolosità”, ma solo una norma di legge che gli conferiva la piena discrezionalità tecnico-professionale nella decisione circa la “necessità” e “l’improrogabilità” di cure “in regime di degenza ospedaliera”.
- Lo psichiatra non era neppure incorso in una “colpa professionale”, ossia in una qualche forma d’“imperizia”, “imprudenza” o “negligenza” circa la necessità di cure, poiché l’evento verificatosi non era prevedibile con sufficiente approssimazione, né evitabile “ex ante”.
E’ però doveroso segnalare che una sentenza molto più recente della Cassazione (riguardante il cosiddetto “caso Pozzi”) emessa nel 2007, ha condannato in via definitiva uno Psichiatra di Comunità dell’Emilia Romagna il cui paziente psicotico (assegnato alla Comunità stessa dal Tribunale di Sorveglianza, e proveniente dall’ O.P.G. per gravi reati contro la persona) uccise un operatore con il quale aveva contrasti da gran tempo: egli lo fece in un momento immediatamente successivo alla sospensione della terapia “long acting”, ordinata dal professionista in ragione dei suoi gravi effetti collaterali sul paziente; la terapia, peraltro, era stata quasi subito ripresa, ma a dire della sentenza, con colposo ritardo. Allo psichiatra, però, al di là dei numerosi elementi di “malpractice” che si è ritenuto di riscontrare nel suo operato sia da parte dei Periti che dal Giudice, è stata soprattutto contestata la mancata effettuazione del TSO, con la motivazione che, benché il malato avesse accettato le terapie (e quindi sembrasse non soddisfare la seconda delle tre condizioni necessarie per effettuare un TSO, quella del rifiuto delle “cure”, e neppure la terza, visto che risiedeva già in una struttura psichiatrica), non c’era alcun motivo che impedisse allo psichiatra, data la grave situazione clinica complessiva e l’anamnesi inquietante, di proporgli comunque il ricovero; egli, insomma, avrebbe dovuto intendere lo stesso ricovero come “cura”, ovvero come “adeguata terapia”, e se del caso, avrebbe dovuto decidere d’imporlo al paziente a prescindere dalla sua accettazione delle cure farmacologiche (effettuando, occorre dire, una notevole forzatura dello spirito e della lettera della legge 180, ed in particolare sia della seconda condizione, ossia dell’”assenso del paziente alle cure”, sia della terza, che prevede la “verifica se le cure non possano essere effettuate anche in regime di degenza extra-ospedaliera”).
La motivazione di questa sentenza perciò, pur facendo riferimento ad una “colpa professionale”, chiama di nuovo in causa, nella sostanza, quella “posizione di garanzia” rispetto alla pericolosità che la sentenza precedente sembrava escludere; essa poi lo fa, segnatamente, con una sorta d’escamotage, ossia interpretando in maniera assai estensiva il concetto di “cura”.
5
Legislazioni a confronto
E’ interessante a questo punto, a proposito della pericolosità, un breve confronto con la legislazione americana: questa infatti, al contrario di quella italiana, ai fini della motivazione d’un Trattamento Sanitario Obbligatorio psichiatrico, privilegia esplicitamente proprio la “pericolosità sociale” rispetto alla “necessità della cura”.
Essa inoltre (cosa molto significativa perché in linea con le più recenti acquisizioni del pensiero scientifico) fa leva sulla specifica competenza e responsabilità tecnico-professionale dello psichiatra nel prevedere il rischio di eventi violenti auto o etero-lesivi, ma lo fa solo nel breve periodo e non nel lungo (come invece, fino a pochi decenni fa, faceva la cultura giuridica italiana di stampo lombrosiano).
Il Civil Commitment americano, dunque, lega la possibilità d’un ricovero obbligatorio di 72 ore (estensibile solo con decisione giudiziale) a tre elementi, il cui accertamento è specificamente legato alla responsabilità professionale e tecnica dello psichiatra:
- Presenza di pericolosità per gli altri.
- Presenza di pericolosità per sé stessi.
- Presenza d’uno stato di grave disabilità e mancanza d’autosufficienza (elemento, questo, considerato dagli stessi giuristi americani come una ridondanza degli altri due, ed in particolare del secondo).
L’accertamento della “presenza della pericolosità” cui fa riferimento la legge americana, come si vede, è una valutazione tecnico-scientifica specifica e polarizzata sulla situazione clinica concreta, rilevabile tramite una visita specialistica accurata ed accertamenti sanitari “mirati”, e soprattutto centrata sul breve periodo. E’ infatti da sottolineare, lo ripetiamo, come tutti gli studi più recenti ed accreditati sottolineino la difficoltà di prevedere sul lungo periodo qualcosa di complesso e multi-fattoriale come il comportamento violento, e l’ovvia maggior facilità di farlo sul periodo breve, ossia in relazione a specifici e contingenti fattori ambientali e/o di stress.
Insomma, dagli studi americani riceviamo indicazioni che sono l’esatto contrario di quella “pericolosità presunta per sé e per gli altri” a tempo indeterminato, prevista come condizione “cronica” connaturata alla malattia, ed anche come motivo di ricovero, dalla vecchia legge manicomiale italiana n. 36 del 1904 (per di più solo sulla base d’un generico “certificato medico” e non di un’accurata valutazione clinica specialistica!): un’idea che nuove proposte di legge italiane sono tornate a riproporre.
Sappiamo già, però, che la limitatissima “valutazione tecnica” già richiesta dalla legge italiana del 1904, proveniva da una matrice eredo-costituzionalista di tipo lombrosiano, la quale faceva riferimento ad una presunta “tendenza criminale innata” dei malati di mente (una condizione, secondo le idee di Lombroso, perfettamente visibile a chiunque, oltre che sulla base del loro comportamento “scandaloso” e/o pericoloso, anche sulla base di semplici “stigmate” fisiche e fisiognomiche). Per tali ragioni e solo per esse, la legge prevedeva l’attribuzione, ai malati di mente già vagliati almeno una volta da un medico e da lui ritenuti portatori delle suddette caratteristiche fisiche e comportamentali, d’una “pericolosità presunta di lungo periodo” la quale preludeva, implicitamente, all’internamento più o meno definitivo in un Ospedale Psichiatrico. Ora, è a questo punto superfluo ribadire come tali presupposti “scientifici” siano stati del tutto superati dalla scienza contemporanea, ed anche come essi fossero assolutamente empirici, mai seriamente comprovati nonché basati, per la maggior parte, su un grossolano pregiudizio ideologico-culturale.
E’ poi interessante il fatto che, viceversa, la legislazione americana, 1) oltre a richiedere una valutazione specialistica accurata della pericolosità, 2) e richiederla come “presenza” attuale, ovvero esclusivamente sul breve periodo, 3) ha scartato ogni motivazione clinico-terapeutica al ricovero coatto (corrispondente alla cosiddetta “necessità urgente di cura” di cui parla la nostra legislazione); insomma, essa ha espunto, dalle possibili motivazioni di ricovero coatto, ogni riferimento para-lombrosiano a fattori “bio-antropologici di pericolosità” ed anche a ragioni puramente “sanitarie”, concentrandosi invece sull’aspetto pratico rappresentato, in caso di pericolosità, da una priorità assoluta accordata all’interesse sociale e collettivo su quello individuale. Insomma ha introdotto, al posto d’una pericolosità sociale cronica e/o di lungo periodo derivante da “ragioni sanitarie”, una previsione di pericolosità nel breve periodo la quale necessita solo dell’uso di indicatori di pericolosità riferiti all’individuo, più ancora che al malato mentale, “qui ed ora”, quindi tarati sulle circostanze concrete che di volta in volta si presentano.
In questa prospettiva, la “necessità di cura” (che nella legislazione italiana successiva al 1978 è divenuta una motivazione d’importanza capitale per il ricovero coatto) è stata giudicata dai giuristi americani come troppo paternalistica, perché di natura tale da violare il diritto del cittadino a rifiutare liberamente quelle cure con le quali non concordi (cfr P. S. Appelbaum ed R. M. Hamm, 1982).
Come si vede la legge italiana e quella americana, pur muovendosi apparentemente entro le stesse coordinate di tipo garantista, hanno imboccato due vie opposte:
1) la legge italiana infatti è partita dal principio lombrosiano, risalente alla legge del 1904, d’una pericolosità presunta e di lungo periodo del malato di mente, per poi abbandonare, nel 1970, ogni valutazione di pericolosità ed approdare al principio (in sé anch’esso assolutamente illiberale, tranne che nelle situazioni di igiene pubblica o di preminente interesse collettivo) della “necessità della cura” (legge 180).
2) la legge americana invece, pur prendendo teoricamente in considerazione il principio della “necessità della cura”, lo ha consapevolmente scartato in ragione, da un lato, del rispetto del diritto individuale alla libertà di cura (Appelbaum ed Hamm), e dall’altro della necessaria conciliazione dei diritti individuali con quelli inerenti la necessità di sicurezza collettiva e di prevenzione sociale.
Il principio della “libertà di cura”, insomma, per il diritto americano, ove preso in sé stesso, rappresenta un caposaldo giuridico assolutamente chiaro, sacrosanto ed inoppugnabile; tuttavia, in presenza di pericolosità sociale, la giurisprudenza statunitense afferma con altrettanta chiarezza che sul diritto individuale al rifiuto delle cure debbono prevalere le “considerazioni collettive e di pubblico interesse”.
Ora occorre osservare che, almeno in questo caso, è proprio una tale estrema chiarezza nel difendere le ragioni collettive, l’elemento che consente di salvaguardare nella maniera più netta anche il diritto individuale della persona alla libertà di cura: la legge americana, infatti, non solo circoscrive ad ambiti limitati e verificabili il diritto della persona al rifiuto delle cure, ma sancisce, in maniera altrettanto circoscritta, i casi in cui su quest’ultimo deve prevalere il principio dell’interesse collettivo, riuscendo in tal modo a contemperare (fondendoli in un mirabile equilibrio) il principio classico del diritto “soggettivo” e dell’interesse individuale, con quello, d’origine barbarico-tribale, del diritto “oggettivo” e dell’interesse collettivo e sociale.
Al contrario il mascherare, come fa la legislazione italiana, sotto le presunte finalità “umanitarie” proprie della “necessità ed improrogabilità della cura”, l’ineludibile necessità di far prevalere, almeno in taluni casi, l’interesse collettivo sulla libertà individuale a curarsi o meno, rappresenta forse la modalità più insidiosa per oscurare e mettere a repentaglio proprio il principio liberale della “libertà della cura”: infatti lo pone in balìa, senza fissare degli argini chiari, di esigenze collettive che con esso sono del tutto inconciliabili (ad esempio, quelle “sanitarie”), e che in condizioni di forte pressione dell’opinione pubblica sono fatalmente destinate a prevalere.
A controprova dell’incongruenza, su questo punto, della legge 180, basta considerare l’assoluta impossibilità, nella nostra legislazione, di sottoporre contro la sua esplicita volontà un paziente psichiatrico, a meno che non sia in stato di perdita di coscienza (e neppure se si trova in TSO!), a terapie quali, ad esempio, un intervento chirurgico d’urgenza, oppure un’alimentazione forzata in corso di anoressia (patologia per la quale di solito non si ricorre neppure al TSO!): infatti il TSO psichiatrico consente esclusivamente la somministrazione coercitiva di “terapie psichiatriche” miranti a correggere un’alterazione dello stato psichico che necessiti di intervento sanitario urgente, ed in nessun caso la somministrazione di terapie “mediche” le quali, pur anch’esse urgenti, mirino ad uno scopo diverso.
Ora, se si analizza dal punto di vista giuridico questa strana eccezione, rappresentata dalle “terapie psichiatriche”, al principio del “libero assenso alla terapia”, ci si accorge, a ben vedere, di avere ancora una volta a che fare con la priorità dell’interesse collettivo su quello individuale, ed in definitiva, con la pericolosità sociale: questa è l’unica possibile giustificazione per l’”eccezione psichiatrica”, poiché altrimenti non si capirebbe quale possa essere, nel caso delle cure psichiatriche (dalle quali può dipendere l’incolumità altrui!), quell’elemento specifico capace di inficiare una libera scelta individuale che lo stesso soggetto, nel caso debba invece decidere circa un intervento diagnostico o chirurgico su di sé (e che può incidere solo sul suo personale stato di salute), può invece esercitare!
L’elemento differenziale che riguarda le cure psichiatriche, ovviamente, non è altro che quella stessa pericolosità sociale che a parole viene esclusa, ma che surrettiziamente, fra le righe del testo, è presente nella stessa legge 180.
Insomma, l’elemento che fa la differenza fra le cure psichiatriche e quelle non psichiatriche prestate ad uno stesso soggetto che si trova in condizioni identiche (un malato di mente che non si rende conto delle conseguenze dei propri atti), non può essere altro che quello derivante, nel caso delle cure psichiatriche, da un interesse collettivo a che il soggetto “si curi la mente”, il quale s’identifica semplicemente con la sua pericolosità sociale, quindi con la possibilità che procuri del danno ad altri.
In conclusione, la nostra legislazione, in maniera abbastanza ipocrita, nel mentre che salvaguarda giustamente il diritto del paziente psichiatrico (come d’ogni altro!) a rifiutare quelle cure mediche con cui non concordi, postula poi, in modo del tutto contraddittorio, una ”necessità urgente” (ma che si pretende non sia inerente alla pericolosità!) alle cure psichiatriche, ossia ad essere curato sul piano psichico anche contro la sua volontà: si proclama insomma d’operare nel suo esclusivo “interesse”, però poi ci si rapporta con lui come se la sua “malattia” fosse contagiosa alla stregua d’una meningite (a parte le malattie mentali, solo alcune malattie infettive possono dar luogo a Trattamenti Sanitari Obbligatori!).
Con ciò, però, non ci si limita a nascondere l’idea della “pericolosità” dietro quella della “necessità ed urgenza” della cura, ma si fa una cosa ben più grave e pericolosa: in luogo di tenere rigidamente separati, in linea di principio, l’ambito dell’interesse collettivo e sociale e quello delle libertà dell’individuo al fine di mantenerli integri e di salvaguardarli entrambi (salvo il far prevalere esplicitamente, in casi circoscritti, l’uno sull’altro), si introduce di soppiatto, e senza giustificarla in alcun modo, una rischiosa e discutibile eccezione al “principio della libertà della cura” in sé, ovvero quella rappresentata, non si sa bene perché, dalla “cura psichiatrica”, con il risultato di rendere tale principio una sorta di “diritto di serie B”.
6
I problemi dell’abolizione della pericolosità e le possibili soluzioni
In conclusione, esistono più che valide ragioni per ritenere che la reintroduzione, nel nostro ordinamento giuridico, d’una valutazione psichiatrica della “presenza di pericolosità” nel malato di mente non ancora autore di reati, ove si basi non già sul concetto lombrosiano della “pericolosità sociale presunta” e “di lungo periodo” in quanto “connaturata alla malattia”, bensì sull’uso di indicatori di pericolosità sul breve periodo, nonché di più numerosi reparti per ricoveri psichiatrici coatti di breve durata come quelli attuali (gli SPDC), sia lo strumento più idoneo per prevenire due gravissimi pericoli che a nostro avviso minacciano, in prospettiva, la sopravvivenza d’una concezione liberale ed umanitaria della Psichiatria:
- un primo pericolo è rappresentato dalle risorte (ma in realtà mai tramontate del tutto!) spinte illiberali e/o contro-riformatrici, le quali vanno in direzione sia della riapertura dei Manicomi (ovvero di “luoghi di ricoveri coattivi e di lunga durata”), sia del ripristino d’una “pericolosità sociale presunta e di lungo periodo” del malato di mente in quanto tale: si vedano le già citate proposte di contro-riforma presentate nella legislatura 2001-2006.
- Un secondo pericolo è rappresentato dalla periodica riproposizione, in relazione ai malati che commettono reati e che a dire dell’opinione pubblica non hanno un’adeguata sanzione e/o trattamento/prevenzione, di proposte e spinte “radicali” di segno opposto sul piano dei principi, ma ai fini pratici del tutto equivalenti alle precedenti: queste proposte vanno infatti in direzione dell’abolizione dell’antichissimo ed umanitario principio della “non imputabilità” di minori e folli, per cui, paradossalmente, il rimedio ad una mancata valutazione preventiva della presenza di pericolosità nel malato di mente (considerata non si sa bene perché “illiberale”) sarebbe l’attendere che egli commetta dei reati ed il ripristinare a suo carico una sanzione penale ordinaria nel caso che malauguratamente li commetta!
D’altra parte, l’uso dei suddetti indicatori di pericolosità incentrati sul “breve periodo” sarebbe uno strumento utilissimo al fine di contemperare e salvaguardare alcuni importanti principi giuridici, non sempre del tutto coincidenti ma tutti quanti d’importanza capitale, in una società che voglia essere minimamente civile e giusta:
- il principio dell’uguaglianza dei cittadini, quanto ai diritti inviolabili della persona, a prescindere da loro caratteristiche biologiche e/o di salute più o meno permanenti, donde il rifiuto dell’idea d’una “pericolosità sociale presunta” che da tali permanenti caratteristiche possa automaticamente discendere, con tutte le sue conseguenze liberticide;
- il principio, conseguente al precedente, della libertà di ciascun individuo di rifiutare quelle cure, incluse le psichiatriche, con le quali non concordi, fatto però salvo il necessario prevalere sulla libertà individuale, almeno in alcuni casi circoscritti (segnatamente, l’accertata “presenza di pericolosità”), dell’interesse collettivo e sociale.
- Il principio, di antichissima e classica origine storico-giuridica, della “incapacità di intendere e di volere” del folle, e conseguentemente quello d’una sua “non imputabilità” in quei momenti nei quali sia in lui “presente” e dimostrata una qualche pericolosità.
In base a tutto ciò riteniamo, a proposito di quel certo discutibile “spirito riformatore” della Psichiatria italiana che ha sin qui preferito concentrarsi sui luoghi anziché sui problemi, che il ripetere ancora oggi ad oltranza il “mantra” secondo il quale “non c’è spazio per la cura all’interno d’una dimensione repressiva e/o custodialistica” (un “mantra” coniato all’epoca del ripudio d’ogni possibilità di lavoro terapeutico, anche provvisorio, all’interno dei Manicomi, il quale ha contribuito a produrre la frettolosità micidiale con cui sono state varate sia la legge 180 che la legge n. 9 del 2012, e che allo stato attuale sembra più che altro un luogo comune ideologico), oltre che sconfessare di fatto il lavoro terapeutico ancora oggi compiuto, ad esempio, nei SPDC (i quali ovviamente possiedono “anche” una dimensione custodialistica), sia la spia d’una mentalità difensiva, fatta di negazione dei problemi di fondo della Psichiatria, che è assolutamente necessario superare.
Occorre riconoscere che la richiesta che alla Psichiatria proviene dalla società, nel profondo è tuttora, anche e soprattutto, custodialistica e repressiva (e lo sarà, temiamo, per lunghissimo tempo!): il negare ciò come si faceva una volta, con fughe in avanti o con progetti di palingenesi sociale, oppure l’illudersi, come si fa oggi, di potere erigere dei muri più o meno invalicabili fra la dimensione terapeutica e quella repressiva e custodialistica (muri materiali, come l’abolizione “immediata”, eretta a feticcio, d’ogni possibile luogo fisico di cura a carattere anche solo parzialmente repressivo, oppure muri all’interno di sé stessi, ovvero interiori e mentali), ci sembra non sia nient’altro, per l’appunto, che un’ingenua e nefasta illusione.
Una tale illusione, infatti (è questa la cosa più grave!), non fa altro che distogliere ogni psichiatra dalla battaglia permanente che, ovunque egli operi, deve condurre in special modo all’interno di se stesso, affinché le spinte e le richieste repressive che costantemente gli provengono dal collettivo sociale (e dalle sue stesse strutture mentali più collegate con quest’ultimo), non prevalgano sulle sue motivazioni terapeutiche.
BIBLIOGRAFIA
Appelbaum P. M., “The right to refuse treatment with antipsychotic medications: retrospect and prospect”. Am J Psychiatry 145:413-419, 1988
Appelbaum P., Hamm R., “Decision to seek commitment: psychiatric decision making in a legal context”. Aech. Gen. Psychiatry 39: 447-451, 1982
Balestrieri A., “Psichiatria”, ed. “Il Pensiero Scientifico”, 1981
Basaglia, F. “Che cos’è la Psichiatria”, Baldini Castoldi Dalai, 1997
“ “L’Istituzione negata”, Baldini Castoldi Dalai, 1998
Basaglia F., Basaglia Ongaro F., “La maggioranza deviante”, ed. Einaudi, 1971
Bassi M., De Risio S., Di Giannantonio M., “La questione etica in Psichiatria”, Il Pensiero Scientifico Editore, 2000
Bini L., Bazzi T., “Trattato di Psichiatria”, Milano, 1974
Bleuler E., “Trattato di Psichiatria”, ed. Feltrinelli, 1967
Bollea G., “Compendio di psichiatria dell’età evolutiva”, Roma, 1980
Buglass R., Bowden P. “Principles and Practice of Forensic Psychiatry”. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1990.
Cacciari M., “Sulla libertà”, da “Conversazione con Cacciari” di Ennio Galzenati, “Caffè Europa”, 11 11 1999
Callieri B., “Il rinnovamento della Psichiatria italiana”, in “il Veltro”, 1962, VI
Cassano G. B., “Psichiatria medica”, UTET, 1990
Cassano G. B., Cioni P., Perugi G., Poli E. (a cura di), “Manuale di Psichiatria”, UTET, 1997
Cassano G. B. e altri, “Trattato Italiano di Psichiatria”, tre vol., ed. Masson, 1992
Cazzullo, C. L., (a cura di), “Studi di Psichiatria”, Roma, 1970
“ “Psichiatria”, tre vol., ed. Micarelli, 1993
Clarkin J. F., Lenzenweger M. F., “I disturbi di personalità – Le cinque principali teorie”, Raffaello Cortina Editore, 1996
Cocurullo B., “I moventi a delinquere”, Edizioni de “La toga”, 1930
De Ajuriaguerra J., “Manuale di Psichiatria del bambino”, Masson, 1974
De Caro M., “Libero arbitrio – Una introduzione”, ed. Laterza, 2009
De Ferrari F., Altamura A. C., “Medicina Legale in Psichiatria”, Ravizza Mediserve, 2002
De Vincentiis G., Callieri B., Castellani A., “Trattato di psicopatologia e Psichiatria forense”, Roma, 1973
Di Petta G., “Il Manicomio dimenticato”, Edizioni Universitarie Romane, 1994
Di Tullio B., “Principi di criminologia generale e clinica e Psicopatologia sociale”, ed. Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 1971
Ey H., Bernard P., Brisset C., “Manuale di Psichiatria”, UTET Masson, 1972
Ferrara M., Germano G., Archi G., “Manuale della riabilitazione in psichiatria”, Il Pensiero Scientifico Editore, 1990
Farrington DP, West DJ (1981) The Cambridge Study in Delinquent Development. In Mednick SA, Baert A.E. (eds) “Prospective Longitudinal Research: An Empirical Basis for the Primary Prevention of Psychosocial Disorders”. Oxford: Oxford University Press pp. 137–145.
Fornari U., “Trattato di Psichiatria Forense”, UTET, 1997
Freedman A. M., Kaplan H. I., Sadock B. J., “Trattato di Psichiatria”; ed. Piccin, 1984
Frighi L., “Appunti di Igiene Mentale”, ed. Rizzoli, 1973
Gaston C. L:, “Psichiatria e Igiene Mentale”, Elsevier Masson, 1997
Giberti F., Rossi R., “Manuale di Psichiatria”, Piccin, 1983
Goffman E., “Asylums – Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza”, ed. Einaudi, 1974
Gozzano M., “Compendio di Psichiatria”, Torino, 1975
Gulotta G. (a cura di), “Trattato di Psicologia Giudiziaria”, Giuffré Editore, 1987
Hafner, H. & Boker, W. (1982) “Crimes of Violence by Mentally Abnormal Offenders” (ed. F. H. Marshall). Cambridge, Cambridge University Press
Hall S. C., Lindzey G., “Teorie della personalità”, ed. Bollati Boringhieri, 1986
Harris S., “The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values”, Free Press, 2010
“ “Il paesaggio morale. Come la scienza determina i valori umani, Einaudi, 2012
Hinsie L. E., Campbell R. J., “Dizionario di Psichiatria“, ed. Astrolabio,1979
Hume C., Pullen I., “La riabilitazione dei pazienti psichiatrici”, Raffaello Cortina Editore, 1994
Janiri L., Caroppo E., Pinto M., Pozzi G., “Impulsività e compulsività. Psicopatologia emergente”, ed. Franco Angeli, 2006
Jaspers K., “Psicopatologia generale”, ed. “Il Pensiero Scientifico”, 1965
Jervis G., “Manuale critico di Psichiatria”, Milano, 1977
Jones M., “Ideologia e pratica della Psichiatria Sociale”, ed. Etas Kompass, 1970
Kant I., “Saggio sulle malattie della mente”, 1764, Ibis, Como-Pavia, 1994
Kaplan I H., Sadock B. J., “Psichiatria – Manuale del comportamento e Psichiatria clinica”, ed. Centro Scientifico Internazionale, 1997
Kendell R. E., “Il ruolo della diagnosi in Psichiatria”, ed. “Il Pensiero Scientifico”, Roma, 1977
Kernberg O., “Disturbi gravi della personalità”, ed. Bollati Boringhieri, 1987
“ “Teoria della relazione oggettuale e clinica psicoanalitica”, ed. Bollati Boringhieri, 1989
“ “Aggressività, disturbi della personalità e perversioni”, Raffaello Cortina Editore, 1992
Kline P., “La personalità – Misura e teoria”, Casa Editrice Astrolabio, 1984
Kraepelin E., “Trattato di Psichiatria”, ed. Vallardi, Milano, 1907
Kretschmer E., “Manuale teorico-pratico di psicologia medica”, Firenze, 1952
Leonhardt K., “Le psicosi endogene”, ed. Feltrinelli, 1968
Liberman R. P., “La riabilitazione psichiatrica”, Raffaello Cortina Editore, 1997
Link B, Stueve A. “Evidence bearing on mental illness as a possible cause of violent behavior”. Epidemiol Rev. 1995;17172- 180. 3
Lombroso C., “L’uomo delinquente”, Milano, Frat. Bocca, 1896, rist. Roma, Napoleone, 1971
“ “Delitto genio follia, scritti scelti” ed Bollati Boringhieri, 1995
Lorettu L., “Le reazioni emotive al paziente violento: implicazioni diagnostiche e terapeutiche”, Centro Scientifico Editore, 2000
Lusetti V., “Pericolosità del malato di mente”, Edizioni Universitarie Romane, 2013
MacLean P., “Evoluzione del cervello e comportamento umano”, ed. Einaudi, 1984
Maffei C., “Il disturbo borderline di personalità”, ed. Bollati Boringhieri, 1993
Magnarapa G., Pappa D., “Teoria e pratica dell’omicidio seriale”, Armando editore, 2003
Malmquist C. P., “Omicidio”, Centro Scientifico Editore, 1999
Maslow A. H., “Motivazione e personalità”, Armando editore, 1990Masud Khan R., “Le figure della perversione”, ed. Bollati Boringhieri, 1991
Mc Cord W., Mc Cord J., “Lo psicopatico”, ed. Astrolabio Ubaldini, 1970
Mc Glashan T. H., Keats C. J., “Schizofrenia”, Raffaello Cortina Editore, 1993
Monahan J., “The Clinical Prediction of Violent Behavior” (National Institute of Mental Health, 1981). Reprinted as “Predicting Violent Behavior: An Assessment of Clinical Techniques” (Sage Publications, 1981). Excerpts reprinted in 1 “Violent Behavior” 125-150, 259-279 (Leonard J. Hertzberg et al., eds.) (PMA Publishing, 1990).
“ “Coercion and Aggressive Community Treatment: A New Frontier in Mental Health Law (ed. with Deborah L. Dennis) (Plenum Press, 1996).
“ “Violence and Mental Disorder: Developments in Risk Assessment (ed. with Henry J. Steadman) (U. of Chicago Press, 1994).
Niceforo A., “Criminologia – vecchie e nuove dottrine”, Fratelli Rocca Editore, Milano, 1941
Nivoli C. G., “Il perito e il consulente di parte in psichiatria forense”, Centro Scientifico Editore”, 2005
Palermo G. B., Mastronardi V., “Il profilo criminologico”, Giuffrè, 2005
Pancheri P., “Manuale di Psichiatria clinica”, Bulzoni Editore, 1977
Pancheri P., Reda G., “La diagnosi di schizofrenia”, Il Pensiero Scientifico Editore, 1987
Parrini A., (a cura di), “La norma infranta – pratica e teoria di una équipe psichiatrica tra ospedale e territorio”, ”, ed. Guaraldi, 1978
Pervin L. A., John P. O., “La scienza della personalità – Teorie, ricerche, applicazioni”, Raffaello Cortina Editore, 1997
Piccione R., “Manuale di Psichiatria”, Bulzoni Editore, 1995
Porter R., “Storia sociale della follia”; Garzanti, 1991
Rabkin J., “Criminal behavior of discharged mental patients: a critical appraisal of the research”. Psychological Bulletin 1979; 86:1–27.
Realdon A., “Fondamenti di Psichiatria”, ed. Sorbona Milano, 1994
Reda F., “Trattato di Psichiatria”, USES Edizioni Scientifiche Firenze, 1982
Rippon S., “An Epistemological Argument for Moral Response-Dependence”, Jan 1 2010
Roccatagliata G., Albano C., “Trattato della malattia maniaco-depressiva”, ed. Liguori, 1997
Rossini R., “Trattato di Psichiatria”, Cappelli Editore, 1969
Rudas N., Marongiu P., Pintor G., “La pratica psichiatrico-forense”, ed. Percorsi Editoriali, 1999
Sarteschi P., Maggini C., “Psichiatria”, Goliardica Editrice, Parma, 1982
“ “Personalità e Psicopatologia”, ETS Editrice Pisa, 1990
Sartorius N., Maj M., “Schizofrenia”, CIC Edizioni internazionali, 2001
Scharfetter C., “Psicopatologia generale, un’introduzione”, Feltrinelli, 1992
Scapicchio P.,Trabucchi M. (a cura di), “Servizi psichiatrici nella sanità riformata”, Il Mulino, 1999
Scheff T. J., “Per infermità mentale – una teoria sociale della follia”, ed. Feltrinelli, 1974
Schneider K.,“Psicopatologia clinica”, ed. Fioriti, 2004
Searles H. F., “Il paziente borderline”, ed. Bollati Boringhieri, 1988
“ “Scritti sulla schizofrenia”, ed. Bollati Boringhieri, 1989
Selzer M. A., Sullivan T. B., Carsky M., Terkelsen G., “Il paziente schizofrenico”, Franco Angeli Editore, 1992
Sims A., “Introduzione alla Psicopatologia descrittiva”; Raffaello Cortina Editore, 1992
Siracusano A., Balestrieri M., Bellantuono C., Berardi D., Di Giannantonio M., Rigatelli M., Skodol A. E., “Psicopatologia e crimini violenti”, Centro scientifico Editore, 2000
Swanson J. W., Borum R., Swartz M. S., Monahan J., “Psychotic symptoms and disorders and the risk of violent behaviour in the community”, Article first published online: 10 MAR 2006, DOI: 10.1002/cbm.118
Tardiff K., “The Current State of Psychiatry in the Treatment of Violent Patients”, Arch Gen Psychiatry. 1992; 49(6):493-499. doi:10.1001/archpsyc.1992.01820060073013.
Tellenbach H., “Melancolia”, ed. “Il pensiero scientifico”, 1975
Vella G., Siracusano A., “ “Il consenso informato in Psichiatria”, Il Pensiero Scientifico Editore, 1996
West D. J., “The clinical approach to criminology”, April 1980 as the nineteenth Sir Geoffrey Vickers Lecture, under the auspices of the Mental Health Foundation.
Zilboorg G., Henry G., “Storia della Psichiatria”, Feltrinelli, 1973
Zitrin A., “Crime and violence among mental patients”, Am J Psychiatry 1976;133:142-149.
Zoccali R. A., “Manuale di Psichiatria”, Il Pensiero Scientifico Editore, 2007
 La vergogna è uno di quegli aspetti della psicologia umana che maggiormente si prestano ad essere fraintesi.
La vergogna è uno di quegli aspetti della psicologia umana che maggiormente si prestano ad essere fraintesi.