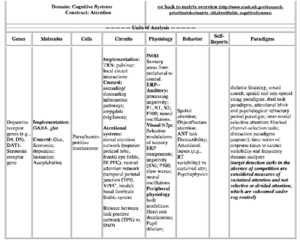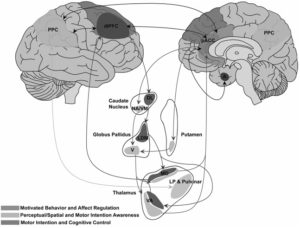di Giovanna Nicolò 25 novembre 2016
leggi in pdf il ciclo Antoine Doinel. Disavventure di una autorealizzazione

Era il 2009. Frequentavo allora il corso di Laurea triennale in Psicologia dei processi relazionali e di sviluppo, le cui lezioni si tenevano in Aula Piovani – Facoltà di Lettere e Filosofia – via Porta di Massa, 1 – Napoli. Proprio in quella stessa aula si tenne la Giornata di Studio Internazionale “La famiglia nel cinema: un oggetto della psicoanalisi applicata”, alla quale partecipai. Fu in quell’occasione che ebbi modo di assistere alla proiezione del film “I quattrocenti colpi” di François Truffaut. Ricordo che ospitammo Anna Loncan[1], il cui intervento (Bambini trascurati: potenziamento dei legami tra distruttività e creatività. A proposito de “I 400 colpi” di François Truffaut) fu per me particolarmente interessante.
All’epoca, pur rimanendo profondamente colpita sia dal film che dalla storia e dalla lettura squisitamente psicoanalitica che era stata proposta, non mi appassionai a tal punto (e me ne meraviglio ancora!) da scoprire e voler conoscere l’intero ciclo Antoine Doinel, che consta di cinque film, quattro lungometraggi ed un cortometraggio. L’anno scorso mi capitò poi di rivedere, da sola, quel film visto per la prima volta in una aula universitaria allestita a sala cinematografica, ma stavolta volli seguire la storia “fino in fondo”, o meglio sino all’ultimo film del ciclo, “L’amour en fuite”, che io definirei un amabile punto di integrazione, sotto tanti aspetti, come si vedrà. Avendo suscitato in me nuove riflessioni, connessioni e considerazioni non slegate da tematiche che mi sono care sul piano formativo-professionale.
Ma facciamo un passo indietro …
“Les Quatre Cents Coups”. Il primo lungometraggio di un giovane regista, François Truffaut, allora ventisettenne, diventò immediatamente celebre, inaugurando, nel 1959, la corrente cinematografica «La Nouvelle Vague», di cui costituisce l’emblema. La presentazione a Cannes, dove vinse la Palma d’Oro, sancì per il regista l’inizio di una carriera tutta in rapida ascesa, rappresentando per i giovani cineasti della corrente La Nouvelle Vague l’occasione di affermare, dinanzi al grande pubblico, la loro presenza a livello internazionale.
“Les Quatre Cents Coups” viene tradotto letteralmente in italiano con il titolo “i 400 colpi”, erroneamente, distorcendone il reale significato, che voleva essere inteso come il modo di dire “combinarne di tutti i colori” o anche “fare il diavolo a quattro”. Del resto, non ci si riferisce semplicemente alle stupidaggini compiute da un adolescente, ma, più profondamente, si rinvia ai “duri colpi” che Antoine, nella sua breve ma complicata storia, ha subìto e continua ad attirare a sé, in un circolo vizioso.
I 400 colpi non vuole essere né saggio pedagogico né opera leggera, ma lo specchio di una verità intima e profonda, che fa incontrare ed integra amabilmente coppie antinomiche (nomotetico/idiografico; tragedia/commedia, ecc.), in un itinerario unitario ed unico.
Un film mitico, una novità, dal punto di vista concettuale, stilistico ed espressivo, capace di meravigliare critica e pubblico. Un capolavoro che inizia una impresa unica nel suo genere: sarà il primo film di un ciclo – quattro lungometraggi, un cortometraggio, distribuiti nell’arco di vent’anni (Les 400 coups, 1959; L’ amour à vingt ans, 1962; Baisers volés, 1968; Domicile conjugal, 1970; L’ amour en fuite, 1979) – che vedrà lo stesso protagonista, interpretato dallo stesso attore (Jean-Pierre Léaud), crescere (da adolescenza a età adulta), lungo un percorso esistenziale di difficile auto-realizzazione.
L’asse narrativo è la figura in divenire di Antoine Doinel, sotto molti aspetti autobiografica, “alter ego” del regista Truffaut. In “Les 400 coups”, il dodicenne parigino Antoine è un figlio non desiderato e non amato, manipolato all’occorrenza, e lo sa: cresciuto dalla nonna durante la sua infanzia, vive ora con la madre e il padre adottivo, una coppia finta, formale, esito di un matrimonio riparatore, in una casa nella quale Antoine non ha diritto neppure a spazi fisici (dorme nell’ingresso).
Antoine esprime fame di attenzione e amore che gli adulti, autorità rigide, non sono disposti a concedergli; egli ricerca limiti e confini che possano placare, seppur provvisoriamente, i suoi bisogni di essere visto e contenuto, mediante tendenze e comportamenti antisociali in adolescenza (bugie, furti, fughe), che si traducono, in età adulta, nella reiterazione di meccanismi di difesa fallimentari (si pensi all’incapacità di Antoine di tenersi un lavoro, alla frequentazione occasionale di bordelli, alle molteplici relazioni sentimentali ed extraconiugali).
In una delle prime sequenze di Domicile Coniugale, Antoine, parlando con un ex collega del suo matrimonio con la giovane violinista Christine, afferma: «Non ho mai amato una donna in particolare. Sono amante della famiglia, padre madre …, e finalmente non sono più solo». Di Christine ama il suo essere dolce e pulita e la gentilezza della sua famiglia, elementi che gli consentono di sperimentare, almeno superficialmente, un senso di sicurezza e fiducia. Sarà proprio lei, Christine, la madre di suo figlio, che Antoine chiamerà Alphonse a dispetto del parere materno. Doinel tenderà a mentire e a tradire, continuamente, senza provare alcun senso di colpa e rimorso. Dopo un tradimento, dichiarerà a Christine: “sei la mia sorellina, sei mia figlia, sei mia madre”, la quale gli risponderà: “avrei preferito essere la tua donna”. L’ultimo film della saga vede il divorzio da Christine, ma anche l’incontro con una figura “terapeutica”, che gli consentirà di prendere consapevolezza dell’irrisolto, di ri-conoscere sua madre, oramai morta, e di lasciarsi andare ad un amore incondizionato (quello per Sabine). Direbbe Erich Fromm alla “libertà di” … sperimentare l’unità prodotta da un attivo amore che trascende l’ego, supera le modalità dell’avere e sceglie l’autenticità dell’essere.
Con queste parole il regista Truffaut racconta chi è Antoine: “Antoine Doinel procede nella vita come un orfano e cerca famiglie sostitutive. Purtroppo quando le trova tende a scappare perché rimane un individuo incline alla fuga. Doinel non si oppone apertamente alla società, e in questo non è un rivoluzionario, ma fa la sua strada ai margini della società, diffidando di essa e cercando di farsi accettare da coloro che ama e che ammira perché la sua buona volontà è totale. Antoine Doinel non è quello che si potrebbe chiamare un personaggio esemplare, ha fascino e ne abusa, mente molto, chiede più amore di quanto non ne abbia da offrire lui stesso, non è l’uomo in generale è l’uomo in particolare. Antoine Doinel ama la vita, ma soprattutto gli piace di non essere più bambino, cioè qualcuno di cui si può disporre senza chiedergli un parere, qualcuno che si può lasciare da parte, dimenticare o rifiutare con crudeltà”[2].
Antoine è un uomo “terreno”, al quanto egocentrico, in alcune circostanze sembrerebbe poco empatico o addirittura egoista. Un essere umano “tragico”, alle prese con il perenne oscillare tra voglia bramosa di vivere e senso di alienazione; al contempo, assistiamo però al dispiegarsi del suo processo di autorealizzazione. D’altronde l’umanesimo di Truffaut, ereditato da Renoir, è da ritrovarsi in ogni suo personaggio.
Il pubblico ben accoglie questo protagonista, per il quale sente di nutrire un affetto insolito: lungi dall’incarnare il prototipo dell’eroe cinematografico, la sua insicurezza e il suo brancolare nella vita, tra gioie e dolori, conquiste ed errori, fortuna e disgrazia, lo rendono un anti-eroe automaticamente simpatico, in quanto vicino alla realtà ordinaria, tessuta di circostanze ed esperienze che non fanno che confermare la precarietà e le contraddizioni di una esistenza umana, alla ricerca di una felicità ideale ed impossibile, ma testimoniano anche l’apertura, nelle mani dell’uomo, di un ventaglio di infinite potenzialità.
- Una anamnesi in celluloide
In “Les 400 coups” (- I 400 colpi) il dodicenne parigino Antoine, frutto di una relazione prematrimoniale, è un figlio non desiderato e non amato, manipolato all’occorrenza, e lo sa: affidato alla nonna materna (l’indebolimento fisico di quest’ultima deciderà l’accesso di Antoine al domicilio coniugale), vive ora con la madre e il padre adottivo, una coppia finta, formale, in una casa nella quale Antoine è tenuto in uno stato di abbandono affettivo e materiale dalla madre (basti pensare che non ha una camera da letto propria, dorme nell’ingresso, senza coperte, in un sacco a pelo).
La madre, Gilberte, donna bella e affascinante, salvata la faccia con un matrimonio riparatore, intreccia relazioni extraconiugali. Non presta attenzione ai bisogni di Antoine e non si prende cura di lui, pensa solo a se stessa; il padre adottivo, apparentemente bonario, strumentalizza il bambino per irritare o compiacere la moglie, a seconda delle circostanze, e non è certo una figura autorevole, rinfacciando e facendo pesare il fatto di aver riconosciuto un figlio non suo. Antoine, una notte, ascolterà una conversazione tra i coniugi a tal proposito, scoprendo la sua condizione di “bastardo” nato da padre ignoto attraverso gli echi ovattati ma distinti di una “scena primaria” burrascosa, provenienti dalla camera dei genitori.
A scuola Antoine manifesta la sua irrequietezza. Per questa ragione, lo scarso rendimento e gli scherzi, diventa, in diverse occasioni, il capro espiatorio di marachelle di altri. Il solo conforto alla sua solitudine è la lettura e l’amicizia con il suo compagno di scuola René, migliore (ed unico) amico, compagno di disavventure, appoggio per l’evasione. È con lui che marina la scuola per andare al cinema, nei parchi parigini e al Luna Park, alla ricerca di esperienze e attrazioni eccitanti (molto toccante la scena della giostra in cui il ragazzo sembra vivere un momento di puro divertimento). Un giorno, marinata la scuola in compagnia di René, scopre per caso la relazione adulterina della madre, incrociandola per strada e assistendo al bacio tra Gilberte e l’amante; l’indomani a scuola giustifica la sua assenza con una eclatante quanto simbolicamente carica bugia: “mia madre è morta”. Scoperta la bugia, la madre domanderà al marito: “Perché ha fatto morire me e non te?”. Accorrono a scuola la madre e il padre adottivo, il quale lo punisce dandogli un ceffone davanti a tutti i compagni di classe. Umiliato per la sua menzogna, Antoine fugge di casa e si rifugia nella stamperia dello zio di René, vagando poi di notte per le strade di Parigi. Rientrato a scuola, viene “perdonato” dalla madre, la quale, temendo che il figlio denunci la sua infedeltà coniugale, tenta di conquistarne la complicità, promettendogli una forte somma di denaro se migliora i voti in francese; così Antoine prende in prestito da Balzac uno stralcio che descrive la morte di un vecchio (riscrive una pagina letta dal romanzo La ricerca dell’assoluto) per scrivere un tema che riguarda la descrizione di “un fatto grave a cui avete assistito e che vi ha profondamente commosso” (parlerà della morte del nonno). Tornato a casa accende un cero a Balzac appiccando fuoco alle tende, ma non basta perché per quel compito il ragazzo verrà accusato di plagio dal maestro e punito.
Deluso e disperato, Antoine fugge ancora e va a vivere in casa di René. Escogita di rubare una macchina da scrivere nell’ufficio del padre, per pagare, per sé e per l’amico, una gita al mare, che non ha mai visto. Una volta realizzato il furto, i due ragazzi cercano, senza successo, di venderla a un ricettatore, Antoine viene scoperto dal custode nell’atto di restituirla. Il padre lo denuncia, punendolo senza esercitare una reale funzione paterna. Il ragazzo passa, così, una notte in cella con un delinquente e alcune prostitute. La madre, per liberarsene, acconsente con durezza, “per dargli una lezione”, a che venga rinchiuso in un riformatorio lontano da Parigi, dove la disciplina è molto rigida, tanto che Antoine viene punito fisicamente con un sonoro ceffone per aver consumato anzitempo il suo pane. Viene poi interrogato da una psicologa sulla sua vita intima e sui difficili rapporti con i genitori, rispondendo alle domande con sconcertante franchezza: è in occasione di questo colloquio che viene fatta, dal diretto interessato, una sintesi più completa della propria storia infantile, fornendo elementi che prima non erano emersi del tutto. Antoine evoca anche una conversazione burrascosa udita tra la nonna e la madre, dichiarando “Mi ha voluto far abortire” (il doppiaggio in italiano non traduce il lapsus, A. dice della madre solo che “aveva voluto abortire”).
René va a trovarlo ma, per le regole dell’istituto, non può parlargli. La madre gli comunica in modo brusco la decisione di abbandonarlo a se stesso e che il padre non avrebbe più voluto incontrarlo, colpevolizzando del rigetto paterno e, meno esplicitamente, del proprio. Durante una partita di pallone Antoine approfitta della disattenzione dei sorveglianti e fugge, in una lunga corsa sino al mare. Si spinge sino alla battigia e si volta, dopo essere entrato con le scarpe in acqua. La scena finale vede un fermo immagine, in cui viene inquadrato lo sguardo del giovane Antoine verso lo spettatore, uno sguardo di dolore, ma privo di retorica, carico di speranza e di desiderio di libertà.
Nel cortometraggio “Antoine e Colette” (- Antoine e Colette, in L’amore a vent’anni) si assiste alla prima storia sentimentale di Antoine. Antoine, giovanissimo, lavora alla Philips e vive da solo. Innamorato di Colette, una studentessa che ha incontrato ad un concerto della Gioventù musicale, Antoine, romantico e sognatore, si sforza di avvicinarsi a lei e di conoscerla, ma Colette è sfuggente; non esita a traslocare per andare ad abitare di fronte a casa sua, diventando amico dei genitori della ragazza. “E questo, appunto, spiega l’insuccesso di Antoine in “L’amore a vent’anni”: Colette non sa che farsene di un ragazzo che ha sedotto i suoi genitori!” – dichiara il regista in “Il piacere degli occhi”.
In “Baisers volés” (- Baci rubati) ritroviamo 5 anni dopo Antoine Doinel che, partito volontario per il servizio militare (per dimenticare la delusione amorosa), è stato riformato dall’esercito per instabilità di carattere. Va in un bordello, dove la freddezza di una prostituta, giovane e bella, lo spinge fuori dalla camera, ma si imbatte in un’altra donna del mestiere, più grande e più materna, che preferisce alla prima. Si reca a casa della sua vecchia amica Christine Darbon, dove i genitori della ragazza lo accolgono volentieri mentre Christine lo tratta con distacco. Il padre di Christine gli procura un lavoro come portiere di notte dell’Hotel Alsina. Antoine è entusiasta in quanto ha la possibilità di leggere indisturbato, ogni tanto va a cena dai genitori di Christine; una sera, in cantina, ruba alla ragazza un bacio.
Antoine perde il posto perché lascia entrare un investigatore privato che sorprende una coppia clandestina in una stanza dell’albergo. Proprio l’investigatore, però, lo fa assumere nella sua agenzia, la Dubly. Antoine si dedica a maldestri pedinamenti; nel frattempo frequenta Christine, ma sembra essere lui ora quello distaccato, sfuggente. Gli viene affidato il caso del Signor Tabard, facoltoso proprietario di un negozio di calzature, che lo ingaggia come finto magazziniere per portare avanti indagini sul “perché è detestato da tutti” (questo l’interrogativo posto dall’uomo all’investigatore a capo dell’agenzia), ma si innamora della idealizzata Signora Tabard. Nel frattempo Christine si reca al negozio, per avere notizie di Antoine, il quale reagisce in malo modo a quelle che percepisce come pretese improvvise della ragazza: durante questo incontro Antoine, preso dalla rabbia, dice a Christine che non la stima e che non la stimava neppure quando credeva di amarla. La Signora Tabard, capito il debole di Antoine per lei, si reca a casa del giovane e lo seduce, trascorrendo qualche ora lieta con lui. “Io non sono un’apparizione … sono una donna” – afferma Fabienne Tabard, aggiungendo che tutti siamo unici ed insostituibili e che il padre sul letto di morte disse: “la gente è eccezionale”. Antoine viene licenziato per la storia con la Tabard, in quella circostanza un infarto stronca l’investigatore che aveva fatto assumere Antoine, il quale, dopo i funerali, alla ricerca di attenzione e consolazione, finisce con una prostituta.
Viene assunto poi dalla ditta SOS che ripara tv a domicilio. Christine viene a saperlo dal padre, che fa un incidente con il furgoncino della ditta, incontrando casualmente Antoine. La ragazza, approfittando dell’assenza dei genitori per il weekend, manomette la televisione e chiama il servizio di assistenza per rivedere Antoine. Quest’ultimo, inizialmente freddo e distaccato, infastidito dai modi gentili di Christine, si scioglierà poi fra le sue braccia. Scocca la scintilla tra i due, che si fidanzano. Il film termina con la scena che vede i due passeggiare in un parco mano nella mano e con la dichiarazione d’amore eterno che uno sconosciuto (che dall’inizio del film seguiva Christine) fa alla ragazza: “Io sono definitivo … voglio che lei rompa legami provvisori” … Quello sconosciuto viene forse a rappresentare lo stesso Doinel, che dichiara la sua intenzione di iniziare una storia seria, che sia per sempre, con Christine.
In “Domicile Coniugale” (italianizzato con il titolo “Non drammatizziamo … è solo questione di corna) Antoine e Christine sono due giovani coniugi che conducono una esistenza modesta ma tranquilla, sempre supportati dai genitori di lei. Christine, concertista, dà lezioni di violino, mentre Antoine prepara colorazioni artificiali di fiori destinati ad un negozio non lontano da casa. Il vicinato è amico, durante tutto il film presente come risorsa della coppia. In una delle prime sequenze, un vecchio compagno dell’officina di riparazioni ritrova Antoine mentre sta tingendo dei fiori nel cortile, viene a sapere che è sposato con una giovane violinista e gli dice: “In fondo, ti sono sempre piaciute le ragazzine beneducate, quelle borghesi, vero?” E Antoine gli risponde: “Non ho mai amato una donna in particolare. Sono amante della famiglia, padre madre …, e finalmente non sono più solo”. In Domicile Coniugale per la prima volta Antoine si oppone apertamente, seppure in una sola occasione, al fare borghese della famiglia della moglie e alle buone maniere obbligate nei confronti delle persone influenti (la lettera al senatore che ha permesso loro di attivare tempestivamente la linea telefonica di casa), e in una discussione a tal proposito con Christine Antoine afferma che non ha tempo di annoiarsi – lui – e che non vede l’ora di invecchiare per potersi dedicare a passioni che non ha tempo di coltivare adesso.
Non del tutto soddisfatto del proprio lavoro, si mette alla ricerca di qualcosa di nuovo e, scambiato per un altro uomo, raccomandato, viene assunto in un’industria idraulica, come addetto alla guida di un modellino di nave. Christine nel frattempo, rimasta incinta, dà alla luce un maschietto, che vorrebbe chiamare Ghislain ma che Antoine registra all’anagrafe con il nome di Alphonse. In clinica, quando prende il braccio per la prima volta il figlio Antoine afferma: “È il più bel bambino del mondo anche perché è mio figlio … crescerà più forte e intelligente del padre e sarà un uomo importante, più importante di Victor Hugo. Tutte le cose che ho sognato e non ho fatto tu le realizzerai”. Antoine dimostra a suo modo vicinanza alla moglie, ma pare più concentrato su se stesso; Christine si sente poco capita, gli dice che è stanca e nervosa e preferisce, per quella notte in clinica, stare da sola.
Antoine, trascurato da Christine, si lascia sorprendere dal fascino esotico di Kyoko, la moglie di un cliente dell’industria per cui lavora, della quale diviene l’amante. La donna invia dei fiori con all’interno dei messaggi d’amore indirizzati ad Antoine, quest’ultimo li getta, ma un bambino vicino di casa va a trovare il piccolo Alphonse e porta quei fiori trovati nella spazzatura a Christine. Qualche giorno dopo i fiori si aprono lasciando cadere i messaggi e facendo scoprire alla moglie il tradimento di Antoine. Christine attacca violentemente Antoine e, dopo una parentesi di finzione in cui ricevono a casa la visita dei nonni materni, costringe Antoine a trasferirsi in un hotel. Christine gli urla: “Non è stato un tradimento ma qualcosa di più grave … mi hai tolto la fiducia, mi hai distrutto la vita, non crederò più a niente”. Antoine si arrabbia, non tenta più di giustificarsi, se ne va. Ma gli incontri con Kyoko, tipica donna geisha, perdono il fascino iniziale ed annoiano Antoine. Christine, del resto, non ha smesso di amare il marito e glielo dice apertamente. Non approva, però, il progetto di Antoine di scrivere un romanzo, che secondo Christine «non può essere un regolamento di conti». Quando Antoine la bacia dolcemente e le confida: “Sei la mia sorellina, sei mia figlia, sei mia madre”, Christine risponde: “avrei preferito essere la tua donna”. Dopo un incontro con Christine, nel quale hanno espresso affetto e tenerezza reciprocamente, Antoine va in un bordello (qui confida alla prostituta Marie: “io odio tutto quello che finisce, che ha termine, che muore”). Successivamente ricerca nuovamente la sua dolce Christine e si riappacificano.
In “L’amour en fuite” (- L’amore fugge) Antoine ha superato la trentina e lavora come correttore di bozze. È innamorato di Sabine, commessa in un negozio di dischi, e sta per divorziare da Christine, dalla quale è separato da 5 anni. Circa due anni fa Antoine ha pubblicato il suo romanzo autobiografico (Les salades de l’amour – Le insalate dell’amore). Il giorno dell’udienza per il divorzio, Antoine e Christine, che hanno optato per il divorzio consensuale, si lasciano andare ai ricordi: non c’è rabbia, non mancano invece il bene reciproco ed il rispetto. Colette (la prima cotta di Antoine in “L’amore a vent’anni”), oggi avvocato, intravede e riconosce Antoine Doinel e va ad acquistare il suo romanzo.
Antoine e Colette si rincontrano alla stazione, dove Antoine ha accompagnato il figlio Alphonse (in partenza per il mare) mentre Colette è diretta ad Aix en Provence per seguire un caso in cui è chiamata a difendere il colpevole in un caso di infanticidio, il ché le risulta difficile e penoso (durante il film emergerà che Colette ha perso sua figlia, morta investita da una automobile quando aveva appena 3 anni; quel trauma ha determinato la separazione dal marito, 5 anni fa, mentre oggi Colette è innamorata del libraio Xavier, che si scoprirà essere il fratello di Sabine). Antoine non esita a salire sul treno, pur senza biglietto, per poter incontrare Colette e parlarle, ma i due finiscono per discutere in quanto la donna dichiara una volta per tutte di non aver mai amato Antoine e di essersi anzi sentita oppressa dalla sua insistenza.
Nel frattempo Sabine, stanca delle continue assenze di Antoine, lo lascia. Sarà Antoine a ritornare da lei, con una sicurezza mai provata ed espressa prima in campo sentimentale. Un passaggio importante e determinante per questa svolta è rappresentato dall’incontro casuale tra Antoine e Lucien, “L’amante numero 1” (così lo definisce Antoine in una lettera a Sabine) della madre Gilberte, quel tale che da ragazzo Antoine aveva visto baciare la madre per strada: Antoine Doinel può in questa circostanza ri-conoscere la madre (descritta da Lucien come una donna “anarchica”, che soffriva l’ipocrisia della società, e al contempo un “pulcino” da difendere, che “voleva bene” ad Antoine) e, in un certo senso trovare quella figura reale e vera di riferimento che da tempo ricercava (Lucien ha assistito fino ai suoi ultimi giorni di vita la madre Gilberte, morta all’età di 47 anni). Con Lucien, Antoine si reca per la prima volta a trovare sua madre al cimitero di Montmartre. “Somigli a tua madre” – dice Lucien ad Antoine.
Antoine, con la benedizione di Christine e Colette, ritorna da Sabine per farle capire che è stata la prima donna che ha amato ciecamente e ha voluto conquistare davvero sin dall’inizio: le confida di essersi innamorato di lei trovando una sua foto strappata, e di essersi messo alla ricerca, fino a trovarla (il primo incontro proprio al negozio di dischi) e a “farla innamorare”. Antoine dice: “Ho finto di non provare nulla … ma il cuore mi batteva a cento all’ora …” e aggiunge: “La vita mi ha abituato a nascondere le emozioni, a non dire le cose in faccia”, Sabine allora afferma: “Perché non hai fiducia negli altri” e Antoine: “ma in te sì”. Si riconciliano con un bacio e con la passione che aveva fatto da apertura al film. Il loro affermare “Poi si vedrà” diventa un motto beneaugurante ed un inno all’età adulta, alla vita in tutte le sue sfumature e alla sua continuità.
- Esperienze e relazioni familiari, affettive e sociali
Il materno. Antoine incarna probabilmente per Gilberte l’abbandono subìto dall’amante dell’epoca. Lo stile materno di attaccamento è distanziante, il rapporto che la lega al figlio è intriso di autoritarismo: lo rimprovera in maniera assillante e lo tratta da domestico più che da membro della famiglia, designandolo come “il ragazzo”. Quando si sfila le calze davanti a lui non tenta di sedurlo quanto di ignorarlo, non guardando alla sua sensibilità di adolescente. Quando Antoine scopre la sua infedeltà coniugale, Gilberte mostra una “preoccupazione materna primaria” fittizia e manipolatoria: nella scena del bagno, al ritorno dalla prima fuga notturna, la donna lava e asciuga Antoine, recitando il ruolo di una madre amorevole per comprare il suo silenzio, ma non è affatto convincente agli occhi del ragazzo, evidentemente imbarazzato per tanta regressiva ed inconsueta intimità. Antoine non si ribella mai apertamente alla madre, anzi adotta spesso un atteggiamento complice (quando il padre si rende conto che dorme senza coperte, sebbene abbia dato alla madre soldi per comprarne, Antoine va in soccorso della madre, affermando che gli va bene così, dormire nel sacco a pelo), ma la sua passività e la sua indifferenza dinanzi a negligenze ed aggressioni sono solo difensive, apparenti: il suo inconscio tiene in fresco l’odio per la madre con una rimozione possente, basti pensare alla scusa di Antoine, che si giustifica a scuola per la sua assenza rivelando al maestro che “la madre è morta”, esprimendo così in maniera forte ed eclatante i suoi sentimenti ostili, la sua rabbia, il suo rancore per il rifiuto materno. Scoperta la bugia, la madre domanderà al marito: “Perché ha fatto morire me e non te?”. E lui risponderà: “la mamma innanzitutto, no?”.
Una madre distante e inaccessibile. Toccante la scena in cui Antoine prende il posto della madre davanti allo specchio della toilette, tocca i suoi oggetti intimi e si passa la sua spazzola tra i capelli: potrebbe sembrare il bisogno di un contatto, ma condensa in sé anche la ricerca di verità, di risposte a domande che nutrono le esitazioni identitarie dell’adolescente: Chi è mia madre? Cos’è una donna? Ed io chi sono? In cosa somiglio a mia madre? In un film successivo, Baci rubati, Antoine giovane adulto, di fronte allo specchio si troverà a rivivere un momento simile: guarda la sua immagine ripetendo ad alta voce il nome di Fabienne (la donna sposata, ricca e “superiore”), quello di Christine (la dolce e pura ragazza della porta accanto) e, infine, il proprio: pronunciare, in modo ecoico e differenziato, il nome delle due donne che egli crede di amare e poi il proprio rappresenta un tentativo di far chiarezza in se stesso.
La scena della visita in riformatorio, in cui Gilberte colpevolizza il figlio e lo abbandona definitivamente, è l’ultima volta in cui Antoine vedrà sua madre. Sarà l’incontro speciale con il compagno di vita della donna, oramai morta, a portare l’adulto Antoine a perdonarla e a porgerle un saluto al cimitero.
Il paterno. “Where is the father?” è la domanda del professore di inglese. Il padre di Antoine strumentalizza il bambino per irritare o compiacere la moglie, a seconda delle circostanze, e non è certo una figura autorevole, ponendosi come benefattore che attende riconoscenza e punendo Antoine con la violenza e il tradimento pubblicamente inflitti (gli schiaffi che gli dà a scuola, dinanzi ai compagni e al maestro, per aver detto una bugia, corrispondente ad una verità inconscia – la morte della madre, e la denuncia per il furto della macchina da scrivere nell’ufficio paterno, il cui bersaglio inconscio era del resto proprio il narcisismo del genitore affettivamente indifferente). Quest’uomo non ha mai veramente riconosciuto Antoine come suo figlio, e non si sa nulla sulla sua stessa famiglia (non si allude minimamente ai nonni paterni).
La coppia genitoriale. Il legame di coppia si basa su un vero e proprio contratto che ha consentito a Gilberte di riconquistare la propria rispettabilità e a suo marito di “acquisire” una giovane e bella moglie. L’unica cosa che condividono è la mancanza di considerazione reciproca, rinforzata dall’aggressività della moglie e dal cinismo del marito.
Interazioni patologiche fra genitori e adolescente. Ladame (1978)[3] scrive: “Quello che abbiamo potuto osservare in forma ripetitiva nelle famiglie dei nostri adolescenti “con disturbi” è l’estrema importanza dell’identificazione proiettiva e la sua utilizzazione da parte dei genitori degli adolescenti. Fintantoché questo meccanismo resta all’opera in modo preponderante, e che i bisogni difensivi dei genitori sono particolarmente intensi, le possibilità, per l’adolescente, di una vera e propria separazione-individuazione sono bloccate”. Queste identificazioni proiettive, che rendono confusi i confini del Sé dell’adolescente, rinforzano, in associazione con altri meccanismi di difesa arcaici, le credenze che alimentano il romanzo familiare. Un aspetto che ritroviamo nella storia di Antoine.
La parte degli avi. Dell’ambiente primario e dell’attaccamento primario di Antoine sappiamo ben poco, se non che la nonna materna ha salvato il nipote, impedendo alla figlia di abortire e si è occupata di lui sino a che ha potuto. Antoine è consapevole di questo, il rapporto con la nonna è fatto di tenerezza e amore nonostante il furto di cui il ragazzo si rende colpevole ai suoi occhi (“ero certo che non se ne accorgeva … e la prova è che non se n’è accorta” – con queste parole l’adolescente ci dice che non credeva di farle del male, o perlomeno che non era quella la sua intenzione). Nel tema scolastico prenderà poi a prestito anche un eroe balzacchiano per inventare e raccontare la morte del nonno, personaggio che in un certo senso sembrerebbe incarnare il rappresentante della stirpe sconosciuta e l’interdetto che pesa sulle sue origini.
L’amicizia libera. René, compagno di banco e di sventure, unico amico di Antoine, non è mai triste, almeno apparentemente; nonostante sia l’istigatore delle stupidaggini e dei comportamenti antisociali che mettono in atto, è portatore di una vitalità sana. A differenza di René, Antoine è più riservato, introverso, ma i due amici hanno molto in comune: sono entrambi figli unici, trascurati dai genitori, abbandonati a se stessi, adolescenti soli e solitari, che insieme alimentano la capacità di resistere alle avversità e il piacere della ricerca della libertà.
Christine, moglie e madre. “Non ho mai amato una donna in particolare. Sono amante della famiglia, padre madre …, e finalmente non sono più solo”, racconta Antoine a proposito del suo matrimonio con Christine. Quest’ultima, con il suo essere dolce e rassicurante, è l’opposto di Gilberte, la madre di Antoine: è stata da lui scelta per il suo poter essere una brava moglie e madre. Gli darà un figlio, Alphonse. Antoine e Christine si separeranno poco dopo.
I rapporti sentimentali ed extraconiugali in cui prevale la componente del desiderio sessuale testimoniano l’accesso difettoso di Antoine all’ambivalenza. In questi incontri provvisori Antoine sente di potersi abbandonare completamente (ad esempio con la signora Fabienne). Christine, in quanto proiezione dell’oggetto buono, che Antoine ha designato come “definitivo”, perché sicuro, viene protetto dalla fusionalità e dall’aggressività che Antoine ha bisogno di esperire ed esprimere e che potrebbero, secondo lui, mettere in pericolo quel legame di attaccamento. Dopo un tradimento, in un incontro ambiguo e contraddittorio, in cui sembra volersi riavvicinare alla moglie, Antoine le dice: “Sei la mia sorellina, sei mia figlia, sei mia madre”, Christine risponde: “avrei preferito essere la tua donna”.
Paternità. In clinica, quando prende il braccio per la prima volta il figlio Antoine afferma: “È il più bel bambino del mondo anche perché è mio figlio … crescerà più forte e intelligente del padre e sarà un uomo importante, più importante di Victor Hugo. Tutte le cose che ho sognato e non ho fatto tu le realizzerai”. Lo chiamerà Alphonse, a dispetto del parere di Christine, che avrebbe voluto dargli un altro nome. Si tratta di una paternità narcisistica, in cui si fatica a riconoscere il figlio come altro da sé; del resto Antoine non ha avuto un padre. Dimostra una vicinanza quasi imbarazzata alla moglie, focalizzandosi sulla propria difficoltà nel provare e gestire emozioni nuove e tanto intense. Si sentirà anche trascurato da Christine, neomamma alle prese con il piccolo Alphonse. Dopo il divorzio da Christine, il figlio vivrà con la madre, pur continuando Antoine, forse meglio di prima, ad essere per lui un padre presente (seppur distratto).
Il vero amore, Sabine. Con lei Antoine vive l’amore maturo, incondizionato, trovato più che scelto, indipendentemente da fattori terzi. È vero amore in quanto contempla e integra buono e cattivo, bene e male, dando la possibilità a ciascuno di essere se stesso e di condividere con l’altro una vita autentica.
Il terapeutico Lucien. “L’amante numero 1” (così lo definisce Antoine in una lettera a Sabine) della madre Gilberte: l’incontro con lui rappresenta per Antoine Doinel l’occasione di ri-conoscere la madre, descritta da Lucien come una donna “anarchica” e dolce, che amava suo figlio, e, in un certo senso, di trovare in questo signore, più o meno sconosciuto, tanto “normale”, una figura integrata, che incarna l’uomo capace di quell’amore libero ed incondizionato che può durare in eterno, o perlomeno una vita intera (Lucien ha assistito fino ai suoi ultimi giorni di vita la madre Gilberte).
Sfera sociale e lavorativa. La storia che i film raccontano vede il ragazzino scontroso e provocatorio lasciare il posto ad un giovane senza famiglia che, congedato dal militare, ben si adatta alla società: lavora e vive da solo, ha pochi (ma buoni) amici e sentimentalmente è alle prese con sperimentazioni se vogliamo “tipiche” della sua età, per quanto condizionate nel profondo da un modello di attaccamento insicuro. Quest’ultimo è alla base di quella insoddisfazione di fondo (tesa alla ricerca incessante del pezzo mancante!) che inciderà anche sulle scelte sentimentali future (matrimonio, rapporti e relazioni extraconiugali), e non meno in ambito lavorativo, con il continuo abbandono del vecchio lavoro in favore di uno nuovo.
Risorse
Va pur detto che il temperamento di Antoine, la sua brama di vita e la sua determinazione a riscattarsi costituiscono elementi che mettono il soggetto sulla retta via. È sorprendente come Antoine serbi in sé, nonostante le deprivazioni dell’infanzia, valori positivi di famiglia (le cui radici possono forse essere identificate nel legame di attaccamento con la nonna materna): lo vediamo prima alla ricerca di una famiglia sostitutiva (è determinante nel primo innamoramento e nella scelta di Christine come moglie), poi costruire una propria famigliola come tante altre (madre-padre-figlio), una normalità di cui non ha mai potuto fare esperienza in qualità di figlio.
La gioia di vivere che Antoine esprime in età adulta attesta la presenza di un’altra risorsa fondamentale nel suo faticato processo di auto-realizzazione, la speranza. Quest’ultima nutre l’apertura mentale e sociale di Antoine, alimentando esperienze e relazioni buone, salvifiche. Lo spettatore si meraviglierà, guardando gli ultimi film, delle interazioni e dei buoni rapporti di Antoine con vicinato, colleghi, amici: se ci fossimo fermati al primo film, Les 400 coups, non avremmo scommesso su queste competenze sociali.
- La personalità in divenire di Antoine
L’Antoine che incontriamo per la prima volta è un dodicenne irrequieto. L’adolescenza, è risaputo, è una fase, estremamente delicata, di rinnovamento e cambiamento, portatrice di per sé di conflitti e problematiche. Se poi sei un ragazzo ‘difficile’ con un vissuto ‘difficile’ le cose si complicano ulteriormente. In “Les 400 coups”, con piccoli tocchi, lo svolgersi del film fornisce elementi della sua storia infantile, segnata da attaccamento e relazioni primarie claudicanti, la cui sintesi viene fatta, dallo stesso protagonista, durante il colloquio con la psicologa del centro di detenzione per minori.
L’Antoine che veniamo a conoscere in questo periodo della sua vita è apparentemente ‘mansueto’, obbediente e passivo in famiglia, ma ribelle e provocatorio fuori, dove rivendica attenzione, affetto, ma soprattutto identità e libertà. Frutto di una relazione prematrimoniale, è stato “riconosciuto”, formalmente, dal marito della madre, mentre per quest’ultima è solo “il ragazzo” (così lo chiama), figlio di padre ignoto, “colpevole” a sua insaputa e indegno persino di un nome proprio e di un proprio spazio vitale, tant’é che dorme nell’ingresso in un sacco a pelo. È un figlio non desiderato e non amato, manipolato all’occorrenza, e lo sa.
L’esame di realtà è conservato e le funzioni psichiche sono nel complesso buone, ma l’affettività di Antoine pare essere coartata, è ciò incide sulla sua impulsività: le sue azioni prevalgono sulla riflessione.
Alberga in lui un vissuto di abbandono e di ingiustizia che gli permette di non tenere conto della colpa e di nutrire il desiderio di vendetta. Pensiamo a quando il maestro lo priva della ricreazione dopo averlo sorpreso a far passare tra i banchi una rivista con in copertina una foto eccitante e Antoine scrive, in risposta, un poema sul muro della classe: “qui fu punito il povero Antoine Doinel per una pin up caduta dal cielo ma non è giusto e avrà la sua vendetta”; e alle spropositate minacce di Antoine (ben oltre la legge del taglione che esigerebbe un castigo commisurato al torto causato!) al compagno di classe, che ha fatto scoprire le sue iscrizioni murali (“carogna, traditore, hai i giorni contati, Morrissette!”).
Nei vagabondaggi con René, Antoine ricerca esperienze eccitanti (la scena del Luna Park). Egli condivide con l’amico la passione per il cinema, dove, marinata la scuola, vanno spesso, ma si rifugia anche nella lettura, essendo più riservato ed introverso di René.
Al quanto egocentrico, a volte sembrerebbe addirittura egoista, Antoine adulto è riservato, ed ha ancora qualche difficoltà ad esprimere e gestire le emozioni e a provare empatia; conserverà per molto tempo la tendenza a mentire e tradire. D’altra parte, però, controlla maggiormente la propria impulsività e mostra una maggiore tolleranza alla frustrazione. Il funzionamento globale della sua personalità può dirsi buono. Intelligente, brillante, a volte un po’ ingenuo ma comunque piuttosto realistico, Antoine è un treno in corsa, iperattivo e testardo; se la cava in tutte le occasioni, mostrando buone capacità di problem solving. Gioioso e ironico, apprezza l’ilarità e i momenti di svago e aggregazione (si pensi alla comicità dei momenti di scherzo con Christine o Sabine e delle interazioni con vicini e colleghi).
Insomma, Antoine appare ben adattato, non è radicalmente anticonformista e non disdegna i rapporti e le situazioni sociali, per quanto arrivi ad esprimere il sentirsi come “un pesce fuor d’acqua” rispetto alla borghesia di cui è entrato a far parte (attraverso il matrimonio con Christine), società alla quale muove per la prima volta un’aperta critica in Domicile coniugale, penultimo film del ciclo. Preferisce pur sempre i ritagli di intimità domestica in cui si dedica alle proprie passioni, lettura e scrittura.
Aspetti psicopatologici
In un contesto familiare e sociale che sovverte logiche, relazioni, ruoli e regole, destinatario di messaggi ambigui e anaffettivi, Antoine rivendica attenzione, ricerca disperatamente amore, uno sguardo che lo com-prenda, ma forse ancor di più va a caccia di senso e verità, che gli adulti non sono capaci e disposti a concedergli, mostrando essi una formalità rigida e coatta, che innalza un muro di indifferenza e insensibilità.
Come già detto, fintantoché prevalgono i bisogni difensivi dei genitori (della madre nella fattispecie), ed è preponderante la loro utilizzazione di identificazioni proiettive, le possibilità, per l’adolescente, di una vera e propria separazione-individuazione sono bloccate. Queste identificazioni, che rendono confusi i confini del Sé dell’adolescente, si associano ad altri meccanismi di difesa arcaici, scissione e idealizzazione, con il rischio – rispettivamente – di una patologia borderline dominata dal manicheismo buono-cattivo e di una patologia narcisistica dominata da un Sé grandioso. In famiglie tanto fragili l’adolescente può considerare necessaria, per la risoluzione della crisi genitoriale, l’espulsione, “modalità di transazione patologica” che si può manifestare attraverso tentativi di suicidio, fuga o viaggio patologico (Marcelli, Braconnier, 1983).
Bugie, furti e fuga impulsiva sono tentativi di ribellarsi all’indifferenza e affermare se stesso, placando, seppur provvisoriamente, i suoi bisogni di essere visto e contenuto.
Ciò che gli è assolutamente necessario è liberarsi dai legami deleteri, rispetto ai quali è rassegnato e indignato, primo fra tutti dal legame, che dovrebbe essere sacro, primario e vitale, con la madre. Gli è necessario trovare limiti e confini che gli consentano di identificarsi come soggetto intero, in relazione con soggetti interi, capaci di guardare, ascoltare e contenere anche il suo lato oscuro fatto di sentimenti ostili. Confini e limiti che gli diano possibilità di essere, di costruire un percorso libero definibile e narrabile, laddove le sue origini sono “marchiate” dall’ irriconoscibile ed indicibile.
L’agito, mettere in atto tendenze antisociali, costituisce per lui l’unica difesa, in questo caso egosintonica e adattiva, rappresentando la sola possibilità di salvaguardare sopravvivenza e affermazione di sé; al contempo le sue provocazioni sembrano voler comunicare ai genitori, agli adulti insensibili, al mondo intero, che non ha bisogno della loro sufficienza, della loro assenza presente (o finta presenza), che può fare a meno di loro, preferendo addirittura la “galera”.
Con l’amico di sventure René, l’adolescente Antoine ricerca esperienze attraverso cui sperimentare eccitazione, che confonde con quel senso di vitalità mai provato. Molto toccante la scena del Luna Park, nella giostra in cui il ragazzo vive un momento di pura adrenalina e ha la faccia di colui che è “senza pensieri”.
Antoine adulto, nei momenti più emozionanti, difficili o tristi, è ancora spinto a rispondere ad un bisogno impellente di scarica dell’eccitamento ingestibile, basti pensare, ad esempio, alla sua frequentazione di prostitute in due circostanze: congedato dal militare e dopo il funerale del collega investigatore privato.
L’accesso parziale all’ambivalenza genera in lui una doppia tendenza, da un lato a preservare quanto ha assunto come rassicurante “base sicura” (ideale assoluto da non contaminare!), dall’altro a ricercare in un altrove, nuovo e provvisorio, ciò che gli manca. Questa spinta condiziona profondamente tanto la vita sentimentale quanto quella lavorativa di Antoine, costellate da alti e bassi.
Il cinema in età adulta viene superato di gran lunga dalla passione per la lettura, che gli consente anche di attuare un meccanismo di intellettualizzazione, volto a mantenere lontani dalla coscienza pensieri, immagini ed emozioni potenzialmente pericolosi. In tale direzione si può spiegare la sua dichiarata avversione per la “noia”: il suo voler riempire le giornate di “fare”, il suo non fermarsi mai, sembra essere una strategia per non pensare troppo.
Attaccamento insicuro
Alla ricerca di una figura di riferimento, Antoine adolescente trova il suo personale dio (costruisce persino una sorta di altarino con tanto di santino!), maestro che in un certo senso lo accompagnerà per la vita, in Balzac, il quale in “Le père Goriot” scrive: «La società, il mondo vertono sulla paternità, tutto crolla se i figli non amano i padri».
Le dinamiche della vita affettiva di Doinel, ancor prima che essere riferite all’assenza del padre e di una figura paterna, possono essere messe in relazione con lo stile materno di attaccamento, distanziante, che ha reso inaccessibile ad Antoine il mondo affettivo della madre, impedendogli di imparare a ri-conoscere e “digerire” le emozioni, proprie e altrui.
Rivendicando la sicurezza di cui è stato deprivato (ricordiamoci che deve la vita alla nonna materna, la quale ha rifiutato alla figlia il permesso di abortire e che ha avuto amorevolmente cura di lui finché ha potuto), Antoine difende come può la sua integrità precaria e l’amore di cui è capace, seppure con modalità inappropriate e disfunzionali: se in adolescenza ne sono espressione tendenze e comportamenti antisociali, nell’età adulta di Antoine troviamo ad esempio, costanti ed esemplificative, l’irresponsabilità nell’abbandonare sempre il lavoro vecchio per uno nuovo, la promiscuità sessuale (la frequentazione di prostitute), la tendenza a mentire e tradire (relazioni extraconiugali).
Queste modalità, che rimandano ad uno stile di attaccamento tipo A insicuro-evitante (Ainsworth et al., 1978), sono accomunate dallo schema di attaccamento dell’“evitamento angoscioso” (Bowlby, 1989)., in cui “l’individuo non possiede la fiducia che, quando ricercherà delle cure, gli si risponderà soccorrevolmente, ma, al contrario, si aspetta si essere rifiutato seccamente. Quando un tale individuo tenta, in grado marcato, di vivere la propria vita emotiva senza l’amore e il sostegno degli altri, egli cerca di divenire autosufficiente sul piano emotivo e può venire in seguito diagnosticato come narcisista o come persona con un falso sé, del tipo descritto da Winnicott (1960). Questo schema, in cui il conflitto è più nascosto, è il risultato di una madre che respingeva recisamente e costantemente il figlio” (Bowlby, 1989, p. 120).
Potremmo affermare che un tale modello di attaccamento insicuro, attraverso il consolidarsi di modelli operativi interni, può segnare l’orientamento caratteriale del soggetto in senso improduttivo (Fromm, 1947), ostacolando l’autentica espressione e realizzazione di sé. Ma va tenuto conto del fatto che l’esito psicopatologico non è l’unico possibile, così come non sono da escludere successive modificazioni e trasformazioni dei modelli disfunzionali. Più recenti studi sull’attaccamento, evidenziando aspetti quali la bidirezionalità e transgenerazionalità, sembrano porre il focus dell’attenzione su una dimensione interpersonale nella quale può giocarsi un “potenziale continuo di cambiamento” (Bowlby, 1989, p. 131), che Antoine saprà cogliere e dispiegare.
Orientamento produttivo
Nell’ultimo film del ciclo, L’amour en fuite, il cambiamento di Antoine, iniziato già nel precedente, Domicile coniugale, mostra anche la possibilità di una trasformazione caratteriale, laddove intervengano fattori (principalmente interpersonali) che favoriscono una presa di coscienza e un comportamento proattivo.
Il cambiamento di Antoine trova spinte forti sia nei nuovi legami di attaccamento (in primo luogo quello con la rassicurante, sicura, Christine, per lui “sorellina, figlia e madre”) sia nelle esperienze che contrassegnano l’età adulta di Antoine (come quella della paternità). Ma momento cruciale sarà l’incontro con Lucien, amante della madre, oramai morta, il quale fungerà da figura terapeutica, consentendogli di ri-conoscere e riscrivere la sua storia. Potrà allora essere e amare in modo autentico, nell’hic et nunc, sentire e relazionarsi in modo autentico, rispetto a se stesso e agli altri. La relazione con Sabine nasce e si sviluppa come risorsa fondamentale, spazio fecondo del cambiamento in atto, in quanto imperniata su un amore incondizionato, che implica il riconoscimento dei reciproci limiti e la condivisione di un progetto comune in cui le potenzialità di ciascuno trovano espressione e il coraggio di realizzarsi.
- Bisogni di attaccamento, vita affettiva e realizzazione di sé
Attachment Theory e Psicoanalisi Umanistica Frommiana
Intendo proporre, in questa sede, una ipotesi di raffronto che coinvolge ed integra la teoria dell’attaccamento di Bowlby e la psicoanalisi umanistica di Fromm.
Secondo me il punto essenziale di congiunzione, che mi accingo ad approfondire, risiede nei concetti di amore e sicurezza affettiva, di cambiamento e di autenticità che, seppur in maniera diversa, sono stati elaborati dai contributi a cui si fa riferimento.
Il contributo di John Bowlby è fondamentalmente legato alla nozione di attaccamento, approfondita nei tre volumi di Attaccamento e perdita (1969, 1970, 1980). Per Bowlby come per Freud la psicoanalisi ha profonde radici nella teoria di Darwin, ma quello di Bowlby è un darwinismo del XX secolo: per l’autore l’attaccamento è istintivo e primario, indipendente dalla mera soddisfazione dei bisogni fisici, il bambino è individuo attivo e biologicamente preadattato, che ricerca la maggiore prossimità alla madre mediante schemi di comportamento propri della specie volti allo stabilirsi di un “legame affettivo intimo e costante” tra madre e bambino; il sistema di attaccamento ha l’obiettivo esterno di garantire la vicinanza con il caregiver (per assolvere la funzione biologica che B. individua nella “protezione dai predatori”) e quello interno di motivare il bambino alla ricerca di una sicurezza interna. Due sono quindi le ipotesi centrali, ampiamente convalidate dalle ricerche empiriche, nella costruzione teorica di Bowlby: 1) lo stile di attaccamento che il bambino sviluppa dipende strettamente dalla “qualità” delle cure materne ricevute; 2) lo stile dei primi rapporti di attaccamento influenza in misura considerevole l’organizzazione precoce della personalità e soprattutto il concetto che il bambino avrà di sé e degli altri, quindi le future relazioni. Bowlby considera il comportamento di attaccamento come “caratteristico della natura umana in tutto il corso della vita – dalla culla alla bara”, e parla di un “potenziale continuo di cambiamento” (1989).
Nel concetto frommiano di situazione umana “possiamo vedere un intreccio di esistenzialismo e di evoluzionismo, anche se solo il secondo è dichiarato. Le posizioni evoluzionistiche diventano più esplicite nel corso delle opere di Fromm, anche con riferimenti a Bowlby” (Biancoli, 2000). Fromm, rivedendo la teoria freudiana della sessualità, sostiene che, pur esistendo una sessualità infantile, l’attaccamento del bambino alla madre non è di natura essenzialmente sessuale, piuttosto la dipendenza dalla figura materna esprime principalmente il desiderio di protezione e sicurezza, l’aspirazione ad una situazione paradisiaca di soddisfacimento e amore (Biancoli, 1986). L’autore, pur essendosi tanto occupato della società e della sua influenza sull’individuo, accentua, rispetto a Freud, l’importanza del dato costituzionale, il ché gli consente di dare un più solido fondamento teorico alla possibilità di trasformazioni caratteriali: Fromm sostiene che nella personalità entri la natura col temperamento e la società col carattere, quest’ultimo, pertanto, “può fare perno sul lato naturale delle potenzialità e assumere un orientamento diverso, relativo a un altro ambiente o anche, come dovrebbe accadere con una esperienza terapeutica, più autonomo da ogni ambiente, se la produttività che è propria della natura umana si libera e si esprime” (ibidem, p. 21).
Tutto ciò rinvia al concetto di “persistente potenziale di cambiamento” e al “modello dei percorsi di sviluppo” di Bowlby (1989): “Quei bambini che hanno dei genitori insensibili, lenti a rispondere, tendenti a trascurarli, o che li respingono, si svilupperanno con ogni probabilità seguendo un percorso deviante che è in certo grado incompatibile con la buona salute mentale e che li rende vulnerabili a un crollo, qualora si imbattessero in esperienze gravemente negative. Anche in tal caso, dato che il corso dello sviluppo successivo non è fissato, cambiamenti nel modo in cui un bambino viene trattato possono far deviare il suo percorso in una direzione più favorevole o in una più sfavorevole (…) in nessuna età della vita una persona è invulnerabile di fronte alle possibili avversità e anche (…) impermeabile a un’influenza favorevole” (ibidem, p. 131).
Difatti, pur essendo stato dimostrato come l’attaccamento insicuro sia associato significativamente a successivi problemi comportamentali, a problemi nel controllo degli impulsi, a scarsa autostima, a scarsa regolazione emozionale e a difficili relazioni con i pari (Sroufe, 1983; Turner, 1991; Zimmermann, Grossmann, 1994) , i modelli insicuri (evitante e ambivalente) non costituiscono di per sé un indice di patologia, rappresentando in alcuni casi strategie adattive impiegate in relazione a caratteristiche dell’accudimento non ottimali.
Lo stile di attaccamento insicuro-evitante viene comunque a configurare, in ogni caso, anche se in misura e qualità differenti, una situazione umana di inautenticità, determinata in primo luogo dalla messa in atto di un processo di esclusione difensiva dei propri bisogni affettivi e di protezione, che impedisce lo sviluppo di una adeguata consapevolezza ed intelligenza emotiva: “Quando un tale individuo tenta, in grado marcato, di vivere la propria vita emotiva senza l’amore e il sostegno degli altri, egli cerca di divenire autosufficiente sul piano emotivo e può venire in seguito diagnosticato come narcisista o come persona con un falso sé, del tipo descritto da Winnicott (1960)”, scrive Bowlby (1989).
Ciò richiama il concetto di “alienazione” elaborato in Escape from freedom (1941) da Fromm, il quale descrive il falso sé come struttura di carattere improduttiva (Bacciagaluppi, 2000), risultante da rapporti alienati che soffocano la coscienza umanistica, cioè “la voce del nostro vero Sé che ci richiama a noi stessi” (ibidem).
- Una lettura interpersonale umanistica
La “fuga dalla libertà” del vero Sé
Secondo Fromm l’uomo moderno è alienato, estraniato da se stesso, in fuga dalla parte più autentica di sé. C’è infatti una bella differenza tra “libertà da” e “libertà di”: sono tanti coloro che si autodefiniscono liberi, ma in realtà non sono poi così tanti gli uomini che lo sono davvero, che scelgono la libertà di essere umani.
Sotto la pressione di una evoluzione culturale distorta la specie umana fugge dalla propria natura, fatta di infinite potenzialità, preferendo l’immagine ipertrofica di un falso sé che fa da altarino ad una nicchia di isolamento e impotenza. Non a caso Fromm parla, riferendosi ad autoritarismo, distruttività e conformismo da automi, di meccanismi “di fuga”, intesi come modi in cui i caratteri non produttivi si rapportano socialmente.
La fuga impulsiva, lo abbiamo visto, è la tendenza difensiva privilegiata da Antoine. Memorabile la scena finale di Les 400 coups, in cui l’adolescente corre verso il mare, si spinge sino alla battigia e si volta, dopo essere entrato con le scarpe in acqua: lo sguardo di Doinel verso lo spettatore è uno sguardo di dolore, ma privo di retorica, carico di speranza e di desiderio di libertà. Mi viene in mente a tal proposito anche un’altra scena dello stesso film, quella del Luna Park, nella quale appare evidente come il ragazzo ricerchi nelle esperienze eccitanti un senso di vitalità che non ha mai provato. E l’impulsività, come scarica dell’eccitamento, diviene per lui il modo per aggirare il riconoscimento e l’elaborazione delle emozioni.
Seguendo la storia attraverso i film, e quindi lo sviluppo del personaggio, possiamo però osservare il passaggio di Antoine dalla ribellione provocatoria e liberatoria dell’adolescenza ad un rassicurante conformismo, difensivo, che gradualmente si sgretola. Esso lascia posto ad una presa di coscienza e ad una scelta attiva che rendono possibili il cambiamento.
Ciò è stato possibile in quanto il temperamento di Antoine, la sua parte “naturale”, incontaminata nella sua essenza, ha incontrato relazioni buone nell’ambito delle quali fare esperienze correttive e trasformative. I valori e la gioia di vivere che Antoine esprime, nonostante tutto, in età adulta attestano la presenza di una risorsa fondamentale che egli riesce gradualmente e faticosamente ad attivare, la speranza. Secondo Fromm “Alberga nel carattere produttivo un’attiva speranza, che non si aliena nell’attesa del tempo futuro e non forza il presente ma lo vive come stato di gestazione” (Biancoli, 1986).
In Antoine, il passaggio dalla lettura alla scrittura autobiografica è emblematico, dando espressione a quel produttivo atteggiamento di apertura e attivazione che tende ad un cambiamento costruttivo, personale e al contempo socialmente condivisibile. L’uomo che egli diventa si dispiega nel progredire dalla compiacenza ad una sempre maggiore autenticità.
L’incontro con Lucien: “arte” della psicoanalisi e attivazione psicoterapeutica
La vita è fatta di paradossi nei quali, talvolta, si nasconde la verità. Chi l’avrebbe detto che proprio Lucien, che conosciamo per la prima volta in Les 400 coups come l’amante di Gilberte, sarebbe stato il volano del cambiamento di Antoine? Quest’ultimo lo definisce “L’amante numero 1” della madre, d’altronde quell’uomo aveva rappresentato proprio un nemico numero 1 per Doinel adolescente, bambino trascurato e arrabbiato, alle prese con il rifiuto materno e con l’assenza paterna.
In L’amour en fuite ritroviamo questo personaggio, Antoine lo ritrova, guarda a lui con nuovi occhi. Questo incontro interviene in un cambiamento già parzialmente in atto, segnando un momento cruciale, di svolta esistenziale per il nostro protagonista, in quanto gli consente di ri-conoscere sua madre (e di perdonarla), di ricucire ferite e ricomporre fratture che fino ad allora, avendo generato una copertura difensiva, lo avevano reso scisso e alienato, impedendo l’autentica espressione e realizzazione di sé. Da questo momento, Antoine può ri-conoscere se stesso, scoprirsi integro e integrato, nonostante una storia da riscrivere; guardare in se stesso, superando i limiti di un narcisismo difensivo e patologico, gli consente di accettare la propria fragile umanità, e di prendersi cura della propria vita autentica, del proprio essere. “Il narcisismo pone la persona nella modalità dell’avere e la rende facilmente vulnerabile, poiché ciò che si ha si può perdere, suscettibile ed esposta a sentimenti di rancore. L’odio nasce dal narcisismo ferito. (…) Al contrario l’essere io, che è esercizio di vitalità e generatività, sottrae dal rischio di perdere l’identità, che non è alienata in cose ma persistente nella sua stessa esperienza” (Biancoli, 1986).
L’incontro tra Lucien e Antoine è un “confronto vivente” (ibidem), che, nel rispetto dell’interezza dell’altro essere, consente di fare propria la prospettiva altrui. Lucien com-prende il bisogno e desiderio di verità di Antoine, e quest’ultimo ha modo, a sua volta, di com-prendere, la madre e quell’uomo più o meno sconosciuto (che ha amata sua madre sino alla fine dei suoi giorni), come anche se stesso. L’empatia di cui Antoine si mostra, forse per la prima volta, capace, è il risultato e, al contempo, la chiave del suo cambiamento.
Proprio come accade in psicoterapia. Una vera e propria arte, volta non all’adattamento sociale, quanto alla cura dell’anima. Atto creativo. Nell’hic et nunc di questo confronto non mancano resistenze, regressione e transfert, ma è la restituzione che chiama in causa il protagonista nel ruolo attivo di chi prende in mano le redini della sua vita, cosicché la presa di coscienza possa accompagnarsi al salto nell’azione, al cambiamento nel modo pratico di vita.
Lucien, analogamente alla figura del terapeuta, non si limita a fungere da specchio, bensì si mette a disposizione offrendo un rapporto stabile e ponendosi come presenza empaticamente partecipante, come reale e vera figura di riferimento, che sostiene ma non si sostituisce né si impone (ad esempio con interpretazioni selvagge). Egli è un essere umano capace di dedizione e di “prendersi cura” (rimane fino alla fine accanto alla sua Gilberte, morta all’età di 47 anni), esempio di chi sa amare produttivamente. “Il paziente può cogliere la propria interezza quando vede l’esempio dell’interezza del terapeuta. (…) Non le parole del terapeuta infondono coraggio ma il suo proprio coraggio” (ibidem).
Secondo Fromm la conoscenza sperimentata in analisi trascende quella puramente intellettuale, in quanto nel processo psicoterapeutico è possibile il rinvenire di quel volto originario, base dell’identità della persona: il paziente può riconoscere elementi della sua identità e distinguerli da quelli di pseudoidentità, insomma riconoscere il vero sé, scoprendo in esso la libertà di essere umano.
Il cambiamento di Antoine, che trova una spinta decisiva nell’incontro “terapeutico” con Lucien, è analogo a quello a cui tende la psicoterapia, che “può condurre a una triangolazione interiore dei rapporti col padre e colla madre, dove l’autoritarismo e la fissazione incestuosa lascino il posto all’intimo dibattito tra coscienza paterna e coscienza materna della persona, che è divenuta padre e madre di se stessa. La contraddizione rimane, ma non più fissata a vecchie controversie familiari, bensì come permanente tensione insita nella natura umana tra senso del dovere derivante dalla propria socialità e senso di amorevole accettazione di sé proveniente dalla vita stessa e permanente in essa anche se il dovere non venga adempiuto” (Biancoli, 1986)[4].
Il ciclo Antoine Doinel ben viene a rappresentare la “situazione umana” (Fromm, 1947), costellata di dicotomie esistenziali e potenzialmente pro-tesa. Il protagonista non è l’uomo “colpevole” freudiano, lacerato dal senso di colpa per desideri proibiti, bensì un uomo terreno, che soffre di alienazione e insoddisfazione cronica, ma, al contempo, si impegna in una ricerca attiva di senso e verità che sostanzia il suo percorso di autorealizzazione. Sceglie di superare il passato, pur senza aggirarlo (arriverà infatti a raccontarlo nel suo romanzo autobiografico), di ri-conoscere la propria storia per cambiarne il corso, Doinel, che vive l’hic et nunc gestativo (Fromm, 1976) come artefice del proprio destino.
Fromm scrive: “l’etica umanistica prende la posizione che se l’uomo è vivo, sa che cosa è permesso; ed essere vivi significa essere produttivi, non impiegare le proprie capacità per nessuna finalità che trascenda l’uomo, bensì per se stessi, dar senso alla propria esistenza, essere umani. Finché c’è chi ritiene che il suo ideale e la sua finalità sono posti al di fuori di lui, vale a dire al di sopra delle nuvole, nel passato o nel futuro, uscirà da se stesso e cercherà adempimento dove non lo potrà trovare. Cercherà soluzioni e risposte in qualsiasi punto salvo che dove potrebbe rinvenirle: in se stesso” (1947).
Alla fine scopriamo, con lo stesso Antoine, che quando troviamo noi stessi, riconoscendo e accettando la nostra parte più autentica, possiamo incontrare davvero gli altri: smettiamo allora di ricercare la chimera dell’assoluta felicità e possiamo ‘semplicemente’ essere, essere umani.
[1] All’epoca neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, membro della Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique, redattore capo della Rivista Le divan familial, segretario generale e tesoriere dell’Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille.
[2] Jean Narboni e Serge Toubiana (a cura di) (1988). Il piacere degli occhi / François Truffaut. (Trad. It. Melania Biancat). Marsilio, Venezia.
[3] Citato in Marcelli D., Braconnier A. (1983). Adolescenza e psicopatologia. Masson, Milano, 2006 (sesta edizione italiana).
[4] Cita Fromm E. (1955). Psicoanalisi della società contemporanea.
 La pubblicazione, presso Adelphi, degli ultimi versi di Zbigniew Herbert (1924-1998), L’epilogo della tempesta, in un volume che raccoglie i testi poetici scritti tra il 1990 e il 1998, anno di morte dell’autore, con l’aggiunta di testi sparsi scritti tra il 1950 e gli ultimi anni, rende ragione a questo autore, attraverso «una poesia definita classica e intellettuale, ma permeata di quel romanticismo polacco che imponeva un modello di scrittore impegnato nella storia, poeta dell’oscura sofferenza esistenziale e bardo dell’opposizione nella Polonia di Solidarnosc […]» (Francesca Fornari, Postfazione, p. 173).
La pubblicazione, presso Adelphi, degli ultimi versi di Zbigniew Herbert (1924-1998), L’epilogo della tempesta, in un volume che raccoglie i testi poetici scritti tra il 1990 e il 1998, anno di morte dell’autore, con l’aggiunta di testi sparsi scritti tra il 1950 e gli ultimi anni, rende ragione a questo autore, attraverso «una poesia definita classica e intellettuale, ma permeata di quel romanticismo polacco che imponeva un modello di scrittore impegnato nella storia, poeta dell’oscura sofferenza esistenziale e bardo dell’opposizione nella Polonia di Solidarnosc […]» (Francesca Fornari, Postfazione, p. 173). HERBERT Z., L’epilogo della tempesta. Poesie 1990-1998 e altri versi inediti, a cura di Francesca Fornari, Adelphi, Milano 2016, pp. 180, Euro 20.
HERBERT Z., L’epilogo della tempesta. Poesie 1990-1998 e altri versi inediti, a cura di Francesca Fornari, Adelphi, Milano 2016, pp. 180, Euro 20.