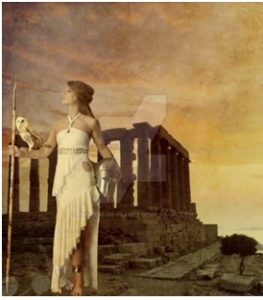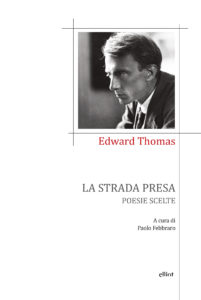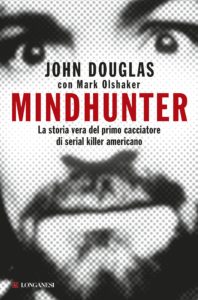di Andrea Galgano 22 marzo 2018
leggi in pdf LE RIFRAZIONI DI ELIO PECORA
 Il nuovo lavoro di Elio Pecora (1936), Rifrazioni[1], appena edito da Mondadori, restituisce un assorbimento originario e uno stupore frammentato di splendore che afferma la cristallinità umbratile e lucida di un movimento di memoria, adesione al presente, scena cromatica.
Il nuovo lavoro di Elio Pecora (1936), Rifrazioni[1], appena edito da Mondadori, restituisce un assorbimento originario e uno stupore frammentato di splendore che afferma la cristallinità umbratile e lucida di un movimento di memoria, adesione al presente, scena cromatica.
Attraverso i lembi dell’essere, è nell’ombra[2] che si situa la parola incrunata, l’attesa azzardata, l’esplosione di colori nudi, la voce che ansima, come l’istante racchiuso nelle palpebre chiuse, nella lampada accesa fino all’alba, nella corrispondenza dei nomi.
L’esergo che apre il testo è del grande poeta esule Josif Brodskij. Un debito, un’apertura, una fessura riflessa: «Che funzione abbia la poesia davvero non lo so. È semplicemente, per così dire, il modo in cui per te la luce o il buio si rifrangono».
Questo passaggio è lo sbocco che intitola un gesto di origine, nato nel reale e nel reale custodito. Attraverso la densità profonda, Pecora attinge il repertorio luminoso dell’attesa, del silenzio incontaminato e dell’ultimità munifica dell’essere: «E tutto sarebbe perduto se dal cuore chiuso / non affiorasse inattesa una nube violetta, / l’odore di un cibo, una voce al telefono, / il libro lasciato sul tavolo ancora da leggere. / Così il mondo intero si popola di storie concluse, / di passaggi, di soste, e un dio munifico / disegna nel cielo vasto e chiaro un arcobaleno».
Vediamo la pienezza dei brandelli, occhi, passi, vigilanze, abbandoni invigilati, ombre scalzate dalla memoria, vicinanze interrotte: queste sono le rifrazioni, le incidenze, le deviazioni luminose di una grazia screpolata. L’ombra tesse la sua diacronia, il suo silenzio, l’attimo aggrappato alla necessaria incorporazione della bellezza:
«Dice che se un quarto è soltanto luce / e la verità iniziale, se ce n’è una, va cercata / nel buio: che poi è il niente non più niente… / Dice che se così poco ha finora compreso / e in quel poco nemmeno può più giovarsi del nulla… / Dice, e insiste a dire, che sente di galleggiare / in uno spazio intoccato e pure continua / ad avere fame e sete e non desiste la paura / del soffrire. E ancora s’innamora di un fiore, / del profilo minuto dell’adolescente / che gli siede a fianco nell’autobus affollato, / e ancora guarda estatico la luna sui giardini, / lo inebria la pioggia scrosciante sui tigli. / Dice che il vuoto, il niente, il buio / – quelli sui quali vanno indagando nello sprofondo / e da minaccia sono divenuti un’immensa promessa – / sa di portarseli dentro, cosmi e particole, / e di esserne traversato e abitato / mentre li abita e li traversa».
La consegna relazionale delle immagini addensa una complementarità contrastante. L’intima relazione tra luce ed ombra costituisce il senso, il conflitto, il contrasto intenso, il lato origliato di splendore, come il solco di una terra scura che ritorna al lampo della sua origine, che annaspa nel fango occhieggiando le stelle: «Dove sono finiti i giorni, le ore, / quando, chiuso in un solco di terra scura, / attese parole, sillabe, giri di frase / che finalmente significassero / la consegna inspiegabilmente promessa? / È smisurato il silenzio che succede al rumore, / è il niente, il vuoto privo di voci di echi, / e, se prima è la paura e l’orrore, dopo / è l’incognita di una nuova salute».
L’osservazione di Pecora, dunque, prepara al viaggio nell’ombra, al fondo del rumore, al colloquio dell’arsi della parola che fa vedere scorci minimi e zone finissime che scandagliano, proteggono, assillano l’anima dolorosa e splendente delle cose, la manifestazione del tempo, la soglia tattile degli antri come degli accordi emersi, come da un’eternità immisurabile o un’attitudine di meraviglia:
«Sa che se molto accade nella sua mente / – un gioco misto a paura, idee a cento watt / e infervorati scandagli – molto, ma molto di più / accade di fuori, in quel che chiama mondo / ed è un immenso rimescolio di crescite, / sparizioni, feste, ruberie, delitti, progetti, prospetti, / rovine e tanto altro. E sopra e intorno / e sotto cieli ruotanti, vuoti da perlustrare, / spaventose minacce, strepitose promesse. / E lui qui, vestito del suo poco, rinchiuso / nei suoi sonni che sognano. È questo / il tempo in cui passa, l’ora in cui sosta […]».
Adriano Napoli afferma:
«Poesia è osservare il tempo nell’assenza di ciò che continuiamo a vedere: nella memoria, nel nome che ci chiama da una distanza, nelle ore perdute, colme di redenzione. Guardare il tempo è in fondo una metamorfosi. Per questo l’immagine del giardino che ci accoglie fin dalla soglia di questo libro screziato di colori e umori, persuadendoci con sensazioni tattili (quasi una fisica della percezione, antidoto alle astrazioni incolori dell’impoetico modernariato attuale), ci appare come l’emblema materico di una realtà che si avvera tutt’intorno nel suo incessante fluire, nell’attimo del suo trascorrere che è al contempo forma, manifestazione – l’unica possibile – dell’Eterno. Il giardino è l’angolo in sé conchiuso, non dissimile dalla coscienza umana, da cui guardiamo immobili (con Pitagora e con Proust; con Ovidio e Bergson) la forma esatta ed effimera delle cose trascorrere, rifrangendosi, in un altrove. E la poesia stessa, altro non è che questo incanto, tenero e malinconico, di sentire il tempo, da un angolo silente e ombroso («quel che chiamiamo Sublime / sta nell’ombra»), da un’ansa della coscienza esposta ad esso, fino a percepirne (come ci ricorda in un bellissimo saggio Pietro Citati) la liquidità».[3]
Attraverso la proiezione, la ricognizione, la scissione e l’identificazione, il gesto del magma poetico frequenta ogni volto o parola che si immerga nel reale e ne viene toccato: dal dolore, dalla morte, dall’assenza, dalla allegria del respiro, dal buio dello specchio e dalle chiamate delle vicinanze.
La poesia ricerca i frammenti per rinnovarli e avvertire il segno del mondo, la sua crittografia e la sua contrazione. Ma il mondo del poeta non è un cosmo di frantumi, poichè lo sguardo pienamente umano vigila la densità dell’istante, per vivere la compiutezza intera di ogni tensione, come pagina leggera in un pugno o specchio accordato di lunghezze epifaniche.
L’oralità trepida sfiora l’inattendibilità di ogni richiamo e abisso, come urgenza, innanzitutto, e poi come confronto instancabile con l’esistenza e la poliedrica nudità di ogni forma («Al crepuscolo la luce è uniforme, / ogni cosa si mostra nella sua nudità. / Ma che resta all’uomo del suo crepuscolo: / che del suo entrare nella vita, / che del suo uscire nella morte?»): «L’ora è ferma e lucente, un pigolio / si spande fra i castagni e gli ulivi; / al desiderio basta il desiderio / di una felicità solo sfiorata».
La sparizione delle cose, innervate nel loro limite buio e luminoso, confrontate nel passato perduto e nelle soglie dei ritorni, non è, quindi, un enigma rovesciato, o una annichilente rapsodia inconsistente, è pausa del tempo, che, nella poesia, trova il suo ritmo di lingua e di relazione e di appartenenza. In definitiva, la sua luce ultima e verbale riconosce e mostra tutto il suo vigore stremato che non si nasconde, bensì si offre, porge il suo ordinario mistero del vivente che risillaba ogni speranza, nonostante l’ora precipiti, mentre corre un altro tempo in questo tempo («è l’ansa dove il sogno della mente / non conosce durata, / la parola che tenta se stessa / esatta, svelata»):
«V’è un’ora della notte quando il sonno, che fino allora / ha retto il suo oscuro governo, d’improvviso si squarcia / nella veglia. Subito, uno dietro l’altro, come torme / di cani affamati si presentano i pensieri più cupi, / le minacce più funeste. E ogni ardire si sfalda. / Del passato non resta nemmeno una stilla di bene, / non v’è rimedio al peggio che spinge da ogni parte: / cova in ogni parola, si nasconde dietro ogni faccia. E solo / se riesci a trovare la forza di accendere la lampada, / di tornare alla pagina del libro lasciato prima / che il sonno t’avvolgesse, solo allora arriverai / a risillabare la speranza. (Trapela dalle imposte / socchiuse la prima luce dell’alba, livida, incerta.)».
È il tempo della scrittura arresa, il sogno vivo e riflesso, come se tutto possa essere placato, i segni smisurati, l’attesa amante che ritorna, il pianto che punge gli occhi, le torme e il grido che scorge l’abisso chiaroscurale e i cumuli delle ombre e «sa che da questi verrà un frutto, un fiore, / una foglia minuscola. Sa pure / che la parola non è più di un cenno, un avvio / per un altrove nemmeno ancora intravisto».
C’è nella poesia di Pecora questa tensione sorgiva per la parola emersa, non sottratta e rifratta, appunto, nelle categorie dell’anima, che rimandano a una appartenenza unica e, a volte, infeltrita dal rumore taciturno ed esploso che strappa, incaglia, arreca discordanza.
Come se essa dovesse risalire dalla nostalgia, dalla memoria confusa, dal bagliore dentro l’addio, e dal legame di conquista e perdita, si fa giardino concluso che non nutre disfacimenti e oblio nella sua luce striata di ombre.
Come una testarda voglia di restare attraversa l’amore, il vento tenue della gioia e le incrinature dei sogni:
«È solo un recinto il giardino / di verdi che svariano, / e i bianchi e gli azzurri degli ibischi, / il rosso tenero dei lillà, / le dalie gialle e amaranto… / E un tempo senza ore, / una luce striata di ombre. / Solo un recinto il giardino / dove il cuore e la mente si alleano / in una chiusa dimenticanza. / Qui è intero lo stare, / un punto di tutto, / la grana taciuta di una voce / che non si conosce».
Nella dimensione onirica, poi, tutta la lava delle impressioni e delle percezioni, così come il fiato delle parole slegate e delle veglie, tornano in un cenno di spazi, in una figuratività sconosciuta o forse confusa, ma sempre generativa nei suoi luoghi anteriori (come il testo dedicato a Roberto Deidier) e nei crepuscoli venati.
La scena del testo riporta ancora l’affresco dell’ombra. Ne Lo spessore dell’ombra, sezione decisiva e importante del libro, dove gli addii agli amici divengono la dimora della parte oscura. Amano frequentare l’Ombra ma allo stesso tempo riemergono in un incontro vivo. Essi «svariano nel giardino d’estate», si mostrano nella sospensione e nella luce che declina.
Tornano vivi in un assedio, avanzano come sommessi nel loro passo e nel loro respiro, come sponde di sogno o scaglie lacerate, «un’ansa, uno specchio nel tempo immisurabile», perché l’aria è piena di anime in una città senza nome: il padre Arsenio, andato per mare, la madre Elena («le labbra carminio, il bracciale di perle e smalto, / il sorriso trattenuto di chi ha vinto») e la sorella di lei Maddalena, il fratello Osvaldo, raccolto nella stupefazione o le care figure, attinte nella dimensione familiare e della sua terra, gli amici poeti Luciano Erba, che tra le ombre parla incagliando e ride del suo nome lucente, e Dario Bellezza («Non fu facile soprattutto / per quel suo dio truce e vendicativo / che minacciava gli inferni al fanciullo / incantato dalle parole e invaghito / da un bene colmo, eccessivo»).
E poi ancora Elsa Morante, «la manichea dagli occhi di agata / l’aspra dispensatrice di sentenze, / l’amica tenera che poteva mutarsi / nella più spietata nemica, / e nemmeno la padrona irridente / la serva che storpiava i cognomi / del manipolo curvo dei fedeli», Aldo Palazzeschi in una danza chiara di parole, Amelia Rosselli nella sua musica incomparabile di incagli, cieli segreti e farfuglii, Elsa de Giorgi, Alberto Moravia nella sua energia raggrumata, Juan Rodolfo Wilcock, Francesca Sanvitale e infine il pianto interrotto di Sandro Penna che splende nell’allegria dell’essere.
Nell’interno della sua estensione poetica, il recinto diviene sia la forma di un riconoscimento dettagliato e sia una appropriazione di alito disparso. L’appropriazione è una custodia e una sottrazione, uno svolgimento di ferite che cerca un nuovo gemito di sicurezza e un atto smisurato verso la totalità, nella strenua ricerca di un approdo oltre il vuoto, la domanda dischiusa, il labirinto dei suoi mostri e il suo lutto:
«Qui conoscemmo l’amore e le sue disfatte, / amico che torni a chiamarmi, è quieta la voce, / da chi sa quali distanze, e ancora domanda / se il bene fu rimanere nel cerchio che stringe, / se il canto fu solo un motivo fiacco, stonato. / Pure la sola durata è in questa luce scarna / che al dolore resiste, anche dove più fortemente / colpisce e infetta (meno grave la resa), / invece prosegui incontro a un altro mattino, / ancora aprile, ancora un febbraio di vento: / una fatica e un’ebbrezza fin dentro la norma / di questo restare, fin dentro il lutto e l’assenza. / Prima il teatro sublime del tramonto viola / – geometrie di continuo composte e scancellate / ora con strida infernali l’inarrestabile orda / di storni va occupando ogni ramo, ogni foglia: / i platani hanno radici che spaccano l’asfalto».
Ecco la genesi della sua architettura, della sua resistenza e della sua preghiera. L’osservazione del mondo è la rifrazione. Aspettare che le cose si rivelano e si disseminino, quando la luna falcata sui terrazzi porterà l’esagerata destinazione del desiderio e del supremo registro dell’anima. Tutta la vastità della vita, nella meta dei dettagli e nei processi di conoscenza, si situa in questa urgenza che lega passato e presente:
«C’è un momento la notte, / subito avanti l’alba, / quando, spente le luci, / ogni forma dispare: / è la città che sogna / il suo sogno iniziale, / l’aratro traccia il solco / della rifondazione: / gli storni fra le nubi / disegnano promesse, / boschi dovunque e selve, / tutto è da cominciare. / È un momento. L’aurora / dei centomila watt / risolleva il sipario / sull’immenso teatro. / Lo spettacolo ha inizio, / va crescendo il rumore, / una folla in cammino / si trova, si disperde».
La tessitura di questa poesia si compone di tracce vissute e di materia viva che diviene, a sua volta, densità lessicale, fisicità di nomi, metafora chiara. Non c’è esibizione di nomi, bensì piuttosto un canto assimilato alla vita e alla morte, come un territorio che ritrae la testimonianza di un canto accostato al mondo, in attesa di una parola che strappi un sì, che non si mutili, e che si pronunci in modo chiaro e definitivo.
[1] Pecora E., Rifrazioni, Mondadori, Milano 2018.
[2] Mauri P., Il destino di ogni poeta è l’elogio dell’ombra, in “La Repubblica”, 21 febbraio 2018.
[3] Napoli A., «Rifrazioni» di Elio Pecora, (https://www.sololibri.net/Rifrazioni-Elio-Pecora.html), 20 marzo 2018.
 Pecora E., Rifrazioni, Mondadori, Milano 2018, pp. 147, Euro 18.
Pecora E., Rifrazioni, Mondadori, Milano 2018, pp. 147, Euro 18.
Pecora E., Rifrazioni, Mondadori, Milano 2018.
Mauri P., Il destino di ogni poeta è l’elogio dell’ombra, in “La Repubblica”, 21 febbraio 2018.
Napoli A., «Rifrazioni» di Elio Pecora, (https://www.sololibri.net/Rifrazioni-Elio-Pecora.html), 20 marzo 2018.