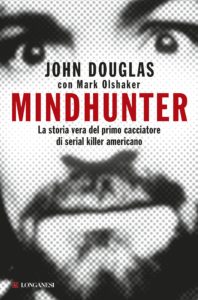di Irene Battaglini 28 novembre 2017
leggi in pdf Mindhunter. Il viaggio dentro la mente che mente di J. Douglas
 A tutta prima, anche intuitivamente, Mindhunter sembra essere il titolo riuscito compendio di un viaggio nella mente dell’assassino seriale, sia che si alluda alla fortunata serie prodotta da Netflix,[i] sia che si tratti della bella edizione di Longanesi[ii] firmata da John Douglas,[iii] – americano doc fondatore nel 1980 dell’Unità Investigativa di supporto all’FBI antesignano del primo programma di Criminal Profiling e autore del CCM,[iv] il primo manuale di classificazione diagnostica di Criminologia – con la collaborazione di Mark Olshaker, scrittore e produttore pluripremiato. Il sodalizio tra Douglas e Olshaker ha prodotto lavori pregevoli, ispirati a fatti di cronaca e delitti irrisolti, a personaggi noti per i propri crimini e a problemi legati alla colpevolezza e all’intenzionalità.[v]
A tutta prima, anche intuitivamente, Mindhunter sembra essere il titolo riuscito compendio di un viaggio nella mente dell’assassino seriale, sia che si alluda alla fortunata serie prodotta da Netflix,[i] sia che si tratti della bella edizione di Longanesi[ii] firmata da John Douglas,[iii] – americano doc fondatore nel 1980 dell’Unità Investigativa di supporto all’FBI antesignano del primo programma di Criminal Profiling e autore del CCM,[iv] il primo manuale di classificazione diagnostica di Criminologia – con la collaborazione di Mark Olshaker, scrittore e produttore pluripremiato. Il sodalizio tra Douglas e Olshaker ha prodotto lavori pregevoli, ispirati a fatti di cronaca e delitti irrisolti, a personaggi noti per i propri crimini e a problemi legati alla colpevolezza e all’intenzionalità.[v]
Mindhunter significa “cacciatore della mente”, o meglio “cacciatore di menti”. Una sorta di risposta speculare alla forma mentis del serial killer, che per Douglas non funziona diversamente, alla base, da quella del predatore per eccellenza, il leone. Così recita l’incipit di Mindhunter:
«Mettetevi nei panni del cacciatore. Pensate a un documentario sulla natura: un leone nella pianura del Serengeti, in Africa. La belva avvista un branco di antilopi all’abbeverata e in qualche modo glielo leggiamo negli occhi: ne sceglie una fra migliaia. Questo, perché è allenato a percepire la debolezza, la vulnerabilità, la diversità dell’antilope in cui riconosce la vittima ideale. Alcune persone si comportano allo stesso modo. E se appartengo a quella cerchia, anch’io vado a caccia tutti i giorni, in cerca della mia vittima. […] È l’eccitazione della caccia che spinge questi individui all’azione. Un’eccitazione, credo, paragonabile a quella del leone nella savana. E poco importa se la loro predilezione va ai bambini, alle donne, alle prostitute o ai membri di qualsiasi altra categoria, oppure se cacciano in maniera indiscriminata. Per certi versi, sono tutti uguali».[vi]
Fin dalle primissime frasi, il lettore riesce a “pensare” senza fatica dal punto di vista di John Douglas, e a subire, inconsapevolmente, un primo influenzamento iniziando a “ragionare” in termini di predatore e preda, di vittima e carnefice, in una sorta di gioco “stimolo-risposta” carico di infinite complessità, rinforzi e varianti sul tema. Tuttavia, la psicologia dinamica fa continuamente da sfondo al tessuto narrativo, poiché sono tanti i riferimenti alla transgenerazionalità del trauma, alle implicazioni diagnostiche in psichiatria, alle teorie delle personalità.
A far da contraltare a questo ordito, sta una trama che rimanda continuamente ai problemi dell’irrecuperabilità del reo, della condannabilità e della capacità di intendere e volere, delle procedure giudiziarie americane. Già nel 1914 lo psicoanalista ungherese Sandor Ferenczi scriveva:
«Io ritengo che attualmente sia possibile sottomettere sistematicamente i criminali a un’investigazione psicoanalitica, purché, naturalmente, l’esaminatore sia perfettamente padrone del materiale scientifico relativo e della tecnica psicoanalitica. Un simile compito è essenzialmente di pertinenza dei medici addetti ai tribunali, ma anche dei giudici, dei procuratori e degli avvocati con una formazione psicologica. Uno studio più approfondito della psicologia del “senso della giustizia” comporterà la riforma del sistema penale. Quando i fattori passionali (desiderio di vendetta o indignazione provata di fronte a una violazione della legge) saranno stati eliminati dalle motivazioni ispiratrici della punizione, anche le diverse pene saranno più adeguate al loro scopo, cioè tenderanno esclusivamente a proteggere la società e a “emendare” il colpevole».[vii]
Per catturare un serial killer bisogna entrare nella sua mente, capire i suoi pensieri, i suoi ragionamenti e prevenire le sue mosse. È proprio questo l’obiettivo esplicito dell’agente del FBI John Douglas. Il “saggio”, distribuito in 20 capitoli, leggibili anche in modalità random e non necessariamente nell’ordine proposto, si incentra sugli interrogatori che Douglas ha intrattenuto con numerosi criminali (principalmente assassini e stupratori seriali), compiuti al fine di “entrare nella mente di un serial killer”.
La domanda incessante, che fa da filo rosso a tutto il saggio di Douglas (che esce per la prima volta in America nel 1995 con il titolo Mindhunter: Inside the FBI’s elite serial crime unit per Scribner di New York), è apparentemente quella di individuare i processi che governano il comportamento di un assassino, cosa lo spinge a compiere un’azione tanto grave quanto violenta, e spesso in modo reiterato e compulsivo.
Quella del leone e dell’antilope, tuttavia, non è soltanto una metafora. Più verosimilmente potremmo definirla un’allegoria, poiché se la metafora rappresenta una dinamica che è trasferibile da un dominio semantico ad un altro, l’allegoria [dal lat. tardo allegorĭa, gr. ἀλληγορία, comp. di ἄλλος «altro» e tema di ἀγορεύω «parlare»] affida ad una raffigurazione a più livelli e ricca di implicazioni un senso riposto e allusivo, diverso da quello che è il contenuto logico delle parole, e necessita di essere interpretata diversamente dal suo livello “apparente”.
Il significato nascosto in questo caso non sta tanto nella dinamica di dominio e sottomissione che lega intrinsecamente il predatore alla sua vittima, quanto nella dialettica che lega l’Ideale dell’Io del Criminal Profiler (in cui si addensano le aspettative individuali e istituzionali in una sorta di viaggio eroico nelle fauci di creature infernali condannate a non essere mai più integrate nella vita sociale) al Super-Io, compromesso e frammentato – o qualche volta del tutto eclissato –, del Serial Killer, che si costringe in una sorta di violenza autoinflitta ad identificarsi – intrudendosi, seminando fallacie comunicative – nella mente dell’investigatore per tentare di opacizzarne la visione, cucendosi addosso il pentimento o un ravvedimento, come una falsa veste che possa garantirgli una libertà condizionale o qualche altro vantaggio agli occhi della macchina della giustizia.
A tenerli legati in una sorta di “bondage” relazionale è una sfida in continuo rialzo, alla ricerca di quell’angolo cieco e vulnerabile della mente dell’altro ma soprattutto ad eludere l’inciampo in una falla nella storia dell’assassino, che permetta di risolvere quella che diversamente appare come una sciarada di inestinguibile mistero: il tentativo, potremmo dire, di dare un senso, di attribuire una logica razionale a qualche cosa che diversamente risulterebbe essere la messa in atto di una modalità perversa di stare al mondo. E questo modo necrofilico di essere nel mondo, potrebbe risultare molto più angosciante, perché inspiegabile, perché votato all’idea di male come opzione fondamentale, rispetto ad una forma perversa di reagire a qualche cosa di traumatico e di atroce che è intervenuto nella prima infanzia del “soggetto ignoto”, che si trasforma a propria volta in vittima – del genitore violento, del destino persecutorio o di un danno al sistema nervoso –, aprendo quindi un qualche spazio controtransferale.
Non si tratta quindi “soltanto” di individuare, attraverso gli interrogatori, i processi che si trovano alla base del comportamento adottato dai criminali interrogati da Douglas, non solo di far emergere il conflitto primario e isolare il tratto perverso narcisistico che modella tutti i loro pensieri, ma di far luce sulla loro natura attraverso una osservazione del loro comportamento, come se si trattasse quasi di una sfida antropometrica. Che “tipo” di uomo si nasconde dietro il serial killer? Prosegue Douglas:
«Ma è ciò in cui divergono [i serial killer], ossia le tracce delle rispettive personalità, a fornirci una nuova arma per l’interpretazione di certe tipologie di crimini violenti e delle modalità di caccia e di esecuzione dei loro autori. Ho passato buona parte della mia carriera di agente speciale dell’FBI a cercare di potenziare quest’arma, e proprio questo è l’argomento del libro. Sempre, davanti a un crimine orrendo, si pone l’interrogativo assillante, fondamentale: che genere di persona può aver commesso una simile azione? Il lavoro di analisi che svolgiamo noi dell’Unità investigativa di supporto si propone appunto di dare una risposta a questa domanda. Il comportamento riflette la personalità».[viii]
Nei suoi interrogatori Douglas individua anche la capacità che hanno i criminali di distorcere la realtà; nel loro isolamento all’interno delle prigioni, gli individui presi in esame dall’agente erano stati in grado di elaborare risposte alternative a ciò che era veramente successo, risultando (solo nelle parole) innocenti accusati ingiustamente. È una caratteristica che Douglas riscontra spesso durante i suoi incontri, la capacità di mentire e di distorcere la realtà attraverso “la fantasia”. Sostiene il sociologo e psicoanalista tedesco Erich Fromm:
«Dunque, l’uomo si differenzia dagli animali perché è assassino; è l’unico primate che uccida e torturi membri della propria specie senza motivo, né biologico né economico, traendone soddisfazione. È proprio questa aggressione «maligna», biologicamente non-adattiva e non- programmata filogeneticamente, che costituisce il vero problema e il pericolo per l’esistenza dell’uomo come specie. […] La distinzione fra aggressione benigno-difensiva e maligno-distruttiva richiede un’ulteriore, più fondamentale distinzione: quella fra “istinto” e “carattere”, o, più precisamente, fra pulsioni radicate nelle esigenze fisiologiche (pulsioni organiche) e quelle passioni specificamente umane che affondano le radici nel carattere («radicate-nel-carattere o umane»). […] Gli uomini si distinguono fra di loro proprio rispetto alle passioni che li dominano. Per fare un esempio: l’uomo può essere guidato dall’amore o dalla passione di distruggere: in ciascun caso soddisfa uno dei suoi bisogni esistenziali: l’esigenza di «realizzare», o di muovere qualcosa, di «lasciare una impronta». Che la passione dominante dell’uomo sia l’amore o la distruttività, dipende in gran parte dalle circostanze sociali: queste circostanze, in ogni caso, operano in riferimento alla situazione esistenziale dell’uomo, data biologicamente, con le esigenze che ne derivano, e non a una psiche infinitamente malleabile, indifferenziata, come presume la teoria ambientalistica».[ix]
Se il comportamento riflette la personalità, l’approccio che Douglas utilizza per ogni individuo è differente, e si modifica a seconda delle informazioni di personalità che si riescono a ricavare; l’agente oscilla tra le polarità del “poliziotto buono” e del “poliziotto cattivo”, al fine di spingere il criminale stesso a una identificazione proiettiva che gli permetta di fidarsi parzialmente e di far emergere le parti mancanti del mosaico del suo romanzo criminale.
Mindhunter. La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano
Longanesi, Milano: 2017, pp. 384
Euro 18,60
[i] Joe Penhall, Mindhunter, Netflix, Usa 2017 – https://www.netflix.com/it/title/80114855
[ii] John Douglas, Mark Olshaker, Mindhunter. La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano, Longanesi, Milano: 2017.
[iii] Brooklyn, NY, 1945.
[iv] John E. Douglas, Ann W. Burgess, Allen G. Burgess, and Robert K. Ressler, Crime Classification Manual. A Standard System for Investigating and Classifying Violent Crimes, Jossey-Bass, Wiley Imprint, 989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741
[v] http://mindhuntersinc.com/books/
[vi] Mindhunter, op. cit., p. 21
[vii] Sandor Ferenczi (1914), Psicoanalisi del Crimine, in Tutte le Opere, pp. 144-145, vol. II (1913-1919), Raffaello Cortina editore, Milano: 2009.
[viii] Mindhunter, op.cit., p. 22
[ix] Erich Fromm (1973), Anatomia della distruttività umana, pp. 21-22. Mondadori, Milano: 1975,