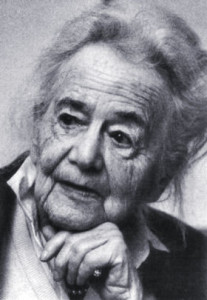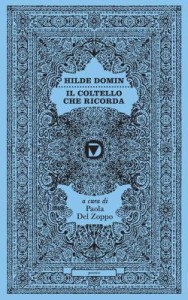di Andrea Galgano 1 giugno 2016
leggi in pdf HILDE DOMIN. IL TAGLIO DEL RICORDO IN ESILIO
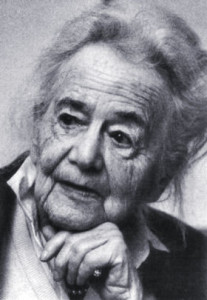 Il progetto di pubblicare l’intero corpus poetico di Hilde Domin (1909-2006) trova in Il coltello che ricorda, a cura di Paola Del Zoppo, terzo capitolo edito da Del Vecchio, una traccia, per così dire, attesa e pronunciata che raccoglie una parte delle poesie, dal 1951 al 1985, che ella stessa aveva scelto per l’intensa raccolta Gesammelte Gedichte (Poesie in raccolta) del 1987, così come le liriche di Der Baum blüht trotzdem (Eppure l’albero fiorisce) del 1999, alcuni testi sparsi e le Poesie dal lascito.
Il progetto di pubblicare l’intero corpus poetico di Hilde Domin (1909-2006) trova in Il coltello che ricorda, a cura di Paola Del Zoppo, terzo capitolo edito da Del Vecchio, una traccia, per così dire, attesa e pronunciata che raccoglie una parte delle poesie, dal 1951 al 1985, che ella stessa aveva scelto per l’intensa raccolta Gesammelte Gedichte (Poesie in raccolta) del 1987, così come le liriche di Der Baum blüht trotzdem (Eppure l’albero fiorisce) del 1999, alcuni testi sparsi e le Poesie dal lascito.
L’intensa nervatura poetica si accompagna ai saggi e alle interviste (Libertà nella scrittura), unendo l’impronta autobiografica (Vita come Odissea linguistica) alla fervorosa concentrazione di indagine e di lettura del reale (Fermare tempo e scopo – Le fasi della poesia tedesca del dopoguerra viste dal Paese e da chi vi ritornò).
Lo sguardo aperto sulle contraddizioni temporali e la ricostruzione della propria vicenda autobiografica, immersa nelle peregrinazioni e negli esili forzati, come il soggiorno in Italia, a Londra e nella Repubblica Dominicana, contraddistinguono la cifra della sua odissea e della sua Resistenza, dove presentare «la fuga permanente come permanente sfida linguistica» e permeare la sua scrittura nella salvazione: «Vengo riconosciuta come un essere della Resistenza, come qualcuno che nuota controcorrente, che si butta avanti ai treni in corsa, come se li potesse fermare, e che trova davvero difficile non sedersi in punta di sedia», o ancora tratteggiando la sua genesi scritturale scrive:
«Quando, dopo la morte di mia madre, di cui qui non parlerò, giunsi al limite, ecco che all’improvviso avevo la lingua che per tanto tempo mi era servita. Sapevo cosa fosse una parola. Mi liberai tramite la lingua. Se non mi fossi liberata, non sarei sopravvissuta. scrivevo poesie. Scrivevo in tedesco, ovviamente. Ma le poesie avevano appena visto la luce che le traducevo in spagnolo per vedere come reggevano in quanto testi. Per guadagnare distanza. Pubblicare, all’epoca, non era in questione. Scrivere era salvarsi».
Nella dimensione di salvazione dall’abisso e di affioramento la parola di Hilde Domin cerca la sua dimora, il nome di ciò che ospita l’identità, dove la semplicità odora di essere umano e ritorna alla lingua, e l’esilio, come afferma Anna Ruchat, «non è vissuto da Hilde Domin come un ripiegamento, bensì come una scelta che continuamente si rinnova e la riconferma come persona il cui radicamento è nella lingua, la sola cosa «permanente» nel continuo cambiamento».
Il lavoro interpretativo sulla parola è l’inizio indiziario di un approdo che sollecita la materia poetica in cui l’autrice muove i suoi passi e in cui il rapporto dialettico tra autore, testo e lettore dimostra che, come sostiene Paola Del Zoppo, «la lettura interpretativa sia di fatto in sé generatrice e non solo relatrice di verità poetica, e come il valore di una poesia non sia limitato alla comprensione dell’intenzione originaria dell’autore».
L’attimo di libertà permesso concede la sua connessione verbale e sociale. Hilde Domin scova il gesto vivente di un approdo nella lettura del tempo e delle sue connessioni sociali, nella consonanza poetica e biografica, e nella disossata verbalità espone la sua stretta ribellione e il suo vorticoso esilio, come condizione e migrazione, innanzitutto, ma soprattutto come genesi edenica espulsa che si attesta sulla lingua originaria e sul plurilinguismo acquisito.
Scrive Roberto Galaverni:
«Diversamente da altri scrittori esuli, che hanno approfondito il rapporto con la propria lingua soltanto attraverso la sua perdita, sembra che per lei il contatto più stretto, la consanguineità tra parola e cosa, tra lingua e mondo, e dunque l’esultanza per il riconoscimento della loro reciproca appartenenza, costituiscano la condizione stessa della poesia. Anche da questo punto di vista il suo percorso appare piuttosto singolare. «La gioia di poter dire liberamente quello che voglio, come voglio», afferma la Domin, «di respirare liberamente e di sentire la cadenza della lingua in concordanza con il proprio respiro, questa è una delle gioie più grandi dell’essere di nuovo a casa, per uno scrittore». La lettura dei suoi versi risulta così un’esperienza alquanto contraddittoria. Da un lato questa poesia – quanto mai lirica, non c’è che dire – colpisce per freschezza, immediatezza, evidenza, dall’altro tante volte sorprende per la semplicità, la prevedibilità delle soluzioni, scorrendo via facile facile, troppo facile».
L’immediatezza non sconfina nell’ingenuità, anzi sorprende come la sua parola debba essere pura, scolpita nella essenzialità dilagata, come misura e libertà. La scrittura diventa, quindi, il momento di verità, perché scommette, continua Galaverni, «sulla riconquista di un’alleanza tra la forma e la vita, tra l’uomo e la sua lingua».
Tale centralità, pertanto, ritorna e riconsegna la poesia al suo spazio assottigliato, «non per tornare a chiuderla in una irraggiungibile torre, ma per restituirla al lettore. […] Il lettore e il poeta, accomunati dal pericolo costante di etero direzione, di spersonalizzazione e in ultima istanza di una disumanizzazione, rischiano di ridursi a essere solo esseri umani menomati dall’immagine che se ne crea funzionalmente» (Paola Del Zoppo).
Nominare direttamente l’avvenimento della realtà significa, per Hilde Domin, ritornare all’elementare porzione delle cose, del creato, di ciò che amiamo, e significa, altresì, arrestarsi sull’attrazione umana basica davanti alla datità dell’essere e alla fraternità del Tu, alla ricostruzione di una speranza menomata e franta che diventa necessaria e imminente nella sua pausa attiva: «Meno della speranza di lui / questo è l’uomo / un solo braccio / sempre / Solo colui che è crocifisso / le braccia / spalancate / dell’Io-sono qui» (Ecce Homo).
Commenta Paola del Zoppo:
«Nel primo gruppo di versi Hilde Domin fa i conti con la realtà della natura umana nella sua realizzazione contemporanea. L’essere umano, che si rivela manchevole in due direzioni, è meno di ciò che si credeva di lui, e meno di ciò che Hilde Domin crede possa o dovrebbe essere, perché è un uomo con un solo braccio, unidimensionale. A questa rappresentazione umana fa da specchio ancor più che da contrasto, l’uomo con le braccia spalancate sulla croce, il “crocifisso”, laddove gekreuzigt è qui un aggettivo: l’intenzione di Hilde Domin non è quella di esortare all’obbedienza (richiamando la presentazione di Mosè sul Sinai), né al sacrificio di sé come speranza dell’umanità (il sacrificio di Cristo), né tantomeno, però, con l’inevitabile richiamo al testo nietzschiano, di annullare nel nichilismo una possibilità di esistenza metafisicamente orientata. L’impostazione scettica di Hilde Domin viene qui – e solo poeticamente – formulata e negata in favore di una speranza di segno maggiore. Appiattirsi su un ideale di sacrificio, sia esso anche di grande portata religiosa o antropologica quanto la rappresentazione biblica o evangelica dell’umanità, è comunque pericoloso perché comporta la riduzione della vera possibilità di umanità: «solo l’Io può essere fratello del tu». Il crocifisso è garante di questa possibilità, perché iconograficamente mostra due braccia, e dunque la facoltà di abbracciare, subordinata però alla rinuncia alla condizione di “crocifisso”, all’uscita dalla definizione di sé data dal simbolo».
La poesia lirica e la sua crisi ridestano l’attenzione della poetessa verso una capacità di connessione alla germinazione dell’Io e all’apertura verso l’Altro in tutta la sua peculiare differenziazione, volgendosi alla tensione trascendentale come intima testimonianza che vuole distogliersi dall’annullamento, e al valore della scrittura come difesa che non si piega all’istantanea di consumo per farsi impegno e lotta, rifugio e confessione come «allenamento per la vita», per usare un’espressione cara a Hans Magnus Enzensberger:
«Quando ci si sente molto oppressi, si può trovare rifugio nella lirica. La lirica permette di sfogarsi di più rispetto alla prosa. La lirica si accende come una lampadina. La lirica è costituita più da sofferenza che da gioia. L’essere umano può liberarsi attraverso la scrittura poetica. Sebbene sia ovviamente qualcosa di diverso, l’unico paragone possibile è con la confessione o con una chiacchierata con lo psicoterapeuta. Si ha la possibilità di esprimere ciò che si sta vivendo. Con la lirica si può fare ancora meglio. Io dico che è una benedizione se si può diventare creativi».
È la sua semina, il singolare barbaglio di luce che diventa oggetto fisico e nuove palpebre: «Nell’aiuola / dei miei fianchi / voglio seminare i tuoi occhi / prima che le foglie dorate / cadano e ci ricoprano. / Perché in primavera / con i narcisi e i giacinti / si schiudano le nuove palpebre».
La realtà fratturata segue la sua fascinazione perlacea, giungendo da lontano, si presentifica in una lingua di cieli e carezze scintillanti,, mietendo il cuore con il coltello che ricorda gioie ferite e stelle fidate (Un luccichio, che non si arresta, una lama / a creare un ampio arco, / falce di sole. / Lì giaccio come il prato / e sento il tuo coltello, / mietitore, / Inarrestabile e gelido, / che sutura):
«Il mare, solcato placidamente di perle / e color argento come le ali di una colomba, / giunge da lontano / fino a me e mi lecca / con minuscole onde / ancora e ancora / e non si placa / come fossi il suo cucciolo. La sua lingua morbida / sui miei occhi, / senza sosta / di fronte al cielo bianco, / mi ipnotizza / dal vetro della terrazza / con questi scintillanti carezze / finchè mi lega / con le braccia a penzoloni / alla mia sedia / e di fronte a me / resta sola / la mia macchina da scrivere».
Il focus oggettuale ed esistenziale di Domin si lega alla sua valenza prodromica che attua dinamiche basilari e nodali. L’avvenimento della parola segue all’accadere della realtà e la lirica, portata sul valore esperienziale, compone i suoi scettri emigranti ed esiliati, radicandosi in una scelta lessicale immediata, come immediato è il pronunciamento, in successione, della sostanza vivente e della caccia muta e luminosa, nella genesi depredata della morte e dell’aria assottigliata: «Già alla porta / sollevasti lo sguardo. / Ci guardammo. / Un grande fiore sbocciò / pallido e raggiante / dal mio cuore» (Già alla porta).
Paola Del Zoppo sostiene che: «Proprio tramite la messa a fuoco dei suoi contorni, la parola poetica può liberarsi e restare oggetto universale, e quindi presentarsi al lettore come slegata: è contemporaneamente oggetto pre e a-razionale, ed espressione lucida di una visione del mondo. La lirica più potente è quindi, secondo Domin, una lirica che può rivelarsi quotidiana e innalzarsi a un livello di essenzialità significativa che rende possibile la sua collocazione anche in altri e molteplici contesti».
La fusione con l’esistente, in Hilde Domin, non si risolve nell’annullamento ma rivela e disvela la superficie delle cose, la materia ricoperta dai filamenti dorati, dischiude lo splendore fradicio della sua mineralità dispersa, visitata nella festa o nell’urlo di gelsomino come luce sui seni: «Ah, vorrei uscire / e sdraiarmi sul prato / con le vene aperte / e la pioggia potente / come un treno / deve scorrermi addosso / e farmi bianca / come il letto vuoto di un fiume / o gli anemoni / sulla tomba di mia madre».
La celebrazione della realtà scopre il suo istante corposo attraverso la fuga in uno specifico equilibrio librato di macchie umide e oli rovesciati, persino la stessa sovrabbondanza grida la sua solennità tormentata e frammentata, il miracolo soffice, la prominenza dell’umano come sbocco e vertigine di significato.
Sono i suoi segnali che, come i fiori bianchi, «succhiano una scorta di sole / per la notte», aprono le ferite dilatate e amate del cuore cardinale e sottovoce combattono il superfluo. Nella distanza vergine si scoprono rose e magie, come se la parola, riempiendo ogni fessura del tempo resistente, riuscisse a essere pietra vivente, oracolo luminoso, arazzo germogliato nelle radici, e polvere di sogni: «[…] e il cuore / diventa pesante di dolcezza / come un frutto pieno di zucchero. / Dopo viene trapiantato / come semi di grano dai fossati / al solco dolorante / e la ferita viene curata con la saliva / di baci leggeri. / E il grano / una felicità morta / mette radici e germoglia. / Tutte le vene ne hanno l’odore / finchè le punte delle mie dita / sono rosee / come quelle di un bambino».
L’esigenza esistenziale di comunicazione della parola ricerca l’anticipo delle fioriture, dove denudare segreti e partecipazioni all’intimità dell’essere, dove porgere la propria vociata lingua, calligrafare l’autentico, determinare la scelta esatta del volto di ciò che c’è, determinare il perimetro del territorio del linguaggio nell’attrazione indifesa e raccolta come immagini chiarificate per una seconda nascita («Chiedo alle parole di tornare da me / attiro tutte le parole / indifese / Raccolgo le immagini / i paesaggi vengono da me / gli alberi le persone / Nulla è lontano / tutti si riuniscono / c’è tanto chiarore»), e, infine, soggiogare le lacrime nello iato insanabile di gioia e mancanza, pelle e orlo: «Le parole sono melagrane mature, / cadono al suolo / e si aprono / Tutto l’interno si volta all’esterno / il frutto denuda il suo segreto / e mostra il suo seme, / un segreto nuovo».
L’esilio domestico si realizza in finestre piene di luce per trovarsi, dar respiro al cuore nelle case, svegliare la profonda nudità dell’essere che apre il mondo, facendo terminare l’estraneità delle stagioni che scuriscono e imbiancano e le corride dei frammenti: «Le teniamo strette / queste chiavi, / viaggiamo con esse, / noi esiliati, / anche noi. / Il cuore, la tua vecchia / casa, / ha finestre piene di luce, / i volti all’interno / sono estranei. / Solo nel sogno / potresti entrare / con queste chiavi / che da sveglio / pesano così tanto nelle tue mani» (Chiavi di casa), come le strade che accumulano bellezza: «Violette orlano la strada, / occhi di fiori di fragola, / mughetti. / Il cuculo m’accompagna / di richiamo in richiamo / lungo una strada / che non è la mia. / Bordata di fiori sì / ma non la mia. / Guardando gli altri / mai mi sono chiesta / se la strada sotto i loro piedi / fosse la loro», o attraverso l’approdo proscritto che inventa la destinazione, per farsi promessa di nome eterno e “necessarietà” oltre la distruzione: «Mi sono data il nome / mi sono chiamata / con il nome di un’isola. / È il nome di una domenica / in un’isola sognata. / Colombo scoprì l’isola / una domenica di Natale. / Era una costa / a cui approdare / si può sbarcare / qui gli usignoli cantano a Natale. / Si dia il nome, disse qualcuno / quando sbarcai in Europa, / dalla sua isola» (Poter approdare).
La dinamica del nostos permea il tracciato della sua tensione attraverso riferimenti biblici, letterari e autobiografici, designando l’odissea cifrata dell’esistenza, come avviene in Nell’antro di Polifemo, in cui, «nella personalissima mitopoiesi di Domin», scrive Anna Maria Curci,
«Ulisse che fugge con i suoi compagni si affianca a Sisifo che si oppone alla coazione e ad Abele invitato a rialzarsi dopo essere stato ucciso da Caino. È la dimensione plurale della fuga che emerge chiaramente nelle tre quartine di Nell’antro di Polifemo, precedute, a loro volta, da un distico che fa invece preciso riferimento all’io lirico: «Der blinde Riese greift wieder nach mir», «Il gigante cieco torna a ghermirmi». Lo scenario torna a essere una Höhle, un antro, una caverna, una cavità – […]. Le immagini proposte attingono a quanto narrato nell’Odissea: Ulisse e i suoi compagni sono aggrappati al vello dei capi del gregge del ciclope, che, oramai accecato, ne tasta il ventre man mano che questi, varcando l’ingresso, si recano al pascolo. Il verbo «fortgehen», che ricorre, sempre nella grafia «fortgehn», per ben tre volte nella prima e nella seconda delle tre quartine, la prima volta all’infinito («Andarsene») e nelle due ricorrenze successive, in una anafora, alla terza persona plurale («se ne vanno»), lancia la fune allitterativa a «fliehen» («fuggono») e «Flucht» («fuga») della terza e conclusiva quartina. Il procedere per anafore che caratterizza tutto l’impianto ritorna anche nella conclusione della prima e della seconda delle quartine, «unter der zählenden Hand», «sotto la mano che conta». La condanna si ripete, la minaccia della coazione, come per Sisifo, incombe costantemente, la fuga è condizione permanente. Solo la coscienza di tale condizione, sembra suggerire Domin, è antidoto al soccombere, all’essere schiacciati proprio da quell’obbligo alla coazione contro il quale il “suo” Sisifo si era ribellato».
Il dolore confonde i contorni degli anni, nei giorni che gridano la loro pretesa e le loro gocce, dove solo l’ostinato ha bisogno di essere solo nell’attimo del tulipano morente, dove le porte chiuse e dischiuse accendono luci, e gli stessi occhi toccano l’attimo smisurato e rimpicciolito del cuore in viaggio su lontananze distese e germogli di silenzio, tesi all’estremo: «Eppure l’albero fiorisce / Sempre gli alberi sono fioriti / anche per l’esecuzione capitale / Fiori di ciliegio e / farfalle / il vento li trasporta / anche nel letto del / condannato / Proseguono / portatori di fioritura / senza voltare il capo / con i filari luminosi / Più d’uno ti dice una parola / oppure sei tu a credere che parli / passando / Perché c’è così tanto silenzio» (Eppure l’albero fiorisce).
È la scelta che celebra le cose, le ricorda, le inscena, traccia il solco amoroso degli orli smussati piantati nel fondo e delle perdite come chiare ombre, si abbandona alla caduta e alla forza dello splendore vagante delle quotidianità azzurre, per essere in fuga, e dissolti, da ogni vento, e dove «le voci dure / e colme dei resistenza / quando il giorno finisce / e tu dolcemente / rinunzi allo splendore».
Nella raccolta La pelle del pianeta, Hilde Domin precisa lo scorrimento lento e poroso della sua striscia di carta, come un urlo che dà forma all’umano, pretendendo l’ “impossibile” coraggio civile, conoscendo la familiarità del «con- dolore» che annulla ogni perspicace distacco, e come afferma Paola Del Zoppo,
«ci conduce attraverso tutto il suo mondo poetico strappando la pelle del pianeta che ci contiene, in una successione di fasi di riappropriazione ed esaltazione della propria umanità. […] Attraversando la Storia sul Tokaido Express, Hilde Domin rielabora poeticamente e ripiega il tempo e lo spazio per trovare una sincera relazione con se stessi nella doppia “casa” dei poeti, il cui «paese si fa sempre più grande» e accogliente. La superficie terrestre si contrae i confini si ritraggono per far sì che si va via e si rimane, perché si vive nella parola «persino in parole di diverse lingue», o per scelta ci si impegna con fatica per avere residenza nella «parola tedesca». Ma se questo ritorno diventa una chiusura, l’acquisizione di un punto di vista univoco, perde il proprio valore di apertura all’altro. L’uomo tornato al presente è parte della storia e del dolore del luogo in cui si trova, e vi deve imprimere attivamente la propria umanità, «aprendo le braccia», per abbattere un lungo di muri che inevitabilmente hanno radici nel bisogno degli esseri umani di costruire la propria identità tramite somiglianze e differenze e non nella consapevolezza profonda della propria forza individuale».
La spodestata libertà smerigliata da riempire con schegge di vetro, la chiarità della scrittura che trascina detriti e macerie ma segnando «il sempre e il comunque di ogni lettera», la nostalgia che fa scorrere la terra tra le dita e delimita il nomadismo del tempo buio raccolgono la sopravvivenza di un’orma instancabile che tiene stretta i lembi delle ferite, rammenda e strappa il fiato mai stanco della luce posteriore della storia, per abitare la parola e aggrapparvisi.
Nella sillabazione della classificazione delle mura (Classificando mura), dai disegni sui tessuti, alla muraglia cinese di porcellana, fino alle mura di Avila e quelle senza porte di Ettore e di chi è senza documenti, Hilde Domin «traccia in pochissime sillabe una linea attraverso la storia della narrazione del mito e delle religioni connotando tragicamente la figura di chi è scacciato o non accolto, per associare a essi un muro che assume i contorni dell’assurdità, il muro di Berlino, un muro tra fratelli, «ognuno dalla sua parte». La dolorosa realtà viene scarnamente presentata superando ogni possibile giustificazione simbolica o narrativa: i muri più ripidi, resistenti e lunghi sono gli invisibili muri dell’indifferenza umana muri di schiene, veri e propri Mauern aus Menschenfleisch («muri di carne umana»)» (Paola Del Zoppo).
La scarnificazione della superficie e del superfluo serve alla poetessa per entrare nel mistero del reale, proferendo il suo discorso elementare, la sua tensione inesorabile non inerte che attraversa il tempo e lo spazio per riempirli di verità e senso, la sua altalena che si alza sui fuochi che bruciano, per cadenzare la lingua in un fiato che riporta a casa.
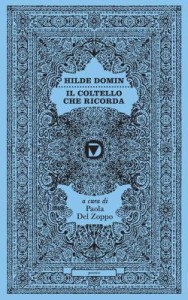 DOMIN H., Il coltello che ricorda, a cura di Paola Del Zoppo, Del Vecchio editore, Bracciano (Rm) 2016, pp.461, Euro 19.
DOMIN H., Il coltello che ricorda, a cura di Paola Del Zoppo, Del Vecchio editore, Bracciano (Rm) 2016, pp.461, Euro 19.
DOMIN H., Il coltello che ricorda, a cura di Paola Del Zoppo, Del Vecchio Editore, Bracciano (Rm) 2016.
CURCI A. M., Più scettica di Brecht, più fiduciosa di Benn: Hilde Domin (http://www.senzazuccheroblog.it/maggio-di-poesia-1-anna-maria-curci/), 5 maggio 2016.
DE MARTIN M. P., Hilde Domin: viaggio verso la parola, in «Miscellanea 3» (1996), pp. 225-230.
GALAVERNI R., La «seconda vita» di Hilde Domin, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 14 febbraio 2016.
RUCHAT A., Hilde Domin, «Il coltello». Una odissea linguistica, compagna dell’esilio, in “Alias Domenica, supplemento de Il Manifesto”, 14 febbraio 2016.
 E non si dà capolavoro d’arte. Fuor dell’opera, si è capolavoro[1]
E non si dà capolavoro d’arte. Fuor dell’opera, si è capolavoro[1]